Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini – Giorgio Boatti

SINTESI DEL LIBRO:
Dodici professori su oltre milleduecento: i numeri parlano e vengono
usati dalla propaganda del regime per stigmatizzare i renitenti e per
dimostrare il consenso raccolto, non solo tra le masse popolari ma anche nelle
élite intellettuali. I numeri parlano. Apparentemente, in quell’autunno del
1931, dicono cose definitive. Però tacciono, i numeri, sul prima. E,
ovviamente, non possono vaticinare sul dopo. Nella loro perentorietà
obbligano ad abolire sfumature, a dissipare zone d’ombra. Non tengono conto
di riserve e ambiguità, tolgono ogni visibilità ad antefatti che, pur sparsi nel
corso degli anni precedenti, hanno pesato non poco al momento della conta.
Occorre precedere la voce dei numeri. Rammentare i fatti accaduti prima che
quel giuramento fosse richiesto e che i dodici «no» cominciassero a brillare
come torce di libertà su uno sfondo - le università e le comunità di studiosi, di
docenti - precipitato, apparentemente all’improvviso, nella più cupa
penombra.
Dodici «no», si è detto. E alcuni pronunciati con innata riserva verso il
«bel gesto», con signorile diffidenza verso ogni clamore. Qualcuno, per la
verità - senza paventare l’imbarazzante frastuono del gesto esemplare - ha già
anticipato questi «no».
È Gaetano Salvemini che, sin dall’anno accademico 1923-24, ha subito
l’ostilità dei fascisti anche sul terreno della sua quotidiana attività di docente.
È appena rientrato in Italia dopo un soggiorno in Inghilterra quando monta la
campagna contro le lezioni che s’appresta a riprendere: “Non dimenticherò
mai quel giorno - scriverà una testimone a lui vicina in quegli anni fiorentini.
- Le scale, i cortili dell’Istituto pullulavano di fascisti minacciosi coi
manganelli in mano: l’aula dove Salvemini soleva tenere lezione era
incredibilmente affollata; nei primi banchi sedevano, frammisti gli studenti
del corso, colleghi suoi, studenti anziani, amici fedeli che gli volevano
attestare la sua solidarietà. Mi feci largo tra i fascisti e incontrai padre Pistelli,
nazionalista e fascista, ma estimatore del Salvemini, e contrario sempre ad
ogni violenza. Salvemini si avviava, col suo «pipistrello» ed il cappello tondo
sulla testa calva… Pistelli, senza una parola, gli si avvicinò e gli strinse la
mano. Questo bastò perché i fascisti non mettessero in azione i manganelli e
si limitassero a fischiare nei corridoi… Si aprì a destra l’usciolino, ed entrò
nell’aula, con passo ritmato e sicuro, Salvemini. Scoppiò un uragano
d’applausi, irrefrenabile… Di fuori, nei corridoi, urla e fischi di protesta. Egli
si avviò alla cattedra, tirò fuori di tasca il «cipollone», il vecchio orologio
d’argento… e disse calmo: «Né gli applausi né i fischi mi mutano
d’opinione…». E Salvemini - lo storico autore di Magnati e popolani in
Firenze, la magistrale ricostruzione delle vicende del comune fiorentino -
torna a essere quello straordinario docente che è sempre stato.
Ma, pochi mesi dopo, la situazione si fa insostenibile. “L’Università di
Firenze - scrive Massimo L. Salvadori nella biografia dedicata a Salvemini -
diventò campo di opposti schieramenti. «Uscendo di casa per andare a far
lezione» lo storico «non era più sicuro di tornarvi col cranio intatto». Una
mattina, mentre Salvemini faceva lezione, i fascisti gli scatenarono contro
una gazzarra. Calamandrei ha raccontato con la sua fine penna questa brutta
storia. Mentre Salvemini rischiava guai seri, egli scrive, «nel vano di una
finestra dal quale si poteva sorvegliare tutto il corridoio senza essere visti,
due autorevoli professori, Antonio Garbasso, sindaco di Firenze, e Giovanni
Brunetti, preside della mia facoltà, si tenevano… nascosti in attesa che il
corridoio fosse sfollato», impietriti dalla paura. Nessuno osò mettere le mani
sul maestro.
”1
Nell’estate del 1925 - già arrestato l‘8 giugno a Roma per la
pubblicazione clandestina «Non mollare» e appena messo in libertà
provvisoria il 13 luglio - deve decidere. Ha già sperimentato la vita carceraria
e affrontato i suoi giudici fiorentini davanti ai quali appare dopo una faticosa
traduzione ferroviaria che, ammanettato, lo ha portato da Regina Coeli alle
Murate. Rimesso in libertà provvisoria, con l’impegno di tenersi a
disposizione del tribunale, si convince - dopo il delitto Matteotti e con
l’amnistia concessa dal regime per passare un colpo di spugna sulle
responsabilità dell’assassinio del leader socialista - che nessun vincolo (e se
lo chiamassimo parage?) può tenerlo ancora legato allo Stato italiano.
Attraversa - accompagnato da Chabod, Mor e Sapegno - la frontiera al
Piccolo San Bernardo. Non gli è stato neppure necessario procurarsi un falso
passaporto. In effetti qualcuno dei suoi amici ha pensato - vista una certa
somiglianza dei tratti del suo viso con quelli di Bernard Berenson - di
utilizzare il passaporto del famoso storico dell’arte. A questo scopo si chiede
al “giovane conte Umberto Morra di Lavriano, grande amico di Salvemini e
fervente antifascista, di andare ai Tatti e chiedere a Berenson se sarebbe stato
disposto a lasciar usare il suo passaporto a Salvemini. Morra, molto lieto di
questa occasione di incontrare Berenson, eseguì l’incarico; ma l’unica
risposta di Berenson fu una risata cordiale e l’invito a Morra a fermarsi a
pranzo ai Tatti, dove egli divenne poi un amico abituale”
2
. Nei mesi
successivi all’espatrio il regime cerca di indurre Salvemini a tornare
attraverso proposte che il ministro dell’Istruzione pubblica Fedele gli inoltra
attraverso il comune amico Giustino Fortunato
3
. Il fascismo - spiega
Salvadori “forse avrebbe voluto fare con Salvemini quel che riuscì con Croce
poi: libertà di espressione (ma anche questo entro certi limiti) ad alcuni
grandi intellettuali, che avrebbero così testimoniato della «liberalità» del
regime sul piano culturale.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
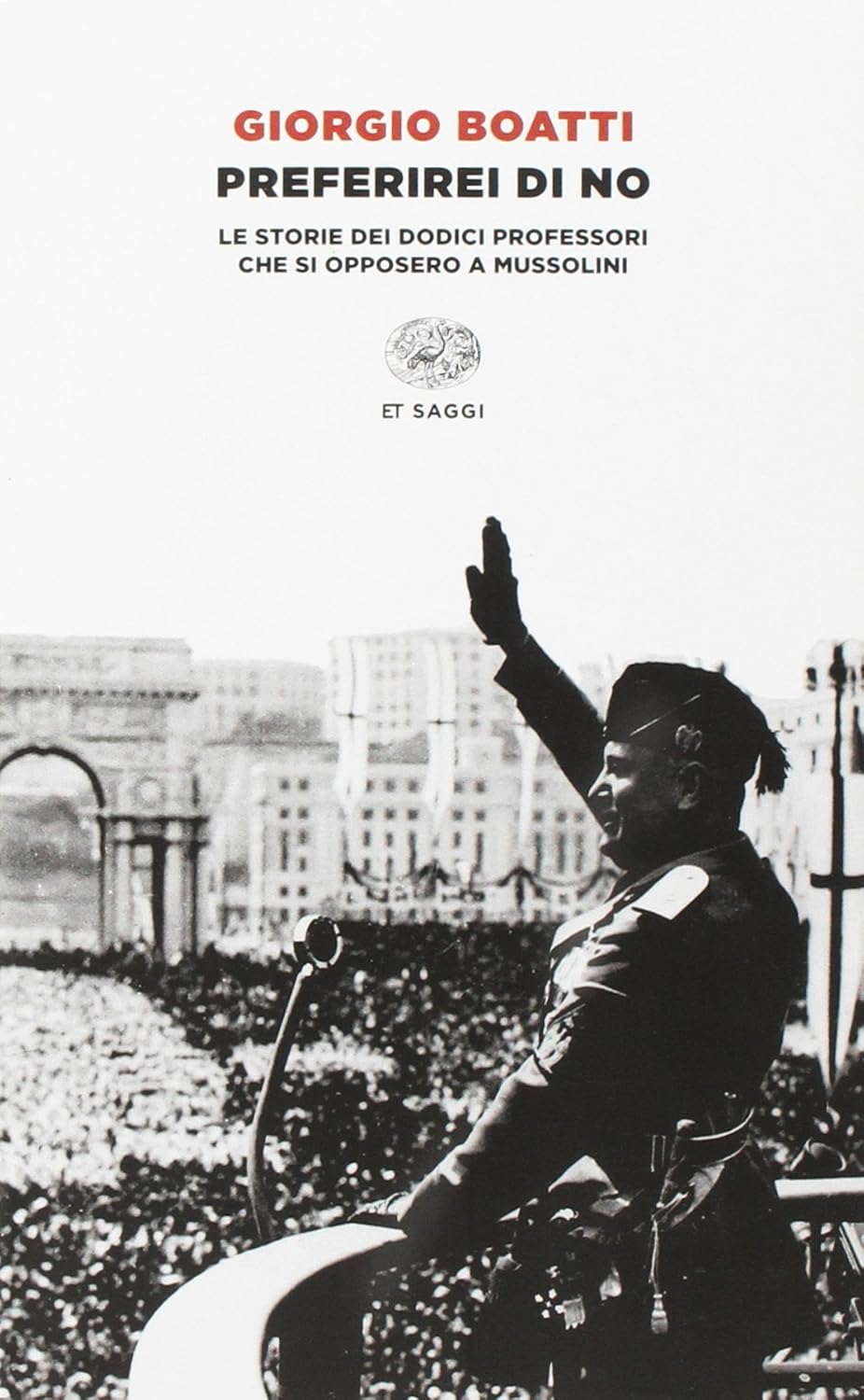






Commento all'articolo