Le sette lettere – Valerio Gasio
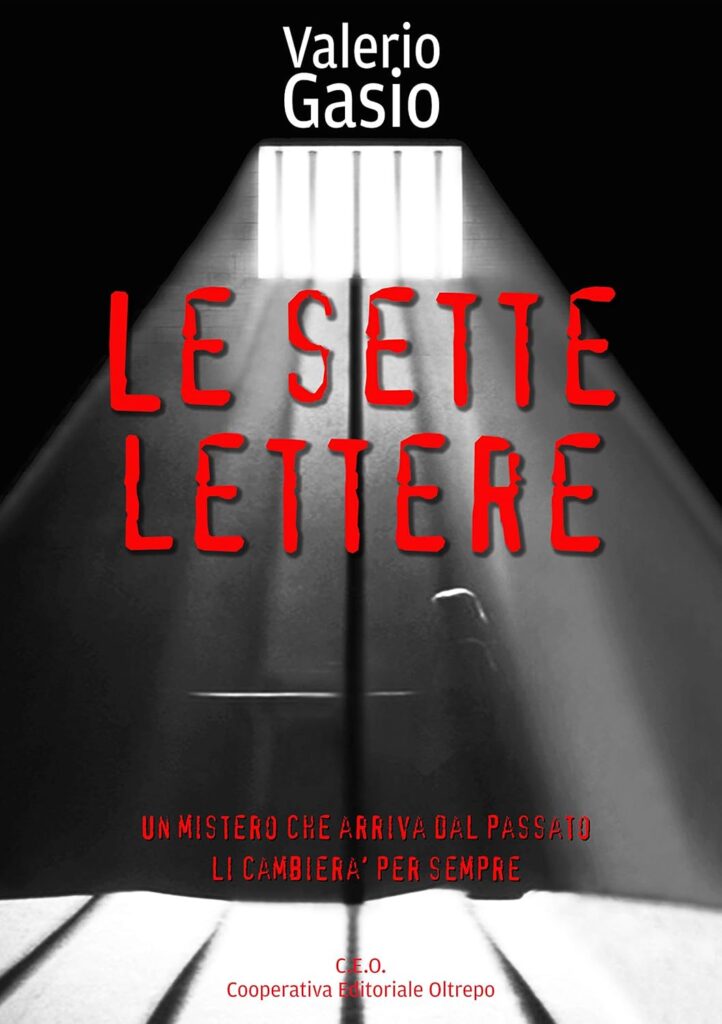
SINTESI DEL LIBRO:
Un teschio e delle ossa umane sparse un po’ dappertutto non
facevano altro che aumentare il senso di disagio e di claustrofobia.
“Perché ci sono questi resti Ingegner Rossi?”.
Giorgio Rossi era un giovane laureato in ingegneria che per hobby
faceva ricerche storicoarcheologiche, soprattutto riguardanti il
Duomo e sui cunicoli che lo collegavano anticamente ad alcune
zone del centro storico. Questa sua passione cercava di
trasmetterla, organizzando visite guidate in collaborazione con le
scuole della città.
“Aspettavo questa domanda. Tutti i ragazzi che porto qui alla fine me
la fanno, è naturale”.
Da una grata di un tombino sul soffitto filtrava un po’ di luce, che
proiettava delle scie attraverso l’aria umida e polverosa di quel
luogo, come quando i raggi del sole penetrano tra le nubi verso la
fine di un temporale estivo, così l’uomo si posizionò in modo da
esserne illuminato.
“Purtroppo, nel 1630 anche Voghera, la nostra amata città, venne
colpita duramente dalla Yersinia pestis. I poveri resti di chi non ce la
fece, vennero sepolti in questo posto per cercare di arginare il
contagio. Chi sa dirmi di cosa si tratta?”.
Tutti tenevano gli occhi bassi guardandosi i piedi per paura di dover
rispondere.
“Va bene, va bene, ve lo dico io, è il nome in latino della peste”.
I ragazzi rimasero in silenzio, in attesa di un’ulteriore spiegazione.
L’Ing. Rossi, alzando leggermente gli occhi al cielo, tirò un lungo
sospiro di sopportazione. “Nel sottosuolo della città, ci sono almeno
altri sette tunnel come questo dove ci troviamo adesso ed alcuni
erano stati usati appunto per arginare l’epidemia di peste bubbonica
che è un’infezione batterica. La trasmissione nell'uomo può avvenire
attraverso la puntura delle pulci dei ratti, detta Xenophilla cheopis,
oppure tramite il morso degli stessi topi o di altri roditori infetti. In
forma minore, anche la pulce dell'uomo ed i pidocchi sono in grado
di trasmetterla e la cosa può avvenire perfino da uomo a uomo.
Insorge violentemente dopo un periodo di incubazione da due a
tredici giorni, presentandosi con febbre alta, mal di testa, grave
debolezza, disturbi del sonno, nausea, fotosensibilità, dolore alle
estremità, vomito e delirio. Si può formare una pustola che interessa
la pelle nell'area della puntura dalla pulce infetta. L'aspetto clinico
più caratteristico della malattia è l'ingrossamento di uno o più
ghiandole linfatiche, quelle più vicine al luogo di ingresso del
patogeno, che di solito sono le zone inguinale ed ascellare. Il
linfonodo s’infiamma formando un bubbone, cioè un rigonfiamento
edematoso, il cui interno evolve formando un accumulo emorragico.
Ciò è la conseguenza del fatto che il batterio continua a sopravvivere
anche dopo essere stato attaccato dal sistema immunitario e si
accumula all'interno del linfonodo, riproducendosi e producendo
tossine in grado di bloccare alcune risposte immunitarie. Nei casi
gravi l'infezione si propaga a tutto l’organismo, dando luogo alla
peste setticemica, provocando insufficienza cardiocircolatoria e
necrosi, che solitamente partono dalle dita delle mani o dei piedi, per
poi espandersi lentamente provocando complicazioni renali o
emorragie interne. In assenza di cure, la malattia può evolvere verso
questa fase e portare facilmente alla morte. Alternativamente, nei
casi meno gravi, la febbre cessa dopo circa due settimane e i
bubboni espellono pus, sgonfiandosi e formando una cicatrice”.
Alcuni dei giovani fecero delle espressioni di disgusto, altri
scherzarono cingendo da dietro il collo degli amichetti notoriamente
più timorosi, spaventandoli e dando il via a risate generali. Perfino il
loro austero cicerone ne fu contagiato e gli scappò un sorriso.
“Adesso non scappate via subito, vi devo ancora far vedere una
cosa interessante dentro la Collegiata di San Lorenzo. Lo so,
nessuno sa cosa sia, ma è il nostro Duomo! Nonostante le
dimensioni e l’importanza non può fregiarsi del titolo di Cattedrale
perché non è sede vescovile. Su, un po’ di pazienza, iniziate ad
uscire uno ad uno e non spingetevi!”.
Dicendolo, indicò la via per tornare all’aperto e tutti i ragazzini
iniziarono allora a spintonarsi l’uno con l’altro, per guadagnare per
primi l’uscita. I più intraprendenti salirono in un battibaleno la scaletta
che portava al livello stradale, nella soprastante Piazza del Duomo,
mentre gli altri rimasero indietro. In particolare l’ultimo, il più
imbranato, addirittura cadde all’indietro per colpa del voluminoso
zaino che portava sulle spalle. La caduta fu rovinosa e si trovò
coricato di schiena sulla terra del pavimento del cunicolo. Girò
leggermente la testa e fu preda di un orrore incontenibile, il teschio
era appoggiato alla sua tempia destra.
Il ragazzo cercò di urlare, ma la voce sembrava essergli sparita,
iniziò a dimenarsi ed a ballare in modo comico come se fosse stato
infestato da voraci formiche carnivore e nel farlo diede un calcio alle
povere ossa che tappezzavano quel luogo di dolore.
“No, no, così no! Un po’ di rispetto, per favore!”.
L’Ingegner Rossi prese quel reperto infilando le dita nelle orbite
vuote e lo posizionò dove si trovava prima.
Quando furono tutti usciti, con l’ingegnere in testa, si diressero più o
meno disciplinatamente verso l’ingresso nord della chiesa principale
della città.
Appena dentro, subito sulla sinistra, c’era un tavolo in marmo e
sopra di esso un dipinto, Giorgio Rossi chiuse allora la porta lasciata
spalancata dai ragazzi ed iniziò la sua spiegazione.
“Ci troviamo di fronte all’altare di Sant’Antonio, il quadro che vedete
lì sopra è di Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone ed è
del XVII secolo. Questo luogo è anche detto dei Ciabattini che, per
chi non lo sapesse, sono coloro che aggiustano le scarpe quando le
rompete e vostra mamma per risparmiare, invece di comprarvele
nuove, le porta da questi preziosi artigiani per le riparazioni. Bene,
questo è dedicato a loro e lo potete capire anche alzando il vostro
sguardo verso l’alto. Lì ci sono quattro vele, no, non cercate quelle
delle barche, si dicono così tecnicamente per la forma del dipinto
che è triangolare e ricorda appunto una vela. Una riproduce
Sant’Antonio l’Eremita, intento a lavorare su di un mobiletto da
ciabattino, perché nella vita svolgeva proprio quell’attività. Le ha
dipinte un pittore dell’800 chiamato Luigi Morgari, lo potete capire da
quelle due letterine, la L e la M, che sono poi le sue iniziali, visibili
sul fondo dei dipinti. Qui sotto i nostri piedi dovrebbe esserci una
cripta, tipo quella che abbiamo visto poco fa, dove una confraternita
che prendeva il nome del santo raffigurato nell’affresco, seppelliva i
corpi dei suoi adepti. Non c’è ancora la certezza di questo, ma io
penso che alla fine verrà trovata”.
Alcuni ragazzi, pensando alla forte sensazione claustrofobica
provata poco prima sotto la piazza, sperarono seriamente non
accadesse mai, per evitarsi un altro giro con l’Ingegner Rossi nel
sottosuolo. “Venite, vi mostro ancora una cosa”.
Un moto di stizza serpeggiò tra i giovani, la loro sopportazione
iniziava ad esser messa a dura prova.
Il gruppetto si diresse verso il fondo della chiesa dove sulla sinistra vi
era una porticina di legno scuro, poco prima di un altro altare detto
del Crocefisso, dove spiccava un Cristo in croce e risalente al secolo
XV. “Sapete cosa c’è lì dietro?”.
Silenzio assoluto.
“No, ovviamente, ma cosa vi insegnano a scuola?”.
Quelle erano visite davvero interessanti, ma tremendamente
stressanti. Sempre messi alla prova riguardo le loro conoscenze
che, vista anche l’età molto giovane, non potevano regger l’urto con
le pressanti domande che venivano fatte loro.
I ragazzi si guardarono quindi tra loro interrogativamente, ma
nessuno di loro sapeva cosa rispondere. “Dietro questo elegante
manufatto c’è…”.
L’uomo l’aprì molto lentamente e tutti sporsero il capo per cercare di
vedere meglio.
Quando la porta fu completamente spalancata li colse un po’ di
delusione, c’erano solamente delle robuste corde che penzolavano
dall’alto senza toccare terra.
L’ingegnere entrò, ne prese una con entrambe le mani e la tirò con
una certa fatica. Subito dopo un forte suono echeggiò in tutte le
navate. Era potente, ma piacevole, era chiaramente il suono di una
campana. “Ci troviamo alla base del campanile, da qui vengono
suonate le campane. E’ difficoltoso farlo, soprattutto per dei
ragazzini come voi, perché ci vuole una discreta forza. Inoltre farlo
bene è un’arte, bisogna avere una grande esperienza per
raggiungere un buon livello”.
Alcuni giovani entrarono a loro volta e sbirciarono verso l’alto e
l’interno di quella costruzione lunga e stretta faceva girar la testa.
“E’ stato edificato sui resti della torre d’avvistamento del Castrum
romano, che in una buia notte dei primi del 1400 crollò sull'adiacente
pieve. La raffinata statua lignea di Gesù in Croce qui accanto, che
era venerata come protettrice da quella terribile malattia di cui vi ho
parlato prima, la peste, si salvò dalla distruzione ed in tanti gridarono
al miracolo. Si decise allora di ricostruire dalle macerie e ciò che
realizzarono divenne l’attuale campanile. All’esterno è ancora ben
visibile la base di circa quattro metri, rimasta in piedi dopo il crollo, lo
potete notare dal colore dei mattoni leggermente diversi dagli altri
soprastanti. Pensate che oggi è alto ben 40 metri, da far venir le
vertigini, vero? Immaginate cosa vi potrebbe succedere ad essere là
in alto con le campane che suonano. Meglio non pensarci”.
I ragazzi non sembravano aver colto, i loro volti dimostravano
inequivocabilmente che erano ormai esausti e disattenti vista la serie
di argomenti un po’ indigesti trattati.
“Su, dai, ho capito, per oggi è abbastanza. Potete tornare all’oratorio
a giocare ed a godervi le meritate vacanze estive. Ci vediamo
presto. Ciao”.
“Arrivederci ingegnere”, dissero tutti quasi all’unisono e, senza
esitare troppo uscirono a passo svelto sparendo tutti in un batter
d'occhio.
Sul selciato della piazza, uno dei ragazzi che avevano partecipato
alla lezione di archeologia locale, osservava tutto quello che lo
circondava. Si copriva gli occhi con la mano a mo’ di visiera per
ripararsi dall’intensa luce estiva che avvolgeva tutto.
Era di fronte alla maestosa chiesa che dominava quel grande spazio
aperto e sulla sua destra, in fondo, all’imbocco della via Garibaldi,
vedeva la vecchia costruzione medioevale chiamata “La casa del
boia”, perché si diceva che un tempo lì sotto venissero impiccati i
condannati a morte. Vedeva poi anche gli eleganti portici tipici
dell’architettura piemontese dell’800, che come una preziosa collana
contornavano tutto il perimetro della piazza.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :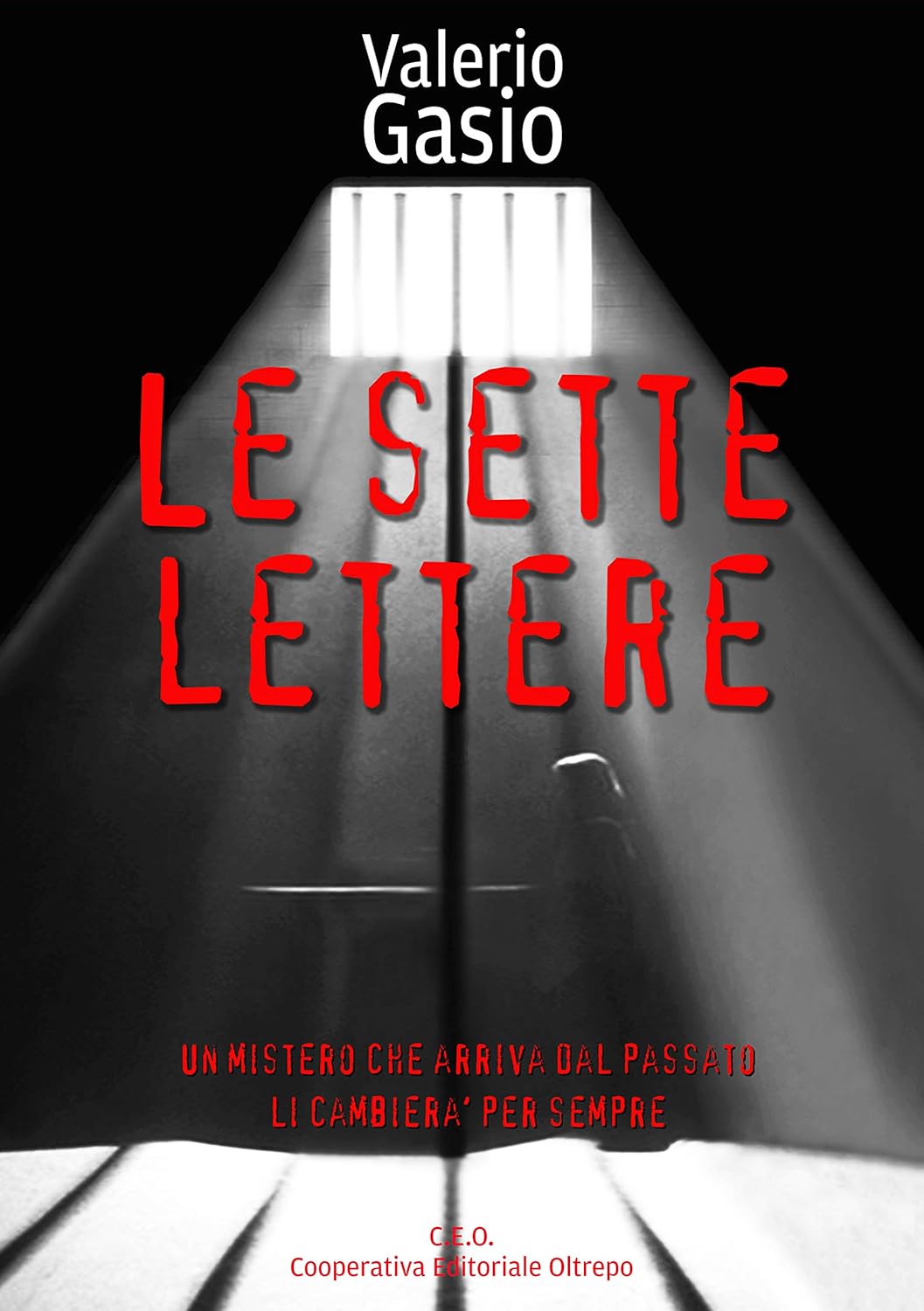






Commento all'articolo