L’amicizia per se stessi – Cura di sé e arte di vivere – Wilhelm Schmid
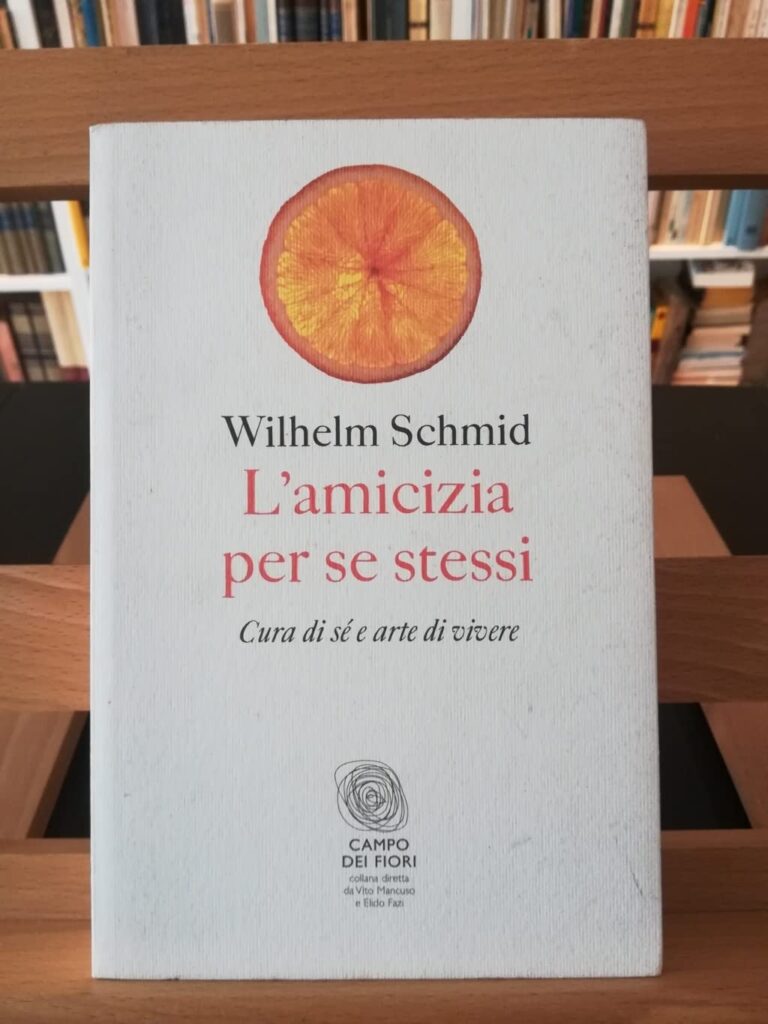
SINTESI DEL LIBRO:
Puro divertimento sulla ruota panoramica, insieme agli altri su
una navicella. Oscillo su tutto il mondo, il vento mi culla. La ruota si
ferma. Laggiù c’è chi sale e chi scende. D’un tratto mi coglie la
paura, senza preavviso e senza motivo. La nuda paura. Nel giro di
un momento la gioia sfrenata si trasforma nel suo opposto: posso
precipitare, mi posso sfracellare, nulla può evitarmelo. «A me?». Di
quale demone sono preda? Cosa si è impossessato di me? Non lo
so: non “lo” conosco, non l’ho mai incontrato. Una cupa certezza
sovrasta le mie forze. La paura della morte mi attraversa, fa
impazzire il mio cuore, mi fa sudare freddo; le mani afferrano la
panca sulla quale siedo. Tutto inutile. Quel demone può dissolvere la
presa in ogni momento e farmi precipitare. Resterebbe sempre un
mistero perché proprio lui, perché proprio lì. Sempre e comunque:
perché.
Come mai non ne faccio parola con nessuno, perché non grido
aiuto? Perché ogni secondo è un tormento; devo darmi da fare con
quelle poche forze che mi restano – ogni momento di distrazione
potrebbe essere quello buono, da un momento all’altro il demone
potrebbe assalirmi, un momento di morte, nel quale il demoniaco
può vincermi definitivamente. Ora vivere è sopravvivere attimo dopo
attimo. Non mi concentro su nient’altro: le mie forze bastano solo a
questa sciocchezza. Gli sguardi atterriti degli altri non mi aiutano a
lottare contro questo Altro dentro di me che mi vuole per sé. Se ne
fossi capace dovrei guardare avanti, a un attimo futuro, e forse
superare anche quello… Perché la ruota, questa ruota dell’orrore, ci
mette così tanto a tornare indietro?
Le torture medievali probabilmente erano simili a questa, che ha
distrutto lentamente ogni fibra del sé. Poi, all’improvviso, tutto è
passato. Tocco di nuovo terra, finalmente posso baciare il suolo con
grande gioia. Le ginocchia continuano a tremare e non ho ancora
capito come si possa vivere così. Intanto decido di lasciare riposare
quest’esperienza, di appropriarmene. Cerco di non pensarci, di non
analizzarla, evito di parlarne. E invece la ridisposizione del sé, la
domanda sul fondamento, dando all’arte di vivere una funzione
privilegiata che permette di trovare un contrappeso, di mantenere le
abitudini, di trovare qualcosa di bello, sono importanti per
controbilanciare l’angoscia. E così ci saranno anche il tempo e la
sicurezza per spiegare che cosa è successo – per dire se davvero
qualcosa è successo.
Quell’angoscia enorme, ineliminabile, perde così la sua forza, pur
continuando a farsi viva tutti i giorni, anche solo per poco. Mi assale
quando cammino su un marciapiede: ho paura di vivere, ho paura
del mondo. Non so proprio che cosa mi stia succedendo. È diffusa
come la nebbia. Dentro di me si forma un buco che risucchia il
mondo in un triste nulla. Se lo racconto, magari qualcuno mi capisce.
Qualcun altro, però, se la svigna, perché la paura è «negativa» e ti
«affossa». La paura rende soli. Non ci posso fare niente; mi
concedo, mi ci abbandono, almeno per qualche tempo. Basteranno
un paio di giorni? Non la voglio nascondere, non la voglio sedare.
Devo farmene carico e sopportarla. Comincio perfino ad attribuirle
un qualche valore, anche se ancora non arrivo a chiedermi di cosa
ho effettivamente paura, o che cosa, in me e nel mondo, la generi.
Può esistere una vita senza angoscia? Cos’è l’angoscia e cos’è la
paura? Entrambe sono un’occasione per riflettere, un momento
eminentemente filosofico, uno sguardo nei fondamenti e nell’abisso.
Normalmente viviamo la nostra vita sulla superficie della
quotidianità. Sotto la superficie, però, si aprono gli abissi: abissi del
dubbio e dell’assurdo, dell’infelicità e della tragedia, del male e dello
“spaesamento”, abissi della banalità. L’esperienza dell’abisso
infrange l’ordinario e distrugge quelle abitudini di cui è popolata la
nostra quotidianità. Una frattura del genere potrebbe forse essere
desiderabile, soprattutto quando viene paragonata al tran-tran di tutti
i giorni, irriflesso, monotono e noioso. Ma quando l’abisso irrompe
sul serio, la quotidianità muta in qualcosa di diverso: la superficie
diviene nuovamente l’indizio dell’oppressione reciproca.
L’esperienza dell’abisso che tutti conosciamo è l’angoscia.
L’angoscia non è un privilegio; l’angoscia arriva per tutti, soprattutto
quando non la si aspetta, e pare essere distribuita tra gli esseri
umani in maniera sorprendentemente equa. Ne sono vittima potenti
e deboli, poveri e ricchi e, in particolar modo, proprio chi si sente
sicuro di fronte a tutto. Ognuno di noi è in grado di parlare delle
paure che fin dall’infanzia toccano la vita umana, descrivendo
quell’esperienza che già in latino viene indicata con la parola
angustia: ‘restrizione’, ‘strettoia’, ‘difficoltà’, ‘pena’. Il sostantivo
richiama il verbo greco áncho: ‘essere trattenuti, strozzati, torturati’.
L’ampiezza delle possibilità si riduce a un’unica realtà, minacciosa
per quanto è ristretta, che non è nemmeno certo sia davvero “reale”,
anche se capirlo non servirebbe a comprendere la paura da essa
generata. Il sé si sente ristretto al punto da mettere a repentaglio la
sua stessa vita, poiché gli viene tolta l’aria per respirare.
L’esperienza della paura si concretizza in un sentimento
innescato da una minaccia che appare spaesante; un sentimento nel
quale il sé, anche se non lo ammetterebbe mai, è estremamente
debole e abbandonato a se stesso. In rapporto al gioco di forza
interiore del sé, come quando siamo afflitti da un dubbio, la paura è
più forte dell’io pensante. Da un punto di vista evolutivo, invece, la
paura fa valere il diritto più antico: innesca l’impulso alla fuga e a
mettersi in salvo. Il suo strumento di potere consiste nel rendere
impossibile ogni pensiero chiaro e nel “generare il panico”. Per
comprendere l’incomprensibile si decide di ricondurre le diverse
angosce a un’occasione concreta che probabilmente non vale
niente. Vengono, cioè, proiettate su un problema che potrebbe
anche non sussistere. Nella società, questa funzione di
semplificazione e proiezione è da sempre svolta dagli “emarginati”:
singoli soggetti e intere culture cercano di mantenere il loro orgoglio
attribuendo ad altri, bollati come “deboli”, il loro sentimento di paura.
In rapporto al gioco di forza esteriore tra gli esseri umani, la paura
rappresenta la leva per l’esercizio del potere di un singolo sull’altro.
Per questo, talvolta, l’io pensante ha ragione a tenersi per sé la
paura, a pretendere che sia legittima solo in un caso particolare, a
imporre un’analisi sobria delle situazioni nelle quali si presenta, a
legarla, come si fa con un cane feroce, e a sfruttare la sua capacità
di fiutare situazioni minacciose senza disperdere i suoi impulsi, ossia
senza abbaiare con tutta se stessa.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :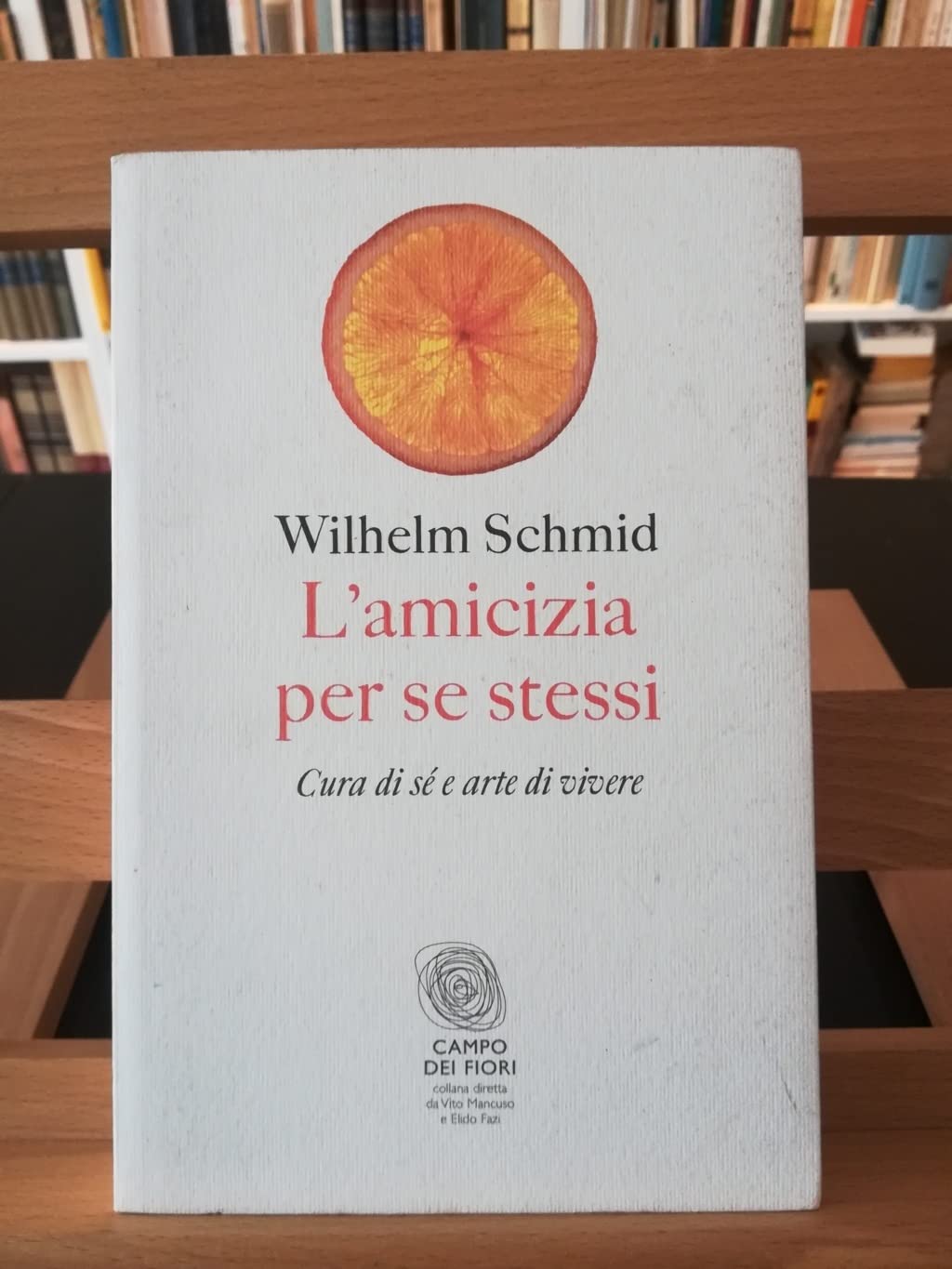






Commento all'articolo