L’albero intricato – David Quammen
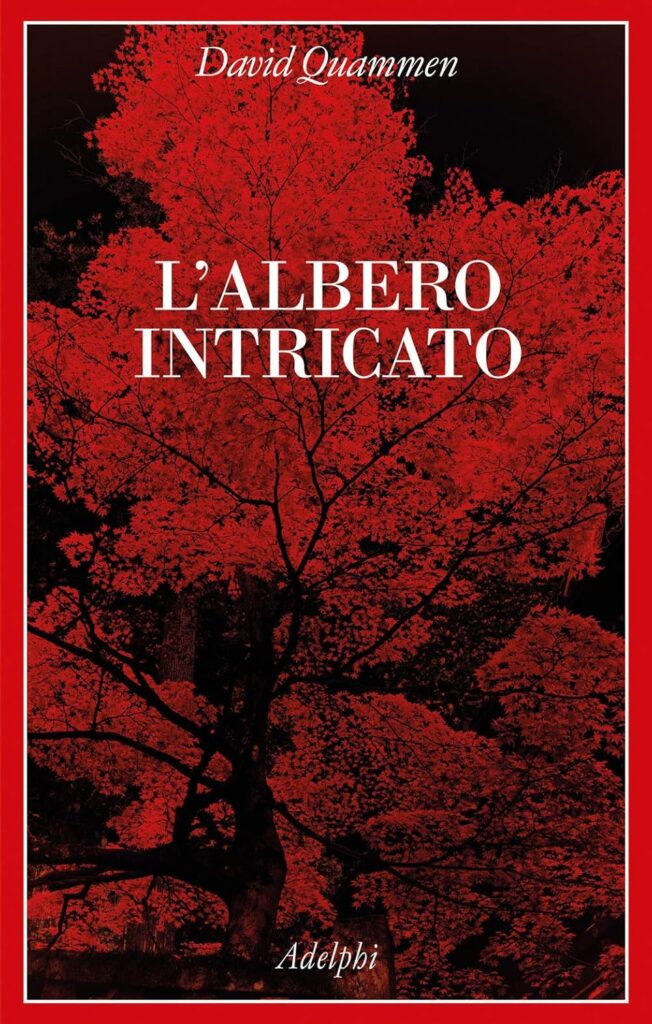
SINTESI DEL LIBRO:
A partire dal luglio 1837, Charles Darwin tenne un
piccolo taccuino, che etichettò con la lettera «B», dedicato
all’idea più bizzarra che gli fosse mai venuta. Era qualcosa
non solo di privato ma di segreto, dove riportava i suoi più
stravaganti pensieri. Il taccuino era rilegato in pelle
marrone, con una linguetta e un fermaglio; 280 pagine di
carta color crema, abbastanza compatto da entrare nella
tasca della giacca. Un quadernetto portatile, ma non di
quelli che poi si buttano via. La qualità dei materiali e della
fattura riflettevano il fatto che Darwin era un giovane
facoltoso, che viveva a Londra e faceva il naturalista
fidando su mezzi propri. Era rientrato in Inghilterra dalla
lunga traversata dell’HMS Beagle appena nove mesi prima.
Quel lungo giro, che aveva assorbito quasi cinque anni
della sua vita, per mare e per terra, principalmente lungo
la costa sudamericana e verso le pianure e le montagne
dell’entroterra, seppur con altre ragguardevoli tappe nel
tortuoso tragitto di ritorno, sarebbe stato l’unica
importante esperienza di viaggio della sua protetta,
privilegiata esistenza. Ma fu sufficiente. Era stata
un’opportunità trasformativa, che gli aveva spalancato la
mente e suggerito alcune grandi idee che intendeva
approfondire. Aveva aperto i suoi occhi su un fenomeno
sorprendente che necessitava di spiegazione. In una lettera
scritta da Sidney, in Australia, e indirizzata al suo
professore di biologia e amico John Stevens Henslow
all’Università di Cambridge, Darwin menzionò le sue
sconcertanti osservazioni sui mimi o tordi beffeggiatori (e
non i fringuelli) dell’arcipelago delle Galápagos, un gruppo
di sporgenze vulcaniche in mezzo al Pacifico. Questi uccelli
grigi dal becco lungo differivano da un’isola all’altra, ma in
maniera così sottile che sembravano essersi differenziati da
un’unica famiglia. Differenziati? Tre specie di mimi?
Lievemente diversi da questa a quell’isola? Sì: apparivano
diversi ma simili, tanto da far pensare che fossero affini. Se
quell’impressione corrispondeva al vero, confidò Darwin a
Henslow come se confessasse un’eresia intellettuale,
«simili fatti minerebbero la stabilità delle specie».
La stabilità delle specie rappresentava il fondamento
della storia naturale. Era data per scontata, e considerata
importante, non solo nel clero e tra i laici devoti, ma anche
tra gli uomini di scienza. Che tutte le svariate forme di
creature sulla Terra fossero state plasmate da Dio, in
specifici atti di creazione, e fossero di conseguenza
immutabili, era un articolo di fede per l’establishment
scientifico di professione anglicana dell’epoca di Darwin.
Questo principio cardine è conosciuto come ipotesi della
creazione speciale, anche se all’epoca sembrava non tanto
un’ipotesi quanto un dogma. Era stato abbracciato e
sostenuto da eminenti naturalisti e filosofi della cultura
scientifica in seno alla quale Darwin aveva ricevuto la sua
istruzione a Cambridge. Adesso era tornato a casa dopo un
rischioso viaggio, un’avventura di gioventù insieme a una
combriccola di rudi marinai inglesi, che l’austero padre
all’inizio aveva visto con scetticismo. L’esperienza lo aveva
cambiato, anche se non nei modi probabilmente temuti dal
padre. Non era diventato un ubriacone o un libertino. Non
imprecava come un nostromo. La sua sete di viaggi,
soddisfatta sul piano fisico, si era adesso spostata su quello
intellettuale. Si proponeva di indagare, con estrema
discrezione, un’alternativa radicale all’ortodossia
scientifica: l’idea che le creature viventi non avessero
forme eternamente stabili, così come Dio le aveva create,
ma si fossero invece modificate nel corso del tempo,
passando da una forma a un’altra, in virtù di qualche
meccanismo che ancora non comprendeva.
Era un’affermazione azzardata. Ma Darwin aveva
ventisette anni, quello che aveva visto lo aveva
profondamente mutato e, pur essendo di indole pacata,
aveva del fegato.
Così si era sistemato nella grande città, prendendo
alloggio su Great Marlborough Street, da dove poteva
raggiungere agevolmente il British Museum. Si trovava a
breve distanza dalla casa dove si era già stabilito il fratello
maggiore Erasmus. Darwin entrò a far parte di società
scientifiche quali la Geological Society e la Zoological
Society, ma non aveva un lavoro. Non ne aveva bisogno. Il
temibile padre, lo stesso che in un primo tempo aveva
disapprovato il viaggio sul Beagle – il dottor Robert Darwin,
agiato medico della città di Shrewsbury –, adesso era
piuttosto fiero del suo secondo figlio, il giovane naturalista
stimato nei circoli scientifici inglesi. All’apparenza arcigno
ma intimamente generoso, il dottor Darwin aveva
organizzato le cose in modo da fornire un adeguato
sostegno a entrambi i fratelli. E Charles era celibe. Andava
a spasso per Londra, si occupava degli esemplari raccolti
durante la spedizione, lavorava alla riscrittura del diario
del Beagle per farne un libro di viaggio e – in gran privato –
rimuginava sull’alternativa radicale alla creazione speciale.
Leggeva molto, buttando giù fatti e frasi in diversi taccuini.
Il taccuino «A» era dedicato alla geologia. Il taccuino B fu il
primo di una serie su quella che, solo tra sé e sé, chiamava
«trasmutazione». Non è difficile indovinare che cosa
significasse. Nella mente di Darwin aveva cominciato a
farsi strada una teoria dell’evoluzione.
Aprì il taccuino B, nel luglio del 1837, con alcune frasi
che alludevano a un libro intitolato Zoonomia, ovvero leggi
della vita organica, pubblicato decenni prima da suo nonno,
un altro Erasmus Darwin. Era un trattato di medicina
(Erasmus era medico), ma conteneva alcune riflessioni
provocatorie che suonavano vagamente evoluzionistiche.
Secondo Zoonomia tutti gli animali a sangue caldo
sarebbero «originati da un unico filamento vivente» e
posseggono «la facoltà di continuare a migliorare» secondo
modalità che potrebbero essere tramandate di generazione
in generazione, «all’infinito!».1 Un miglioramento
attraverso le generazioni? Un cambiamento ereditabile
durante l’intera storia del mondo? Tutto ciò andava contro
l’ipotesi della creazione speciale, ma non era in fondo
sorprendente in un libero pensatore gottoso, libidinoso e –
a volte – poeta come il vecchio Erasmus. Darwin aveva letto
Zoonomia ai tempi in cui studiava e non sembrava aver
dato molto credito alle audaci idee del nonno. Ma adesso, a
un secondo esame, le assunse come punto di partenza. A
pagina uno del taccuino B troviamo, come prima
annotazione, il titolo del libro del nonno, Zoonomia, seguito
da appunti di lettura.
D’altra parte, quei suggerimenti folli non portavano da
nessuna parte. Erasmus Darwin non aveva proposto nessun
meccanismo concreto per spiegare quella «facoltà di
continuare a migliorare», ed era proprio un meccanismo
concreto che il giovane Darwin cercava, anche se forse non
se n’era ancora reso pienamente conto. Come mostra il
taccuino B, a quel punto passò dall’opera del nonno ad
altre letture, altre congetture e altri interrogativi,
annotando frasi smozzicate, spesso senza badare alla
grammatica e alla punteggiatura. Ciò che scriveva non era
destinato alla pubblicazione. Erano messaggi rivolti a se
stesso.
«Perché la vita è breve»2 si chiedeva, omettendo nella
fretta il punto interrogativo. Perché la riproduzione è così
importante? Perché gli animali di una data specie tendono
ad avere una forma costante all’interno di un intero paese
ma a presentare almeno lievi differenze su isole separate?
Ricordava le tartarughe giganti delle Galápagos, dove
aveva fatto una sosta durata solo trentacinque giorni, che
però aveva causato in lui un vero rivolgimento del pensiero.
Ricordava anche i mimi. E perché nella pampa argentina
aveva visto due tipi diversi di «struzzi» (così aveva definito
dei grandi uccelli incapaci di volare che sono conosciuti
oggi col nome di nandù), uno che viveva a nord del Río
Negro e uno a sud di esso? Le creature diventavano in
qualche modo differenti quando erano isolate? Mettete una
coppia di gatti su un’isola, lasciate che si riproducano e si
incrocino endogamicamente per generazioni, senza grande
pressione da parte di specie nemiche. «Chi si azzarderà a
prevederne il risultato?» scrisse Darwin. Si azzardò lui. I
discendenti alla fine potrebbero avere un aspetto diverso
dagli altri gatti, no? Voleva capire per quale motivo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :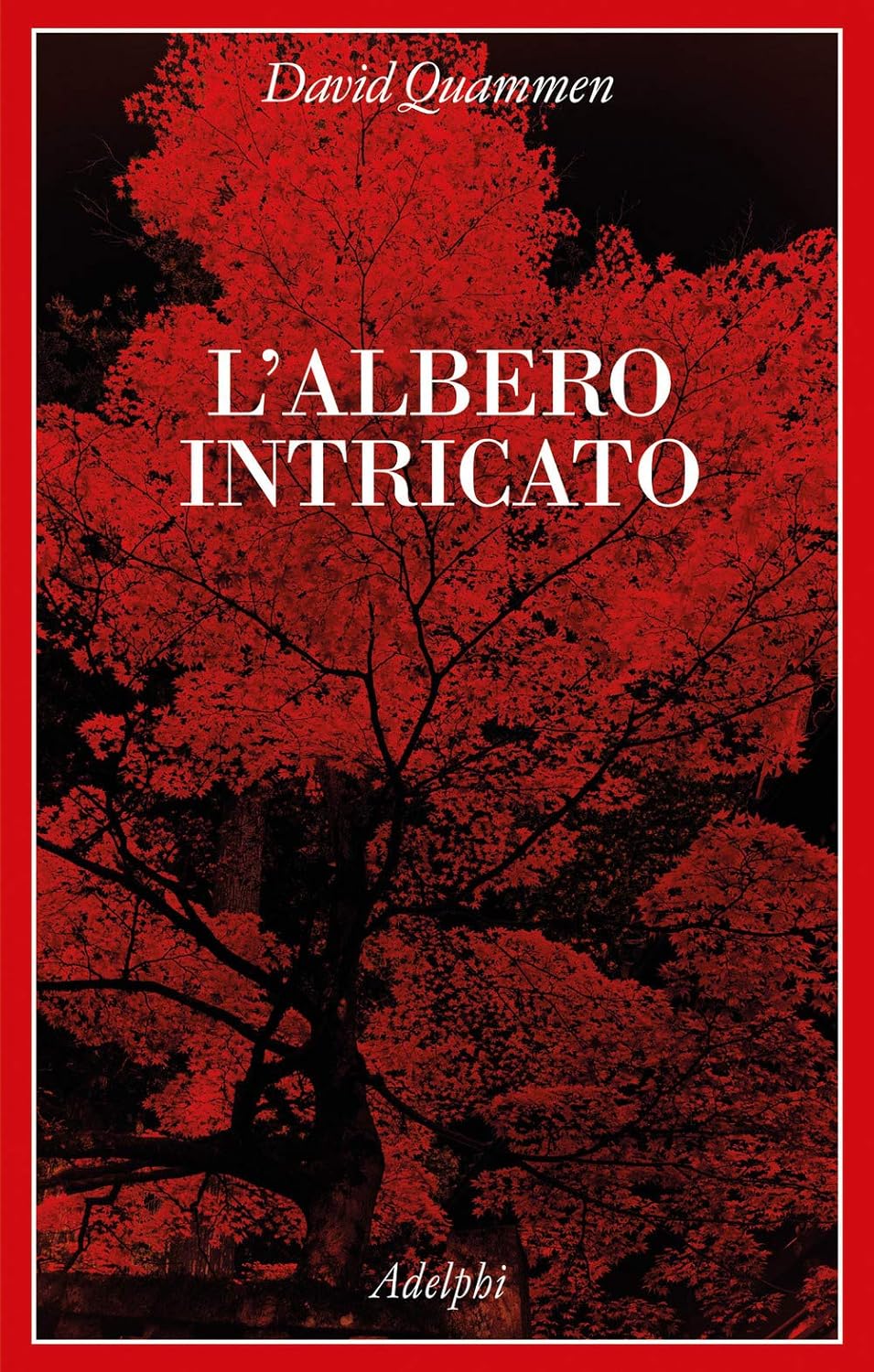






Commento all'articolo