La virtù dell’orto: Coltivando la terra si coltiva anche la felicità – Pia Pera
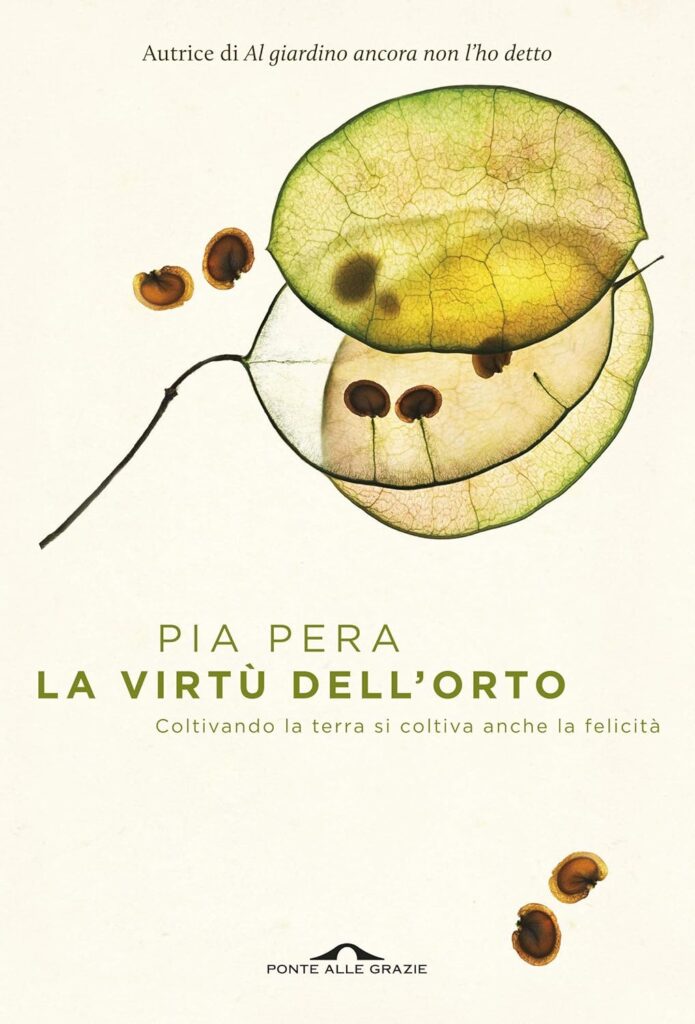
SINTESI DEL LIBRO:
Anni fa lessi nei Saggi di Michel de Montaigne una frase a cui mi sono
affezionata: se qualcosa ci piace, non è verosimile ci faccia male (stava
parlando di cose da mangiare). Non ho sottomano la citazione precisa,
ricordo però molto bene il senso di liberazione provato nel leggerla.
Montaigne dice nel modo più schietto verità non molto diverse da
quelle scoperte dal Buddha al momento dell’illuminazione. Ne condivide
il disincanto, il buon senso, l’amore per la liberazione e la
consapevolezza dell’impermanenza nostra e del mondo.
Montaigne, come i suoi antenati prima di lui, detestava i medici e
rifiutava di prendere medicine, giudicandole incerte e dannose.
Riteneva più saggio seguire la naturale inclinazione. Avere fiducia in un
piacere rettamente inteso e lontano da qualsiasi eccesso. Si chiedeva:
una sensazione di benessere, non nutrirà essa stessa la nostra salute?
Regalandoci un grato buon umore, come potrà farci del male? E le
fantasiose torture inflitte dai medici, certe medicine amarissime, sarà
poi sicuro ci facciano bene?
Suggerisco di applicare il pensiero di Montaigne al beneficio che
potremmo derivare dall’orto: non è una cura universale, funziona solo
se ci corrisponde.
Se per un qualche motivo lavorare la terra proprio ci disgusta,
escludo possa rendere migliori le nostre giornate. Conosco persone che
detestano la campagna. Preferiscono andare a fare spese, fumare,
guardare la televisione, saltare da un aereo all’altro.
Se invece stare all’aria aperta ci rasserena, trafficare tra le piante ci
mette allegria, scoprire che i narcisi stanno per sbocciare ci ispira
letizia, frugare nel mucchio del compost ci dona un senso di
appartenenza alla terra, uscire di casa col pigiama ancora caldo di letto
ci fa sentire liberi e addirittura padroni del mondo, allora rallegrare il
nostro tempo in giardino sarà la più saggia delle occupazioni.
Adesso vi racconto le cose che piacciono a me.
Scavare una buca
L’estate torrida, siccitosa si allontana tra scrosci assidui e gentili di
pioggia. Un paio di giorni dopo, il sole si riaffaccia tra nubi ormai
scariche, gonfie soltanto di luce. La terra è in tempera. Si dice così
quando ha la consistenza perfetta per venire lavorata: né troppo
bagnata, che si incollerebbe alla vanga e, calpestata, si compatterebbe,
né troppo dura e asciutta.
Mi prende la smania di scavare buche. Per mesi e mesi ho tenuto a
freno la voglia di sistemare una piantina presa d’impulso in un vivaio.
Adesso, finalmente, mi posso armare di zappa e vanga.
La zappa ci vuole per togliere lo strato d’erba, mettere a nudo la
terra. È un po’ come portare alla luce un segreto. Cosa ci sarà sotto la
pelliccia, quella sorta di epidermide irta di steli verdi e bruni, fitta di
radici? Argilla rossiccia, ma anche i frenetici puntini neri delle formiche.
Ho disturbato un formicaio. La zappa batte contro la radice di un
ciliegio.
Scopro la larva di un maggiolino, la butto lontano. Il suono di un
grosso chiodo arrugginito. Scavare buche è un po’ come aprire un
cassetto e frugarci dentro.
Dire terra è generico. Perché, sollevata la pelliccia, si può trovare un
sostrato scuro, umido, friabile, talmente cedevole da non opporre quasi
resistenza allo strappo. Ma anche: una materia giallina dura e
translucida. Oppure: una sorta di sabbione cedevole, granuloso, dove
l’acqua fugge. La mia terra è fatta così: con la pioggia, diventa cedevole
come burro, facile da spezzettare con le mani, d’aspetto dolcemente
malleabile. Quasi verrebbe voglia di lasciar perdere la pianta e
plasmare invece la terra. È solo un pensiero mentre continuo a scavare.
La buca bisogna che sia più ampia del vaso: almeno quattro volte tanto.
E profonda il doppio. Mi piace questo sentirmi forte grazie alla terra che
non oppone resistenza. La buca cresce e io non duro nessuna fatica.
Adesso di terra ne ho ammonticchiata abbastanza, la buca basta e
avanza. Ancora qualche colpetto alle pareti col taglio della lama: così le
radici troveranno fessure in cui infilarsi per iniziare le loro esplorazioni,
andare là dove io non guarderò probabilmente mai, provando
sensazioni che fatico a immaginare: una percezione di umidità in
direzione dello stagno, un sentore di ghiottoneria da uno scarabeo
morto, attraente cenere di legna, una saporita cacca di rondine, un
guscio vuoto di chiocciola. Con la vanga sminuzzo il fondo, sempre per
procurare passaggi facilitati alle radici, ma anche per miscelare la terra
alla manciata di concime gettato nella buca, e che è meglio non entri in
contatto con le radici: rischierebbe di bruciare quell’organo tanto
sensibile e intelligente.
Bene, adesso la buca è una meraviglia, merita ammirarla ancora un
poco perché la sua esistenza sarà breve: il tempo di infilarci la pianta,
ed eccola nuovamente riempita di terra.
Il bello di non avere altre buche da scavare è che questa me la posso
proprio godere. Posso fare le cose a regola d’arte, senza fretta e quasi
senza fatica. Scavare una sola buca, quando la terra è al punto giusto
di morbidezza e l’aria tiepida, non sgomenta di certo. Prendo la piantina
– è una Lonicera fragrantissima –, allineo il colletto con il terreno, e per
invogliarla a iniziare le sue esplorazioni sotterranee, verso in fondo alla
buca un secchio di terriccio nutriente preso nel mucchio del compost
dell’anno scorso, perfettamente sciolto e inodore, talmente leggero da
parere torba di palude. Sullo strato di compost maturo adagio la
Lonicera estratta delicatamente dal vaso: un’innaffiatura prima, un
colpetto di vanga poi, ed eccola uscire come un budino scivolato senza
incrinature dallo stampo. A lato del pane di terra, la canna che serve da
promemoria l’estate, quando ci sarà da innaffiare la nuova venuta, e
anche per non rischiare di investirla col tosaerba, quando scomparirà
nel fieno alto.
Tutto intorno, riempio del terriccio ammucchiato da una parte, premo
con le mani, spargo ancora una spolverata di stallatico sciolto, pesto
con le suole per non lasciare buchi d’aria. Per ultimo, innaffio.
Innaffiare per la prima volta una pianta appena trasferita nella sua
nuova dimora è sempre emozionante. Qualcosa tra un gesto di
benvenuto e una benedizione. Sono sicura che, senza questa prima
irrorazione, tutto resterebbe fermo, come in certe fiabe dove un
sortilegio inceppa il libero scorrere delle energie. Lasciar colare una
doccia lieve dalla bocchetta bucherellata dell’innaffiatoio è come
mettere in moto una nuova vita: invitare le foglie a disporsi nella giusta
angolazione rispetto al sole, perché d’ora in poi sarà qui che vivranno,
senza più spostamenti subiti come accadeva nella loro precedente
esistenza nomade di piante in vaso. Anche le radici si possono
sgranchire, smetterla di girare in tondo come prima, costrette dalle
pareti del vaso. Sono finalmente libere di allungarsi con cognizione di
causa, crescere animate dall’allegria di uno scopo.
Mentre verso l’acqua, anche a me pare, con lo scavo della buca –
che poi è la costruzione della casa per questa nuova pianta – di avere
guadagnato una prospettiva sul mondo. Ricopro tutto intorno, là dove la
terra è rimasta nuda, di foglie secche e di paglia. Mentre, con vanga e
zappa in spalla e il vaso vuoto in mano, torno verso il capanno degli
attrezzi, provo la sensazione rassicurante di avere anch’io traslocato da
una sistemazione provvisoria. Quasi che, adesso, avessi pure io dove
mettere radice.
Potare
Un mio amico, grande conoscitore delle rose, mi ha confessato che
nulla gli dà piacere quanto potare. Lo ha detto con un sorrisetto un
tantino sadico – e questo mi ha fatto riflettere che potare è un po’ anche
amputare. Mi auguro che, diversamente dai pruni e dagli sterpi della
selva dei suicidi nel settimo girone, le piante non provino dolore quando
tagliamo loro qualche arto o le riduciamo a quelle che noi consideriamo
la giusta forma e le dimensioni appropriate.
Forse in molti di noi si cela uno scultore mancato. Nel potare, in
quell’allontanarsi per prendere la misura della pianta da regolare, e poi
nell’avvicinarsi con cesoie, segaccio e tronchetto, c’è qualcosa del
gesto dello scultore. Con questa differenza: una pietra o un pezzo di
legno inerte, una volta rovinati sono rovinati per sempre. Mentre con le
piante, si può sempre contare sulla loro capacità di riprendersi dalla
nostra imperizia. Non si spiegherebbe altrimenti la resistenza di certi
sfortunati platani cittadini alle crudeli capitozzature cui vengono
regolarmente assoggettati.
Resa ardita dalla capacità delle piante di sopravvivere ai
maltrattamenti, mi aggiro spavalda per il giardino. Un rametto fuori
posto viene prontamente tagliato con le cesoie, sempre al mio fianco
nella loro custodia. Stessa sorte riservata agli inopportuni polloni. Per i
rami più grossi tengo in tasca un geniale seghetto a serramanico. Cerco
di fare attenzione, per i rami grossi, a tagliare non raso tronco, ma là
dove la corteccia forma l’anello di rinnovo dei tessuti: in questo modo la
ferita si rimargina, e la pianta corre minori rischi di venire invasa da
inquilini abusivi.
È una cosa strana, potare: si sa quando si comincia, non quando si
finisce. Prendiamo la rosa Laure Davoust abbarbicata al pero da fiore.
Questa gigantessa proviene da un esile rametto da me tagliato in un
convento abbandonato di Sillicagnano, e lasciato poi ad attecchire in un
vaso. In breve tempo si è spinta fino in cima al pero.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :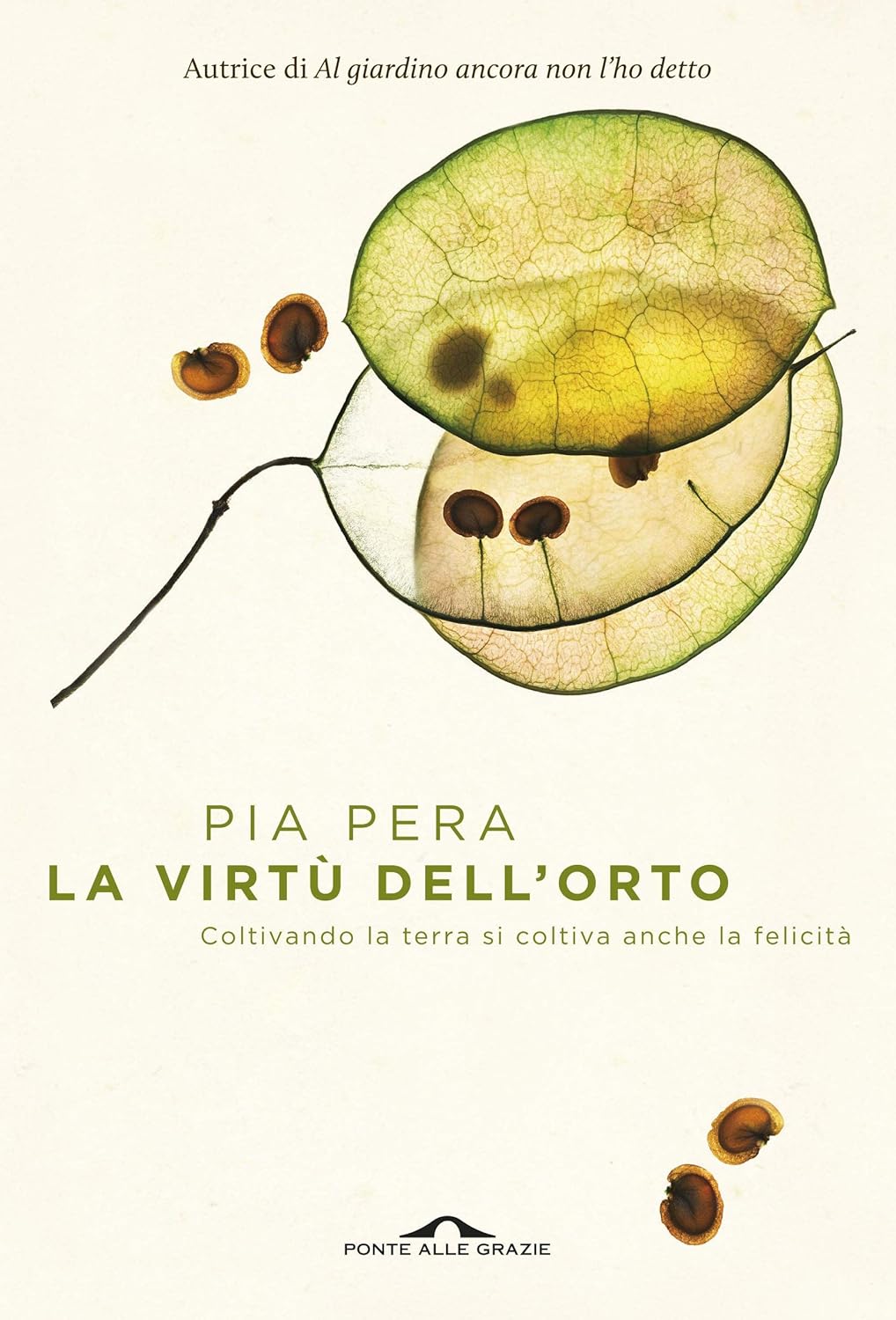






Commento all'articolo