La grande storia della Resistenza – Gianni Oliva
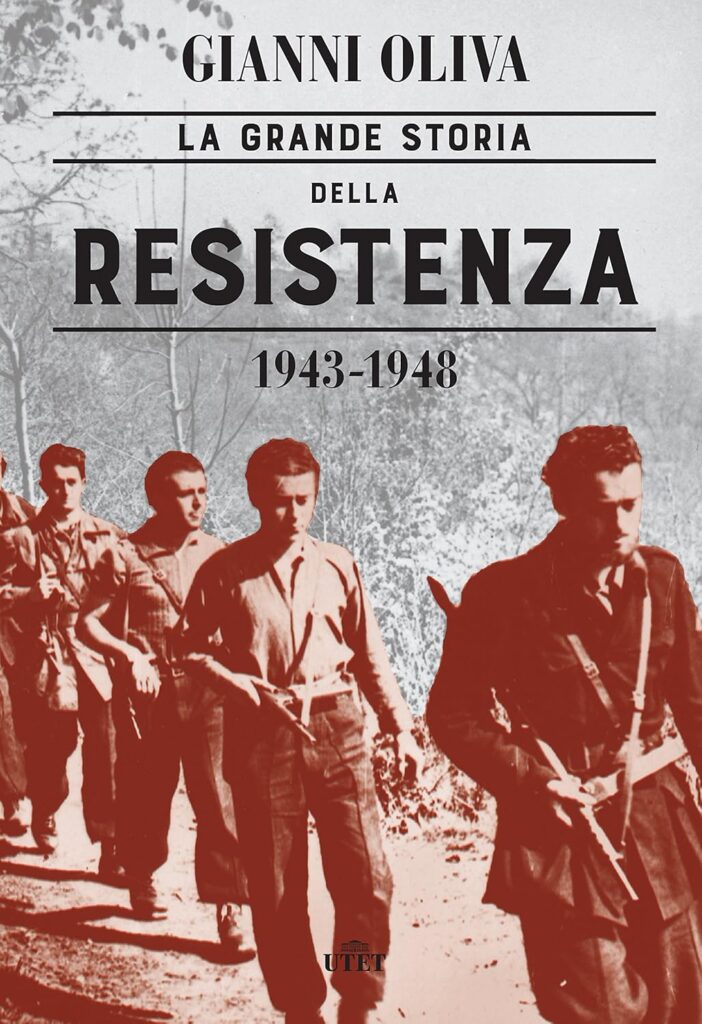
SINTESI DEL LIBRO:
L’immagine che più comunemente si collega al 25 luglio è filtrata dalla
rappresentazione letteraria: l’annuncio della caduta del regime assume i tratti
di una festa liberatoria, un’emozione incredula che si trasforma via via in
esplosione di entusiasmo e di fermento coinvolgendo tutta la popolazione
della Penisola. Nella rielaborazione di Cesare Pavese, la notizia
dell’esautoramento di Mussolini e della nomina di Badoglio a capo del
governo scuote all’improvviso la grande città industriale stremata dai
bombardamenti e dalla fame, e si diffonde in un rincorrersi fremente di voci,
di richiami, di balli per le strade, di falò sulle colline: «Vennero le notizie.
Fin dall’alba strepitarono le radio delle ville vicine: l’Egle ci chiamò in
cortile; la gente scendeva in città parlando forte. L’Elvira bussò alla mia
camera, e mi gridò attraverso la porta che la guerra era finita […]. Capivo
adesso i clamori notturni. Tutti correvano a Torino. Dalle ville sbucavano
facce e discorsi e gli occhi di tutti erano accesi, anche quelli preoccupati.
Cominciò quella ridda di incontri, di parole, di gesti, d’incredibili speranze,
che non doveva più cessare se non nel terrore e nel sangue. D’ora innanzi
anche la solitudine, anche i boschi, avrebbero avuto un diverso sapore».
1
In
modo analogo Corrado Alvaro coglie l’emozione popolare per le vie di
Roma: «C’erano donne del popolo, quelle che soffrono tutta la vita, che erano
vive e veramente felici per un giorno. Una, a Campo di Fiori, con un
bandierone tricolore urlava, ed era veramente la libertà, qualcosa di luminoso,
che saliva dalla sua sofferenza di povera donna. Una madre portava sulla
strada un bambino in fasce, dicendo: “Voglio che respiri quest’aria!”».
2
Nelle loro semplificazioni, le immagini letterarie colgono con efficacia un
tratto caratterizzante del 25 luglio: la spontaneità delle prime reazioni
popolari, che si sviluppano senza alcuna mediazione organizzativa. La gente
scende in piazza naturalmente, tra la sorpresa e il giubilo, spinta dall’urgenza
psicologica di confronto e di conferme. La notizia, affidata a due scarni
comunicati redatti in linguaggio burocratico e trasmessi dalla radio alle 22.45,
ha una forza dirompente e scuote la coscienza collettiva per inaugurare una
forma di partecipazione assai diversa da quelle delle adunate di regime: le
strade si riempiono di rumore, i crocchi si moltiplicano e diventano
assembramenti, gli assembramenti cortei. All’ordine geometrico
dell’inquadramento paramilitare subentra una confusione liberatoria nella
quale si esprimono le energie soffocate dall’atmosfera di guerra e in cui la
comunità riscopre una identità di gruppo solidale: «Il 25 luglio ci siamo
ritrovati», come ha scritto Piero Calamandrei.
3
Se sul piano letterario l’atmosfera di emozione è elemento in sé
esplicativo, la ricostruzione storica deve invece individuare la pluralità di
atteggiamenti che si possono cogliere all’interno della reazione popolare: ne
risulta un quadro ben altrimenti articolato, lo “spaccato” di un’Italia da
ricostruire, sospesa tra vecchie certezze e nuove sfide, dove il carattere di
fondo della spontaneità diventa chiave di lettura per comprendere i sottintesi
di un fenomeno storicamente straordinario proprio in quanto non mediato.
Il primo tratto rilevante è la cornice di lealismo monarchico entro il quale
si sviluppano le manifestazioni. I rapporti delle autorità sottolineano
dovunque l’adesione convinta alla scelta del re, il ricorrere di parole d’ordine
a favore di Vittorio Emanuele III, di Badoglio e dell’esercito, la comparsa di
scritte patriottiche sui muri. Il questore di Torino segnala «un’ondata di
entusiasmo seguita da manifestazioni inneggianti alla maestà del re e a casa
Savoia»; quello di Napoli, «il giubilo della maggioranza dei cittadini» perché
«a capo della vita politica nazionale è stato chiamato il maresciallo
Badoglio»; il prefetto di Savona telegrafa che «la folla ha percorso le
principali vie cittadine con in testa bandiera tricolore»; a Milano un membro
di casa Savoia viene coinvolto da una manifestazione svoltasi sotto Palazzo
Reale, dove «S.a.r. il conte di Torino, affacciatosi al balcone, ha rivolto alla
folla brevi parole»; a Reggio Emilia, un corteo di operai esce dalle officine
Reggiane con «bandiere tricolori e con cartelli riproducenti le effigi di sua
maestà il re e del maresciallo Badoglio».
4 Nell’immaginario collettivo, la
caduta di Mussolini non rappresenta solo un fatto di politica interna, per
quanto clamoroso e decisivo, ma la fine della guerra e di tutto quanto per tre
anni essa ha rappresentato. «Sul mezzogiorno», ha scritto Paolo Monelli,
«escono i primi reparti di forza pubblica e manifesti che invitano il popolo
alla calma. Ma per dodici ore il popolo abbandonato a se stesso ha dimostrato
un grande, un enorme, pacifico sollievo.»
5 Di questo “pacifico sollievo” il re
costituisce il garante: piuttosto che un atto rivoluzionario, la destituzione di
Mussolini si presenta come un mutamento radicale di indirizzo interno e
internazionale che si sviluppa entro una salda cornice di continuità dello
Stato. La monarchia, che ha congedato chi ha voluto l’alleanza con la
Germania nazista e la guerra, è elemento rassicurante di garanzia e di stabilità
e permette il recupero di una dimensione di “patria” nel quale ritrovare
l’identità nazionale, accomunando nord e sud, città e campagna in una stessa
emozione.
Accanto alle manifestazioni di lealismo patriottico si registrano esplosioni
di insofferenza popolare verso il passato regime, che spaziano dagli slogan
contro il Duce, alla devastazione delle sedi del Fascio: lungi dall’elidersi,
queste reazioni risultano complementari e ribadiscono il carattere di
spontaneità delle manifestazioni di piazza del 25 luglio. La tipologia delle
azioni descritte dalle autorità è ricorrente: all’interno dei cortei e degli
assembramenti, gli «elementi più facinorosi e sovversivi» (il lessico è quello
di funzionari che hanno costruito la loro carriera durate il Ventennio)
indicano obiettivi concreti su cui indirizzarsi e ne derivano invasioni di sedi,
distruzioni di simboli, roghi di materiale propagandistico, rimozioni di busti,
di ritratti, di bandiere. A Roma, nella notte tra il 25 e il 26 luglio, tredici sedi
del partito nazionalfascista vengono devastate e saccheggiate; a Torino gli
obiettivi sono la Casa Littoria e la sede della “Gazzetta del Popolo”; a Milano
il “covo” del Fascio primigenio del 1919. In altri casi (e sono i più numerosi)
l’azione si limita alla distruzione delle effigi e a slogan di denuncia dei
profitti illeciti (a Cosenza, per esempio, i manifestanti gridano «viva il re,
abbasso Mussolini, abbasso i consumatori di prosciutto»). In alcuni piccoli
centri del sud, all’invasione della Casa del Fascio si accompagnano la
devastazione delle sedi comunali e la distruzione dei ruolini delle imposte e
delle carte degli ammassi, a documento della stretta intollerabile esercitata
dal regime economico di guerra sulle masse contadine del Mezzogiorno.
Non è difficile scorgere in questo secondo aspetto delle manifestazioni
una volontà prepolitica di rimuovere il passato e di sanzionare materialmente
la fine del regime, che nella distruzione dei simboli trova una forma
elementare di espressione. Nel loro porsi sul terreno dell’iniziativa e
dell’azione violenta, queste reazioni presuppongono tuttavia un livello di
tensione che non è uniforme su tutto il territorio nazionale: alla
determinazione dei grandi centri urbani del Centronord e di alcuni piccoli
borghi agricoli del Mezzogiorno, corrisponde la relativa calma di altre aree.
«Compostezza della popolazione» a Bari, «nessuna manifestazione lesiva
dell’ordine pubblico» a Pavia, «operai regolarmente al lavoro» a Varese,
«nessun incidente contro sedi del fascio» a L’Aquila. Il risultato è una mappa
disomogenea, che rinvia ai contorni di un’Italia frastagliata, dove la realtà
locale risulta determinante nel produrre attitudini e reazioni e nel trasferire
l’emozione dal terreno dell’esultanza per la pace a quello dell’iniziativa
contro il regime appena caduto.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :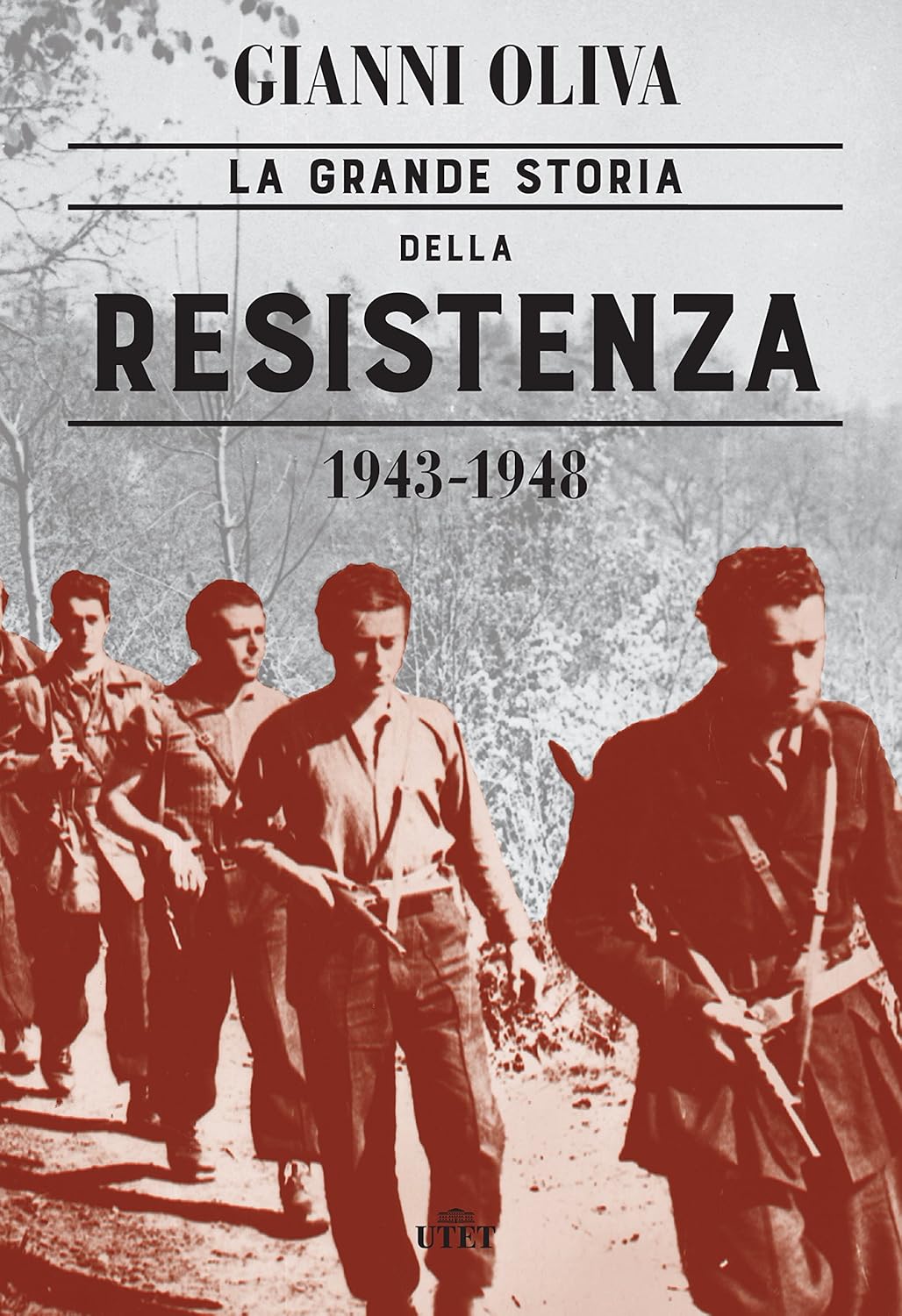






Commento all'articolo