La famiglia Manzoni – Natalia Ginzburg
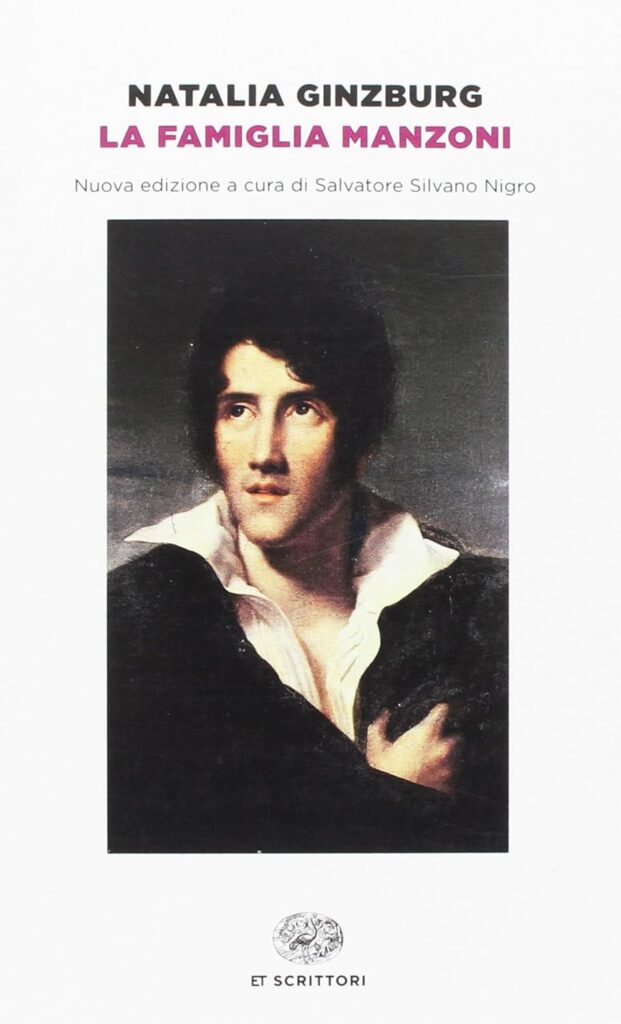
SINTESI DEL LIBRO:
Alcune lettere, nell'originale, sono in francese, e sono state
tradotte da me.
Avrei preferito poterle lasciare in francese.
Però allora, una parte del libro sarebbe stata in francese.
Sono in francese nell'originale, tutte le lettere di Manzoni a Fauriel e
di Fauriel a Manzoni, salvo la prima di Manzoni a Fauriel, che è in
italiano.
Sono in francese tutte le lettere indirizzate a Fauriel, da Giulia, da
Giulietta e cosí via, salvo quelle che gli scrive Ermes Visconti.
Sono sempre in francese le lettere di Enrichetta.
Quelle che scrive alla figlia Vittoria in collegio sono state tradotte da
Michele Scherillo.
E in francese la lettera di Giulietta alla sorella Cristina, da Andeer.
E in francese la lettera di Giulietta al padre, dal castello d'Azeglio.
E in francese la lettera di Giulia all'amica Euphrosine Planta.
E in francese la lettera di Teresa alla zia Notburga.
Questo libro vuole essere un tentativo di ricostruire e ricomporre
per disteso la storia della famiglia Manzoni, attraverso le lettere, e le
cose che se ne sanno.
E una storia che esiste sparpagliata in diversi libri, per lo più
introvabili dai librai.
E tutta cosparsa di vuoti, di assenze, di zone oscure, come
d'altronde ogni storia famigliare che si cerchi di rimettere insieme.
Tali vuoti e assenze sono incolmabili.
Non avevo mai scritto un libro di questo genere, dove occorrevano
altri libri, e documenti.
Avevo scritto romanzi nati dall'invenzione o da ricordi miei, e dove
non mi occorreva nulla, e nessuno.
Cosí devo ringraziare qui alcune persone, che mi sono state d'aiuto.
Devo ringraziare Donata Chiomenti Vassalli.
Come prima cosa ho letto il suo libro, Giulia Beccaria, pubblicato vari
anni fa da Ceschina e non mai ristampato, il diavolo sa perché.
Devo ringraziarla per il suo libro che è molto bello.
Poi devo ringraziarla di avermi ascoltato, imprestato libri, indicato
alcune vie da seguire.
Devo ringraziare Cesare Garboli di avermi ascoltato, indicato alcune
vie da seguire, e della sua consueta, grande, ir,ascibile e generosa
pazlenza.
Ringrazio inoltre la signora Letizia Pecorella e la signorina Maria De
Luca della Biblioteca Braidense, la signoraJone Caterina Riva del
Centro di studi manzoniani, a Milano, e, a Roma, la signora
Annamaria Giorgetti Vichi, direttrice della Biblioteca Nazionale, e
Alessandro Florio.
Essi mi hanno aiutato in maniere varie e diverse: dandomi il modo di
leggere libri e lettere.
Infine ringrazio Enrica Melossi e Augusta Tosone, che hanno curato
la parte illustrativa.
Dedico questo libro alla mia amica Dinda Gallo.
Lei sapeva tutto sulla famiglia Manzoni e io nulla.
Sentivo solo una rozza curiosità per quel destino famigliare.
Parlando con lei m'è venuto il desiderio di conoscerlo piú a fondo e
piú da vicino.
Cosí, via via che scrivevo, le portavo da leggere gruppi di pagine.
Ha condiviso con me perplessita e incertezze.
Ha condiviso con me i1 dispiacere per I VUOti e le assenze.
Mi ha guidato e accompagnato, generosamente.
Ha camminato con me.
Se non ci fosse stata, questo libro non l'avrei scritto, perciò lo dedico
a lei.
_ -a
2 ' °-- e
Prima parte 1762-1836
Giulia Beccaria Giulia Beccaria 13
Giulia Beccaria aveva i capelli rossi e gli occhi verdi.
Nacque a Milano nel 1762.
Suo padre era Cesare Beccaria e sua madre Teresa de Blasco.
Suo padre era di famiglia nobile, sua madre era figlia d'un
colonnello.
Il matrimonio era stato aspramente contrastato.
I due avevano difficoltà di denaro, ma vissero sempre in maniera
dispendiosa.
Cesare Beccaria scrisse in età giovanissima un libro che gli diede
gloria, Dei delitti e delle_ene.
Teresa era nera di capelli e gracile.
Divenne amante d'un ricco, certo Calderara.
Un amico di casa era Pietro Verri, economista, filosofo, amante
d'una sorella di Cesare.
Fra Verri e i due Beccaria i rapporti furono sempre quanto mai
tempestosi, l'amicizia si rompeva e si riallacciava.
Giulia aveva quattro anni quando le nacque una sorella, Marietta.
In quello stesso anno, la madre s'ammalò di mal celtico.
Ma seguitò tuttavia a viaggiare e a far vita mondana.
Mise al mondo poi anche un maschio, che morí subito.
Il padre voleva molto un maschio.
Giulia e la sorella crescevano in mano ai servi, perché la madre,
benché malata, era sempre in viaggio.
Nel 17 74, la madre morí del suo male, fra sofferenze atroci.
Il padre era disperato.
Il giorno stesso ch'era morta, volle che venisse fatto l'inventario dei
suo molti vestiti e gioielli.
Chiamò a sé le due bambine e disse «è tutto vostro».
Si stringeva a loro piangendo.
Ma quei vestiti e gioielli, le bambine non li rividero mai.
Egli se ne andò a piangere nella ricca villa dell'amante della moglie,
Calderara.
Le bambine restarono a casa coi servi.
Calderara, con grande meraviglia, lo vide pochi giorni dopo farsi
arricciare i capelli dal parrucchiere.
Egli disse a Calderara: «Voglio mantenere un buon aspet 14 Prima
parte
to».
Quaranta giorni dopo i funerali della moglie, si fidanzò con una
donna bella e ricca, certa Anna Barbò.
La sposò passati tre mesi.
Ebbe con lei, finalmente, il figlio maschio che desiderava.
Giulia intanto era stata chiusa in convento.
Marietta rimase in casa perché di salute gracile, rachitica e gobba.
Le fu messo un busto di ferro e fu affidata alla servitú.
Giulia in convento venne totalmente dimenticata.
I nonni paterni erano morti e uno zio materno, che la amava, era in
quegli anni assente dall'Italia, risiedeva in Brasile.
Il solo a ricordarsi di Giulia era Pietro Verri.
Veniva qualche volta a visitarla in parlatorio.
Quando essa ebbe diciotto anni, Pietro Verri sollecitò il padre perché
la riprendesse a casa.
Giulia era molto bella, robusta, intelligente e di carattere forte.
Subito ebbe violenti contrasti col padre.
Poi s'innamorò di Giovanni Verri, fratello minore di Pietro, cavaliere
di Malta, uomo sfaccendato, elegante, dai tratti femminei.
Però di un matrimonio fra i due non era il caso di parlare.
Non ci pensavano né i Verri, né il padre di lei.
Giulia non era ricca.
Pietro Verri allora e Cesare Beccaria si guardarono attorno e
posarono gli occhi su un certo Don Pietro Manzoni, gentiluomo di
campagna, vedovo senza figli, quarantaseienne, non ricco ma con
una modesta sostanza.
Aveva una proprietà nei pressi di Lecco, chiamata il Caleotto, dove
soggiornava d'estate.
D'inverno stava a Milano in una casa sui Navigli, in via San
Damiano.
Egli si mostrò arrendevole riguardo alla dote.
Cosí fu concertato rapidamente questo matrimonio.
Giulia non voleva che uscir di casa.
Don Pietro Manzoni viveva con sette sorelle nubili, una deUe quali
ex monaca, e aveva un fratello Monsignore, canonico al Duomo.
Giulia fu subito molto infelice.
Litigava col marito e le cognate le si mostravano ostili.
La casa sui Navigli era brutta, piccola, umida e buia.
Il marito le sembrava una misera persona, senza ingegno, senza
grandi ricchezze e senza prestigio.
Era conservatore e clericale e lei aveva respirato, sia nella casa
paterna sia nella famiglia Verri, idee nuove e libere.
S'annoiava perdutamente.
Non smise di frequentare Giovanni Verri e la bella casa dei Verri,
festosa e sempre piena di ospiti.
Condusse una vita brillante suscitando nei cognati un'awersione
sempre piú palese, e nel marito l'impulso a spiarla.
Tre anni dopo il matrimonio, il 7 di marzo del 1785, essa mise al
mondo il suo primo e unico figlio, Alessandro.
Gli venne messo nome Alessandro in memoria del padre dei
Manzoni.
Fu battezzato nella chiesa di San Babila.
Nessuno era contento che fosse nato.
Fra Giulia e il marito i contrasti divennero piú aspri.
La gente mormorava.
Il bambino venne subito mandato a balia, a Malgrate, nei dintorni di
Lecco.
Giulia riprese la vita di prima.
Era però stanca di Giovanni Verri e lui era stanco di lei.
Essa ebbe una relazione con un certo Taglioretti.
Alessandro intanto cresceva nella casa della balia, una casa di
contadini, e aveva l'affetto della balia e dei suoi numerosi parenti.
Molto di rado la madre veniva a trovarlo.
Poi fu riportato a Milano, ma tornava sempre dalla balia per lunghe
stagioni.
Il pittore Andrea Appiani fece un ritratto a Giulia col bambino.
Nel ritratto, Giulia è vestita da amazzone.
Ha una faccia dura, ossuta e stanca.
Guarda nel vuoto.
Nessuna visibile tenerezza materna per quel bambino che le sta
appoggiato al ginocchio.
Il bambino ha quattro anni.
Giulia regalò il ritratto a Giovanni Verri.
Fu in quel tempo che essa conobbe Carlo Imbonati.
Lo conobbe nel salotto d'una sorella di lui, che era stata sua
compagna di scuola, in convento.
Esiste di Giulia un secondo ritratto, dipinto non molti anni dopo
quello di Appiani dov'è col bambino.
Questo secondo ritratto è opera d'una pittrice di nome Cosway, e fu
dipinto a Parigi, dove Giulia già viveva con Imbonati e dove era
felice.
Qui ha un cappellino bianco e un velo.
Il naso è sottile, la bocca lievemente sorridente d'una vaga arguzia.
Sembra molto giovane.
Gli anni e l'amarezza le sono caduti dal viso.
Carlo Imbonati era di famiglia ricca e nobile.
Ragazzo, aveva avuto come precettore Parini.
Adulto, soggiornò lungo tempo all'estero.
Era appena tornato in Italia quando lui e Giulia s'incontrarono.
Diventarono amanti.
Giulia prontamente decise di separarsi dal marito.
L'amore le dava forza e desiderio di chiarezza.
Quando era legata a Giovanni Verri non aveva pensato a chiedere la
separazione, sentendosi senza 16 Prima par_e
sostegno né morale né materiale, e sentendosi contagiata dalla
mollezza dell'altro.
Adesso tutto era cambiato.
Scrisse a Pietro Verri.
Egli era la persona che veniva a trovarla, in convento, quando non
veniva nessuno; e qualche appoggio glielo aveva dato; anche se poi
s'era trattato d'un appoggio ben discutibile, poiché, in complicità col
padre di lei, l'aveva guidata a quello sventurato matrimonio.
Gli scrisse: «Assolutamente non mi è possibile convivere in una
famiglia animata tutta contro di me.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :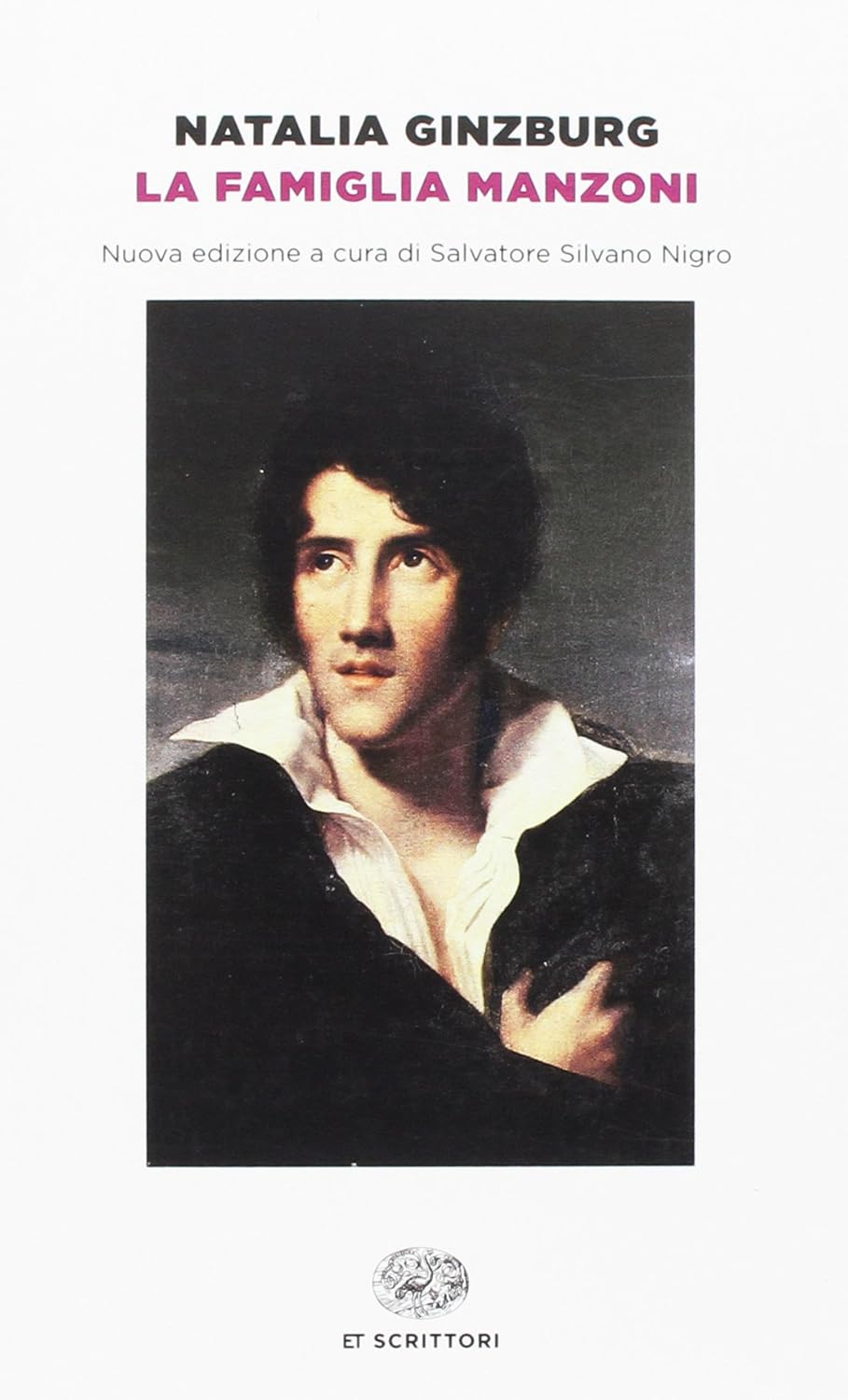






Commento all'articolo