La casa in collina – Cesare Pavese
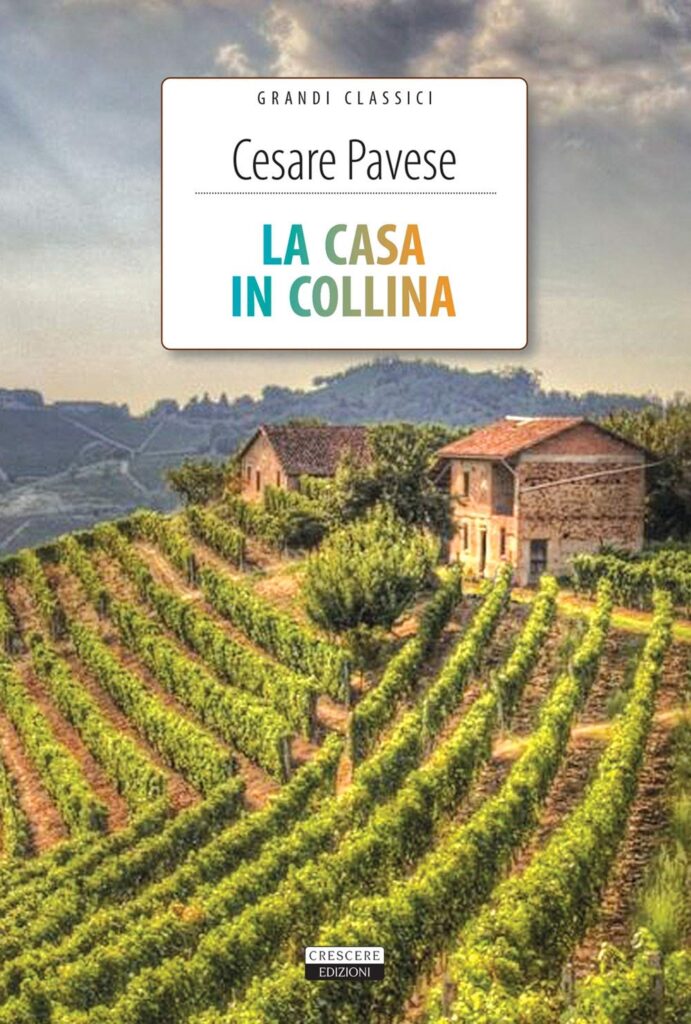
SINTESI DEL LIBRO:
Già in altri tempi si diceva la collina come avremmo detto il mare
o la boscaglia. Ci tornavo la sera, dalla città che si oscurava, e per
me non era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose, un modo
di vivere. Per esempio, non vedevo differenza tra quelle colline e
queste antiche dove giocai bambino e adesso vivo: sempre un
terreno accidentato e serpeggiante, coltivato e selvatico, sempre
strade, cascine e burroni. Ci salivo la sera come se anch’io fuggissi il
soprassalto notturno degli allarmi, e le strade formicolavano di gente,
povera gente che sfollava a dormire magari nei prati, portandosi il
materasso sulla bicicletta o sulle spalle, vociando e discutendo,
indocile, credula e divertita.
Si prendeva la salita, e ciascuno parlava della città condannata,
della notte e dei terrori imminenti. Io che vivevo da tempo lassú, li
vedevo a poco a poco svoltare e diradarsi, e veniva il momento che
salivo ormai solo, tra le siepi e il muretto. Allora camminavo
tendendo l’orecchio, levando gli occhi agli alberi familiari, fiutando le
cose e la terra. Non avevo tristezze, sapevo che nella notte la città
poteva andare tutta in fiamme e la gente morire. I burroni, le ville e i
sentieri si sarebbero svegliati al mattino calmi e uguali. Dalla finestra
sul frutteto avrei ancora veduto il mattino. Avrei dormito dentro un
letto, questo sí. Gli sfollati dei prati e dei boschi sarebbero ridiscesi
in città come me, solamente piú sfiancati e intirizziti di me. Era
estate, e ricordavo altre sere quando vivevo e abitavo in città, sere
che anch’io ero disceso a notte alta cantando o ridendo, e mille luci
punteggiavano la collina e la città in fondo alla strada. La città era
come un lago di luce. Allora la notte si passava in città. Non si
sapeva ch’era un tempo cosí breve. Si prodigavano amicizia e
giornate negli incontri piú futili. Si viveva, o cosí si credeva, con gli
altri e per gli altri.
Devo dire – cominciando questa storia di una lunga illusione –
che la colpa di quel che mi accadde non va data alla guerra. Anzi la
guerra, ne sono certo, potrebbe ancora salvarmi. Quando venne la
guerra, io da un pezzo vivevo nella villa lassú dove affittavo quelle
stanze, ma se non fosse che il lavoro mi tratteneva a Torino, sarei
già allora tornato nella casa dei miei vecchi, tra queste altre colline.
La guerra mi tolse soltanto l’estremo scrupolo di starmene solo, di
mangiarmi da solo gli anni e il cuore, e un bel giorno mi accorsi che
Belbo, il grosso cane, era l’ultimo confidente sincero che mi restava.
Con la guerra divenne legittimo chiudersi in sé, vivere alla giornata,
non rimpiangere piú le occasioni perdute. Ma si direbbe che la
guerra io l’attendessi da tempo e ci contassi, una guerra cosí insolita
e vasta che, con poca fatica, si poteva accucciarsi e lasciarla
infuriare, sul cielo delle città, rincasando in collina. Adesso
accadevano cose che il semplice vivere senza lagnarsi, senza quasi
parlarne, mi pareva un contegno. Quella specie di sordo rancore in
cui s’era conchiusa la mia gioventú, trovò con la guerra una tana e
un orizzonte.
Di nuovo stasera salivo la collina; imbruniva, e di là dal muretto
sporgevano le creste. Belbo, accucciato sul sentiero, mi aspettava al
posto solito, e nel buio lo sentivo uggiolare. Tremava e raspava. Poi
mi corse addosso saltando per toccarmi la faccia, e lo calmai, gli
dissi parole, fin che ricadde e corse avanti e si fermò a fiutare un
tronco, felice. Quando s’accorse che invece di entrare sul sentiero
proseguivo verso il bosco, fece un salto di gioia e si cacciò tra le
piante. È bello girare la collina insieme al cane: mentre si cammina,
lui fiuta e riconosce per noi le radici, le tane, le forre, le vite
nascoste, e moltiplica in noi il piacere delle scoperte. Fin da ragazzo,
mi pareva che andando per i boschi senza un cane avrei perduto
troppa parte della vita e dell’occulto della terra.
Non volevo rientrare alla villa prima che fosse sera avanzata,
giacché sapevo che le padrone mie e di Belbo mi attendevano al
solito per farmi discorrere, per farsi pagare le cure che avevano di
me e la cena fredda e l’affabilità, con le tortuose e sbrigative opinioni
sulla guerra e sul mondo che serbavo per il prossimo. Qualche volta
un nuovo caso della guerra, una minaccia, una notte di bombe e di
fiamme, dava alle due donne argomento per affrontarmi sulla porta,
nel frutteto, intorno al tavolo, e cianciare stupirsi esclamare, tirarmi
alla luce, sapere chi ero, indovinarmi uno di loro. A me piaceva
cenar solo, nella stanza oscurata, solo e dimenticato, tendendo
l’orecchio, ascoltando la notte, sentendo il tempo passare. Quando
nel buio sulla città lontana muggiva un allarme, il mio primo sussulto
era di dispetto per la solitudine che se ne andava, e le paure, il
trambusto che arrivava fin lassú, le due donne che spegnevano le
lampade già smorzate, l’ansiosa speranza di qualcosa di grosso. Si
usciva tutti nel frutteto.
Delle due preferivo la vecchia, la madre, che nella mole e negli
acciacchi portava qualcosa di calmo, di terrestre, e si poteva
immaginarla sotto le bombe come appunto apparirebbe una collina
oscurata. Non parlava gran che, ma sapeva ascoltare. L’altra, la
figlia, una zitella quarantenne, era accollata, ossuta, e si chiamava
Elvira. Viveva agitata dal timore che la guerra arrivasse lassú.
M’accorsi che pensava a me con ansia, e me lo disse: pativa
quand’ero in città, e una volta che la madre la canzonò in mia
presenza, Elvira rispose che, se le bombe distruggevano un altro po’
di Torino, avrei dovuto star con loro giorno e notte.
Belbo correva avanti e indietro sul sentiero e m’invitava a
cacciarmi nel bosco. Ma quella sera preferii soffermarmi su una
svolta della salita sgombra di piante, di dove si dominava la gran
valle e le coste. Cosí mi piaceva la grossa collina, serpeggiante di
schiene e di coste, nel buio. In passato era uguale, ma tanti lumi la
punteggiavano, una vita tranquilla, uomini nelle case, riposo e
allegrie. Anche adesso qualche volta si sentivano voci scoppiare,
ridere in lontananza, ma il gran buio pesava, copriva ogni cosa, e la
terra era tornata selvatica, sola, come l’avevo conosciuta da
ragazzo. Dietro ai coltivi e alle strade, dietro alle case umane, sotto i
piedi, l’antico indifferente cuore della terra covava nel buio, viveva in
burroni, in radici, in cose occulte, in paure d’infanzia. Cominciavo a
quei tempi a compiacermi in ricordi d’infanzia. Si direbbe che sotto ai
rancori e alle incertezze, sotto alla voglia di star solo, mi scoprivo
ragazzo per avere un compagno, un collega, un figliolo. Rivedevo
questo paese dov’ero vissuto. Eravamo noi soli, il ragazzo e me
stesso. Rivivevo le scoperte selvatiche d’allora. Soffrivo sí ma col
piglio scontroso di chi non riconosce né ama il prossimo. E
discorrevo discorrevo, mi tenevo compagnia. Eravamo noi due soli.
Di nuovo quella sera saliva dalla costa un brusío di voci,
frammisto di canti. Veniva dall’altro versante, dove non ero mai
disceso, e pareva un richiamo d’altri tempi, una voce di gioventú. Mi
ricordò per un momento le comitive di fuggiaschi che la sera, come
gitanti, brulicavano sui margini della collina. Ma non si spostava,
usciva sempre dallo stesso luogo. Era strano pensare che sotto il
buio minaccioso, davanti alla città ammutolita, un gruppo, una
famiglia, della gente qualunque, ingannassero l’attesa cantando e
ridendo. Non pensavo nemmeno che ci volesse coraggio. Era
giugno, la notte era bella sotto il cielo, bastava abbandonarsi; ma,
per me, ero contento di non avere nei miei giorni un vero affetto né
un impaccio, di essere solo, non legato con nessuno. Adesso mi
pareva di aver sempre saputo che si sarebbe giunti a quella specie
di risacca tra collina e città, a quell’angoscia perpetua che limitava
ogni progetto all’indomani, al risveglio, e quasi quasi l’avrei detto, se
qualcuno avesse potuto ascoltarmi. Ma soltanto un cuore amico
avrebbe potuto ascoltarmi.
Belbo, piantato sul ciglione, latrava contro le voci. Lo strinsi per il
collare, lo feci tacere, e ascoltai meglio. Tra le voci avvinazzate ce
n’erano di limpide, e perfino una di donna. Poi risero, si
scompigliarono, e salí una voce isolata di uomo, bellissima.
Stavo già per tornare sui miei passi, quando dissi a me stesso:
«Sei scemo. Le due vecchie ti aspettano. Lascia che aspettino».
Nel buio cercavo d’indovinare il sito preciso dei cantori. Dissi:
«Magari sono gente che conosci». Presi Belbo e gli feci segno verso
l’altro versante. Mormorai sottovoce una frase del canto e gli dissi: –
Andiamo là –. Lui sparí con un balzo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :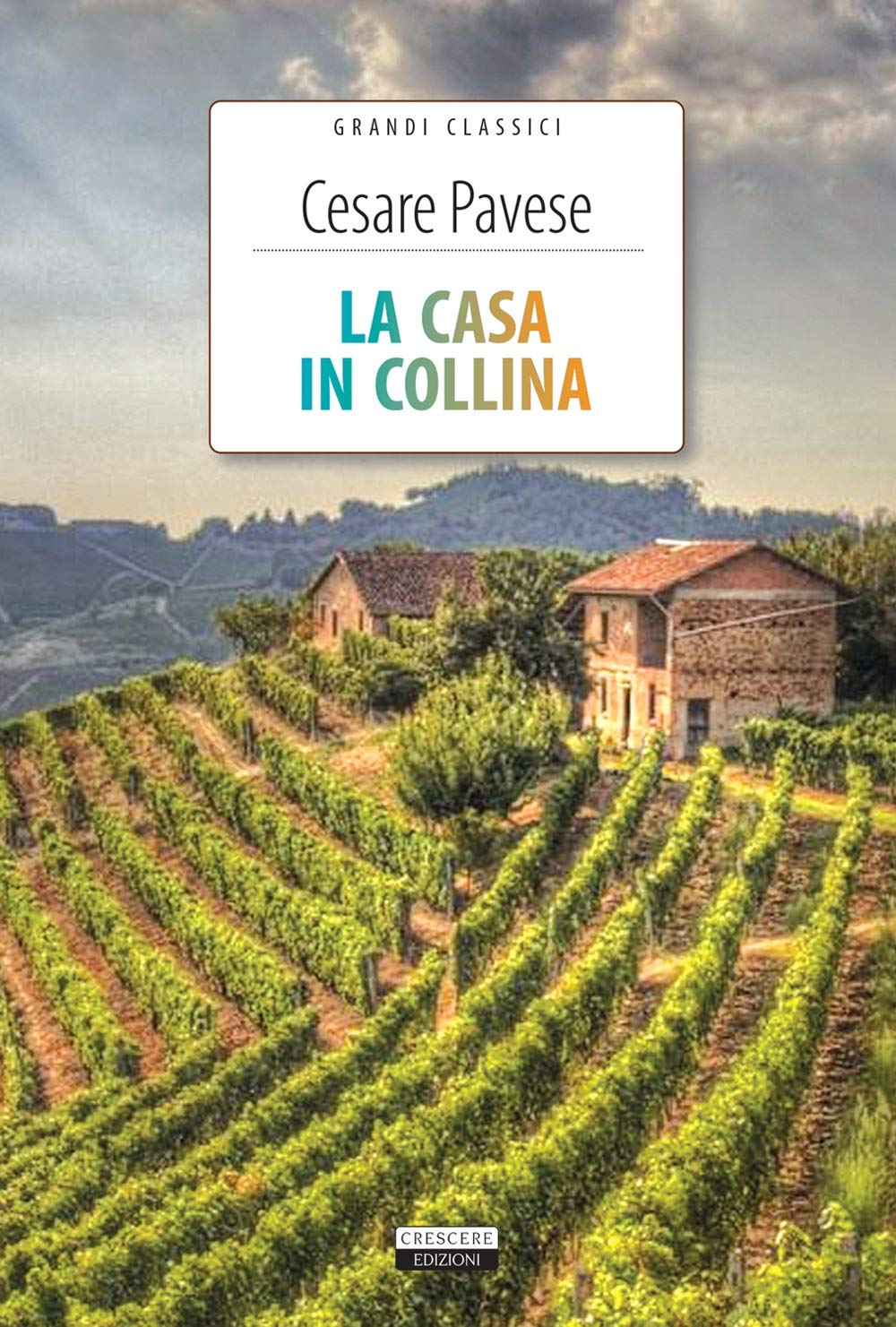






Commento all'articolo