La casa di carta – Carlos Maria Dominguez
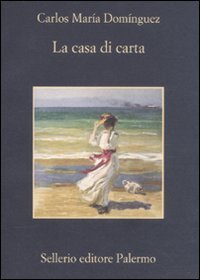
SINTESI DEL LIBRO:
Nella primavera del 1998 Bluma Lennon comprò in una libreria di
Soho una vecchia edizione delle poesie di Emily Dickinson e,
arrivata alla seconda poesia, al primo incrocio, fu investita da
un’automobile.
I libri cambiano il destino delle persone. Ci fu chi lesse I pirati della
Malesia e divenne professore di letteratura in remote università.
Demian condusse all’induismo decine di migliaia di giovani,
Hemingway ne fece degli sportivi, Dumas mandò all’aria la vita di
migliaia di donne, e non poche scamparono al suicidio grazie ai
manuali di cucina. Bluma ne fu vittima.
Ma non fu l’unica. Il vecchio professore di lingue classiche
Léonard Wood rimase emiplegico ricevendo sulla testa cinque
volumi dell’Enciclopedia Britannica crollati insieme a un ripiano della
sua libreria; il mio amico Richard si ruppe una gamba nel tentativo di
raggiungere Assalonne, Assalonne! di William Faulkner che, mal
collocato su uno scaffale, causò la sua caduta dalla scala. Un altro
mio amico di Buenos Aires si ammalò di tubercolosi nei sotterranei di
un archivio pubblico e conobbi un cane cileno che morì di
indigestione dopo aver divorato I fratelli Karamazov in un pomeriggio
di furia.
Ogni volta che mi vedeva leggere a letto, mia nonna mi diceva:
«Smettila, che i libri sono pericolosi». Per anni fui convinto della sua
ignoranza, ma il tempo ha dimostrato l’assennatezza della mia
nonna tedesca.
Le esequie di Bluma richiamarono molti nomi illustri dell’università
di Cambridge. Alla cerimonia funebre il professor Robert Laurel le
dedicò un superbo commiato, poi pubblicato in plaquette in
considerazione del suo valore accademico. Delineò la brillante
carriera di Bluma, i suoi quarantacinque anni di sensibilità e
intelligenza e ricordò, nel corpo principale del lavoro, i suoi decisivi
contributi allo studio dell’influenza anglosassone sulla letteratura
latinoamericana. Ma concluse con una frase controversa: «Bluma
consacrò la sua vita alla letteratura» disse, «senza immaginare che
la letteratura l’avrebbe portata via da questo mondo».
Quanti lo accusarono di aver rovinato il suo discorso con un «vieto
artificio retorico» dovettero vedersela con l’acerrima difesa dei suoi
assistenti. Pochi giorni dopo, in casa della mia amica Anny, sentii
dire a John Bernon, dinanzi a un gruppo di discepoli di Laurel:
«A ucciderla è stata un’automobile. Non la poesia».
«Nulla esiste al di là della sua rappresentazione» argomentarono
due ragazzi e una ragazza ebrea, che sembrava la più agguerrita.
«Ognuno ha il diritto di scegliere la rappresentazione che
preferisce».
«E di fare cattiva letteratura. D’accordo» replicò il vecchio col
sorriso falsamente conciliante che gli aveva guadagnato fama di
cinico nella facoltà, ora in subbuglio per l’imminente assegnazione di
una cattedra postlaurea alla quale lui concorreva insieme a Laurel.
«Ci saranno un milione di paraurti a piede libero per le vie della città,
ciascuno perfettamente in grado di dimostrarvi di cosa è capace un
buon sostantivo».
Le polemiche sulla famosa frase si estesero all’intera università e
fu indetto un torneo studentesco intitolato «Rapporti fra realtà e
linguaggio». Fu calcolato il numero dei passi di Bluma su quel
marciapiede di Soho, il numero dei versi che poteva aver letto, la
velocità del veicolo che l’aveva travolta; furono discussi con zelo gli
aspetti semiotici del traffico a Londra e il contesto urbano, culturale e
linguistico dell’attimo in cui la letteratura e il mondo si erano abbattuti
sul corpo della povera Bluma. A me toccò sostituirla al dipartimento,
occupare il suo studio e tenere i suoi corsi, per nulla sedotto dalla
piega che avevano preso le discussioni.
Una mattina ricevetti una busta indirizzata alla mia defunta
collega. Recava francobolli e timbri uruguayani, e se non fosse stato
per la mancanza di indicazioni sul mittente avrei pensato contenesse
uno dei volumi pubblicati a spese dell’autore che molti inviavano a
Bluma nella speranza che lei li recensisse su qualche rivista
accademica. Lei non lo faceva mai, a meno che l’autore non fosse
abbastanza noto da poterne ricavare qualche beneficio. In genere mi
pregava di portarli nel magazzino della biblioteca, non prima di avere
apposto sulla copertina la sigla UTC (Unlikely to consult: di
improbabile consultazione) che pareva condannarli per sempre.
In effetti era un libro, ma non del tipo che mi aspettavo. Appena lo
estrassi dalla busta provai un’istintiva apprensione. Mi alzai dalla
scrivania, chiusi la porta e tornai a osservare quel vecchio e
sconquassato esemplare della Linea d’ombra. Sapevo che Bluma
stava scrivendo un saggio su Joseph Conrad. Ma quel che mi
colpiva era la copertina, cui aderiva una crosta grigiastra. Dal taglio
delle pagine si staccavano particelle di cemento che sparsero un fine
pulviscolo sulla superficie specchiante della scrivania.
Tirai fuori un fazzoletto e catturai, perplesso, una minuscola
pietrolina. Era cemento, senza alcun dubbio, quel che restava della
malta che doveva aver aderito al libro con ben maggiore solidità
prima di essere deliberatamente rimossa.
Non c’era lettera di accompagnamento nella busta, solo quel libro
malridotto che non mi decidevo a prendere in mano. Sollevando la
copertina con due dita, scoprii sul frontespizio una dedica di Bluma.
Era la sua calligrafia, a inchiostro verde, fitta e rotonda, come in tutto
quel che Bluma scriveva, e non ebbi difficoltà a decifrarla: «Per
Carlos, questo romanzo che mi ha accompagnata di aeroporto in
aeroporto, come ricordo dei folli giorni di Monterrey. Mi dispiace,
sono un po’ strega e l’ho capito subito: tu non faresti mai nulla che
possa sorprendermi. 8 giugno 1996».
Conoscevo l’appartamento di Bluma, i cibi dietetici che teneva in
frigorifero, l’odore delle sue lenzuola, il profumo della sua biancheria
intima. A condividere il suo letto eravamo in tre, due docenti e uno
studente che si era infilato chissà come nella lista. E, come tutti,
sapevo di un viaggio di Bluma a Monterrey per un convegno, dove
probabilmente si era concessa uno di quei fugaci idilli che
confortavano la sua vanità, ormai minacciata dal dileguarsi della
gioventù, di ben due mariti e del sogno di discendere in canoa il Rio
Macondo, ossessione che le era rimasta dalla lettura di Cent’anni di
solitudine. Eppure, perché quel libro tornava, due anni dopo, a
Cambridge? Dove era stato? E che cosa avrebbe dovuto leggere
Bluma in quei residui di cemento?
Ho avuto fra le mani i meravigliosi Irish Fairy and Folk Tales, con
la prefazione di William Butler Yeats e le incisioni originali di James
Torrance; ho sfogliato la Correspondance inédite du Marquis de
Sade, de ses proches et de ses familiers; ho avuto fra le mani antichi
incunaboli, e sia pure per pochi istanti ho avuto il solitario privilegio
di aprirne le pagine, di sentirne il peso; ma nessun libro era riuscito a
turbarmi quanto quel volume in brossura le cui pagine incurvate
dall’umidità reclamavano, di per se stesse, una lettura.
Lo rimisi nella busta, lo infilai nella mia cartella e tolsi la polvere
caduta sulla scrivania con l’accuratezza di un ladro.
Per una settimana rovistai nei faldoni lasciati da Bluma alla ricerca
dell’elenco di indirizzi che si suole distribuire ai convegni di critici e
scrittori. Lo trovai in una cartellina ocra con su scritto: «Ricordi di
Monterrey». Nessuno dei due autori venuti dall’Uruguay si chiamava
Carlos, ma presi ugualmente nota dei loro recapiti elettronici. Mi
ripetevo che non avrei dovuto addentrarmi nell’intimità di Bluma e
tuttavia sentivo che un libro così particolare e inutile, al di là del
messaggio di cemento che lei sola avrebbe potuto interpretare,
meritava di fare ritorno a chi lo aveva inviato.
Sistemai il libro sopra il leggio di un tavolo del mio studio e, lo
confesso, per qualche sera lo guardai con intrigata apprensione.
Forse per via dell’aspirapolvere di Alice che non risparmiava
neppure i ripiani più alti della libreria e rendeva impensabile un
granello di polvere sul tappeto o sui tavoli, il libro pareva alterare
l’equilibrio della stanza come la presenza di un vagabondo a un
ricevimento regale. Era una copia dell’edizione Emecé, Buenos
Aires, stampata nel novembre del 1946. Compiendo qualche ricerca
venni a sapere che faceva parte della collana «La puerta de marfil»,
la porta d’avorio, diretta da Borges e Bioy Casares. Sotto la calce, o
il cemento, s’intravedeva ancora il disegno di una nave, e di quelli
che sembravano dei pesci, anche se non avrei saputo dirlo con
certezza.
Nei giorni seguenti, Alice stese un panno sotto il leggio per
impedire al piano di vetro di sporcarsi. Lo sostituiva ogni mattina con
la muta discrezione che fin dal suo primo giorno di lavoro aveva
conquistato la mia piena fiducia.
Le mail che avevo scritto a Monterrey non diedero alcun risultato.
Ricevetti la lista dei partecipanti che già possedevo, il programma
del convegno e una mappa della città. Ma uno degli scrittori
uruguayani mi fece sapere che al convegno aveva preso parte in
veste di uditore Carlos Brauer, un bibliofilo suo connazionale. Lo
aveva visto uscire al termine di una cena in compagnia di Bluma,
erano entrambi piuttosto alticci, dopo aver ballato una serie di
incredibili vallenatos. «Conto sulla sua riservatezza» aggiungeva,
«dal momento che si tratta di un’indiscrezione».
La immaginai ballare in un patio coloniale, alla luce delle candele,
in una notte torrida e definitivamente incerta, come lo sono spesso le
notti messicane, ansiosa di dimostrare che poteva essere gringa ma
non legnosa, seria ma non idiota, elegante, ma anche sensuale. Poi
la vidi vacillare lungo una via acciottolata, per mano all’uomo che la
conduceva, forse felice? mentre le loro ombre fuggivano in oscuri
portoni.
Lo scrittore diceva che Brauer si era trasferito a Rocha,
dipartimento uruguayano adagiato sull’Atlantico. Da allora non aveva
saputo più nulla di lui, ma se gli avessi dato qualche giorno mi
avrebbe trovato l’indirizzo di qualcuno che lo conosceva.
Quindici anni sono molti e da quindici anni vivevo in Inghilterra.
Ogni tre tornavo a Buenos Aires per far visita a mia madre,
riallacciare i legami con gli amici del passato e fare un bagno di
parlata rioplatense mescolandomi alla variegata fauna porteña, ma
ignoravo quasi tutto dell’Uruguay. Conservavo il vago ricordo di un
viaggio notturno su un vaporetto che attraversava il Rio de la Piata
diretto a Montevideo, quando avevo cinque anni e mio padre mi
teneva ancora in braccio; molto più tardi un amico mi aveva ospitato
per qualche giorno a Punta del Este, ma non ero mai stato a Rocha.
Avevo appena una vaga idea di dove si trovasse.
Le spiagge del Sud argentino non mi hanno mai fatto pensare a
un parabrezza sporco in un giorno di pioggia. Forse il cielo
eccessivo, la tempesta di sabbia e vento, sommati alla storia di
Carlos Brauer, hanno legato le coste di Rocha, i parabrezza e
l’orribile monito che torna a tormentarmi ogni volta che qualcuno si
complimenta per la mia biblioteca. Ogni anno regalo non meno di
cinquanta volumi ai miei studenti, eppure non riesco a smettere di
aggiungere sempre un nuovo scaffale, una nuova doppia fila di libri; i
libri avanzano per la casa, silenziosi, innocenti. Non riesco a
fermarli.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo