La buona medicina – Domenico Ribatti
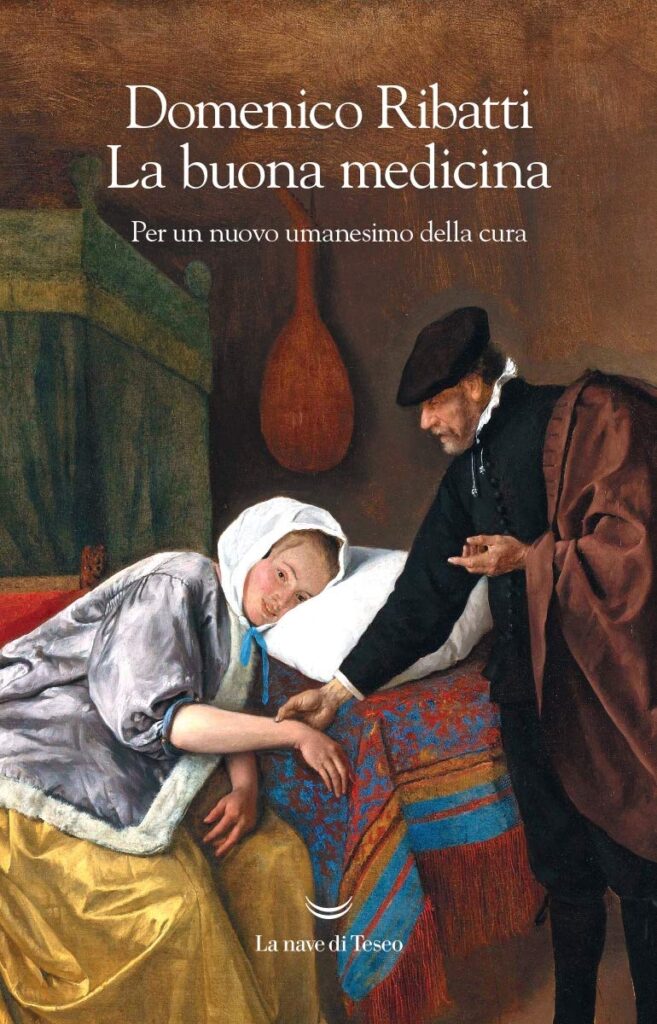
SINTESI DEL LIBRO:
Nel corso della cura il medico ha obblighi nei confronti
del paziente e di nessun altro. Non è l’avvocato della
società o della scienza medica o della famiglia del paziente
o dei suoi compagni di sventura o di coloro che in futuro
soffriranno della stessa malattia. Soltanto il paziente conta
quando è affidato all’assistenza del medico. Già secondo
la semplice legge del contratto bilaterale (in analogia, per
esempio, al rapporto tra avvocato e cliente con il suo
concetto etico-professionale del “conflitto di interessi”) il
medico è vincolato a non consentire che nessun altro interesse
entri in competizione con l’interesse del paziente alla sua
guarigione. Ma, evidentemente, entrano in gioco regole
ancora più elevate di quelle contrattuali. Possiamo parlare
di un sacro rapporto di fiducia. In senso stretto il medico
è per così dire solo con il suo paziente e con Dio.
Hans Jonas, Tecnica della medicina ed etica
Il termine malattia assume almeno tre significati diversi: è malattia in
quanto concetto patologico, malattia in quanto condizione
esistenziale vissuta dal paziente e malattia in quanto percepita da
coloro che stanno intorno al malato. Nella lingua inglese ognuno di
questi concetti è denotato da un termine specifico: disease, illness e
sickness. Per disease si intende l’alterazione fisiologica e lo
squilibrio biofisico così come canonicamente è registrato nei trattati
di medicina; illness indica la percezione soggettiva del malessere,
ovvero l’esperienza personale dello stare male; infine con sickness
ci si riferisce al modo in cui la società rappresenta la malattia.
Secondo il bioeticista statunitense Hugo Tristram Engelhardt (1941-
2018), quando un medico dice a qualcuno “lei è malato” o “lei ha
bisogno di cure” cambia la realtà sociale intorno a quella persona.
Come afferma Michael Bury: “Mentre la malattia ha un carattere
estremamente individuale, la sua esperienza prende inevitabilmente
caratteristiche sociali, in quanto gli individui interagiscono nel corso
del tempo con l’ambiente fisico e sociale.”1
Martin Heidegger, nelle pagine dedicate alla cura, distingueva il
pro-curare qualcosa a qualcuno dal prendersi cura di qualcuno.
Umberto Galimberti si è chiesto se “i medici che si limitano ad
applicare protocolli, prescrivere farmaci e ricette ai pazienti senza
prendersi cura della loro soggettività che tanta rilevanza ha nella
insorgenza, nel decorso e nella prognosi della malattia, sono da
considerare davvero medici o semplici ‘tecnici di protocolli’.”2
Nella maggior parte dei casi l’insorgenza di una malattia è il frutto
dell’interazione tra il grado di esposizione all’agente causale e la
suscettibilità dell’individuo su base genetica o come conseguenza di
precedenti danni subiti. Andrebbe messa in discussione un’idea
meccanicistica e riduzionistica della vita e più in generale dei
processi biologici, e si dovrebbe privilegiare una concezione olistica
nella quale le relazioni tra le diverse componenti sono più importanti
delle singole parti. In questa accezione, la salute, la condizione di
benessere è il prodotto di molteplici fattori di ordine biologico,
psichico, culturale e sociale che interagiscono e cooperano tra di
loro a rendere ogni esperienza umana unica.
La medicina non sfugge alla variabilità dell’esistenza in quanto le
sintomatologie si presentano in modo diverso in ogni paziente e le
risposte alle terapie sono variabili da soggetto a soggetto.
La medicina non è solo una scienza, quanto una disciplina
complessa che ha per oggetto l’uomo tanto in chiave biologica,
quanto in rapporto alla sua condizione di essere sociale. Riflettere
sul ruolo della medicina quale strumento di tutela della salute e della
vita umana significa interrogarsi sul rapporto che intercorre tra
questo diritto e l’interesse collettivo, nonché sull’essenza stessa del
concetto di salute. Quest’ultima, infatti, dovrebbe essere sempre
intesa come conservazione del benessere e dell’equilibrio psico-
fisico della persona, e dovrebbe tenere conto del fatto che, nella
ricerca della guarigione, il medico si muove tra differenti risorse
terapeutiche, alle quali si può accedere a seconda della loro effettiva
disponibilità.
Un tempo il medico dava consigli il malato e forse lo guariva, ma
sempre lo consolava. Il legame tra medico e paziente non ha solo
fondamenta scientifiche, ma è basato sulla religio medici, che è
anche il titolo di un libro di Thomas Browne (1605-1682), ovvero la
religione medica del dovere. Questo rapporto si sintetizza nella
pietas, ovvero l’attenzione alle sofferenze del paziente.
Consolare l’ammalato è un’arte delicata e difficile, è lo specchio
dell’anima di chi gli sta vicino. Da sempre, chi è malato vuole, oltre
alla competenza, anche essere capito, esige disponibilità al dialogo,
accoglienza e ascolto. Per dare speranza basta un gesto, un sorriso,
la fiducia, la vicinanza di una persona cara. L’attenzione e l’ascolto
sono una grande cura. Proprio perché la medicina si misura con
l’essere umano, ciò che emerge con forza è la necessità di una
relazione interpersonale. A seguito dell’affermarsi di una medicina
fortemente specialistica è diventato più arduo individuare un medico
che si assuma il compito di dialogare con il paziente per spiegargli la
diagnosi e le possibili terapie.
Oggi, come ha scritto Giorgio Cosmacini, “il medico ha più mezzi,
migliori conoscenze… ma sembra prendere le distanze dal malato
che ha di fronte dedicandogli sempre meno tempo. […] I medici
sembrano meno capaci di trattare le persone malate e non. Se è
vero che il bisogno di qualcuno che si prenda cura della nostra
condizione di malati affonda le sue radici nella storia evolutiva della
specie, come di fatto dimostrano anche gli effetti placebo, allora può
essere rischioso per la sopravvivenza della stessa medicina
scientifica sottovalutare la relazione comunicativa con il paziente.
Perché una conseguenza è l’insoddisfazione per una medicina
frettolosa e difensiva e quindi il ricorso a pseudomedici, come gli
omeopati, che non curano alcunché ma dedicano ai pazienti molto
tempo.”3
La medicina narrativa si pone come obiettivo proprio quello di
rivalutare il rapporto medico-paziente, come passaggio
fondamentale della vera cura: coinvolgimento diretto e attivo del
paziente, ricerca di percorsi di cura condivisi, con la finalità di ridurre
il numero delle pratiche mediche inutili e costose e di migliorare
l’efficacia delle terapie. La comunicazione e la relazione rivestono
una importanza fondamentale e si estendono anche alla dimensione
sociale e psicologica del paziente, così da aiutarlo a gestire
importanti aspetti della sua malattia e della terapia.
Ha scritto Giorgio Bert in un saggio dedicato alla medicina
narrativa che “pur essendo un metodo che ha analogie con alcune
psicoterapie, la medicina narrativa deve lasciare il malato libero di
esprimersi usando le strutture e le espressioni linguistiche che più gli
sono proprie. […] Uno dei massimi esperti dell’argomento, il
sociologo dell’Università di Calgary, Arthur Frank, ha coniato il
termine narrazione caotica. È caotico ogni racconto che non preveda
sequenze connesse di eventi, ma giri come un vortice intorno alla
malattia e solo intorno ad essa. Il malato può parlare e poi
all’improvviso tacere, segnalando uno stato di profonda confusione,
in quanto ciò che percepisce non è dicibile in termini narrativi. È
possibile infatti narrare la propria vita se si è in grado di prendere
almeno un po’ le distanze dagli eventi, ma non si può narrare la vita
mentre la si sta vivendo. Perché sia possibile, a volte bisogna che il
medico favorisca la comunicazione e metta in atto alcune tecniche
basate sull’empatia.”4
Il racconto in chiave personale della malattia e della salute
concorre, quindi, a migliorare l’efficacia della cura. Oggi i medici
vengono formati a raccogliere dati depurati da qualunque
soggettività, e quasi mai il paziente ha il tempo di raccontare perché
si è recato dal dottore.
Del resto, questo paradosso è sintomatico di una crisi profonda
che la medicina vive da diversi anni, una crisi che trae fondamento
proprio da un eccesso di medicalizzazione: ovvero la minaccia
incombente di una deriva tecnologica che finirà per inglobare ogni
cosa e per ridurre l’esistenza umana, ancora più che in passato, ad
una cifra, un meccanismo in avaria.
Nella medicina classica l’accento veniva posto più sulla
patogenesi, cioè sugli aspetti meccanicistici che caratterizzano
l’insorgenza e lo sviluppo di una malattia in un corpo, piuttosto che
sugli aspetti eziologici, cioè i rapporti tra l’individuo e il suo ambiente.
L’elaborazione dei postulati di Henle-Koch formulati da Robert
Koch (1843-1910) e dal suo maestro Jakob Henle (1809-1855)
derivava soprattutto dall’esperienza che i due avevano maturato
nello studio della tubercolosi. Il suo agente patogeno,
Mycobacterium tuberculosis, è stato denominato “bacillo di Koch”
proprio in onore del suo scopritore. I postulati di Koch portavano
finalmente ordine in un settore della medicina dove fino ad allora
regnavano empirismo e superstizione. La loro adozione consentì
all’epoca di ottenere insperati successi nella prevenzione e controllo
di numerose malattie batteriche. I postulati stabilivano che l’agente di
una malattia infettiva 1) deve essere presente in tutti i casi di una
specifica malattia; 2) non deve essere presente in caso di altre
malattie né in individui sani; 3) deve essere isolato dai tessuti in
coltura pura; 4) deve essere capace di riprodurre la malattia
attraverso infezione sperimentale in un animale di laboratorio. Il
primo requisito corrispondeva al criterio aristotelico di causa
necessaria (la causa deve essere sempre presente), il secondo e il
terzo criterio chiarivano la causa sufficiente (ovvero, la sua presenza
è di per sé sufficiente a indurre la malattia). L’adozione di criteri
aristotelici di causalità è evidentemente coerente con una
concezione della conoscenza come “disvelamento”, con l’enfasi sulla
tassonomia e con l’interpretazione meccanicistica della patogenesi.
Come ha osservato Bernardino Fantini, “Koch sposta il ruolo
dell’agente alla causa necessaria: la presenza di un microbo
specifico può non essere sufficiente a causare la malattia, ma la sua
assenza senza eccezioni significa l’assenza della malattia.”5
Di fatto, solo alcune malattie rispondono a una classificazione di
tipo “eziologico”, basata sul riconoscimento dell’agente causale.
Altre, come i tumori, sono classificate in base a criteri
fenomenologici, altre ancora possono venire classificate in base a
entrambi i criteri.
Nel passaggio dalla tradizione ippocratica alla scuola di Galeno,
attraverso la razionalizzazione teorica dovuta a Aristotele, si delinea
uno stile di pensiero fondato sul metodo e sull’esperienza. Si impara
a conoscere il corpo umano attraverso la dissezione di un cadavere.
Sulle tracce del paradigma aristotelico, un grande impulso allo studio
scientifico delle malattie, secondo una prospettiva fondata sulla
osservazione sistematica degli organi è venuto dallo sviluppo della
anatomia patologica: nel XVI-XVII secolo con l’anatomia postvesaliana e con William Harvey (1578-1657) e tra il XVIII e il XIX
secolo con René Laennec (1781-1826) e la sua scuola.
La correlazione anatomo-clinica, ovvero il riscontro di un
corrispettivo anatomico del sintomo, effettuato post mortem, diventa
il fulcro della medicina moderna. Il medico francese Marie FrançoisXevier Bichat (1771-1802), che aveva orientato la clinica verso
l’anatomia patologica, scriveva che “una serie di autopsie farà più
luce di vent’anni di osservazione dei sintomi” e che “la vita è
l’insieme delle funzioni che resistono alla morte.”6
L’anatomia patologica tradizionale ha insistito a lungo sulla
specificità delle lesioni negli organi come carattere distintivo di
ciascuna malattia. È stato con Louis Pasteur (1822-1895) che la
prospettiva è cambiata: da un lato le cause esterne sono divenute
tangibili e materiali, dall’altro è emerso un nuovo paradigma secondo
cui a cause esterne specifiche corrispondono reazioni aspecifiche
negli organi. Lo stesso modello è stato applicato con successo nello
studio delle malattie degenerative: in particolare, nel caso del
cancro, il modello tuttora accettato, e che ha ricevuto recenti
conferme, è quello di una serie di stadi successivi la cui attivazione
può avvenire ad opera di agenti esterni. Le cause esterne
intervengono a minacciare un equilibrio fisiologico garantito e
mantenuto da un sistema regolativo di feedback o retroazione.
La vita, secondo Claude Bernard (1813-1878), è un conflitto tra
l’organismo che tende a conservarsi e l’ambiente esterno che tende
a distruggerlo, tra condizioni organiche predeterminate e condizioni
fisico-chimiche ambientali. Bernard ha dimostrato che la conoscenza
si accresce grazie a una metodologia ipotetico-deduttiva in cui
l’osservazione serve a diversificare le ipotesi che hanno mosso la
ricerca stessa. Bernard ritiene che lo sperimentatore è colui che,
affidandosi a una interpretazione più o meno probabile, ma
anticipata dei fenomeni osservati, imposta un esperimento in modo
tale che, secondo la logica delle sue previsioni, il risultato che ne
ricava possa avvalorare o smentire la tesi di partenza.
Scrive Bernard che “la fisiologia pur diventando la base naturale
della medicina sperimentale non può sopprimere l’osservazione
dell’ammalato né può diminuirne l’importanza. Le conoscenze
fisiologiche sono indispensabili non solo per spiegare la malattia, ma
anche per fare una buona osservazione clinica.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :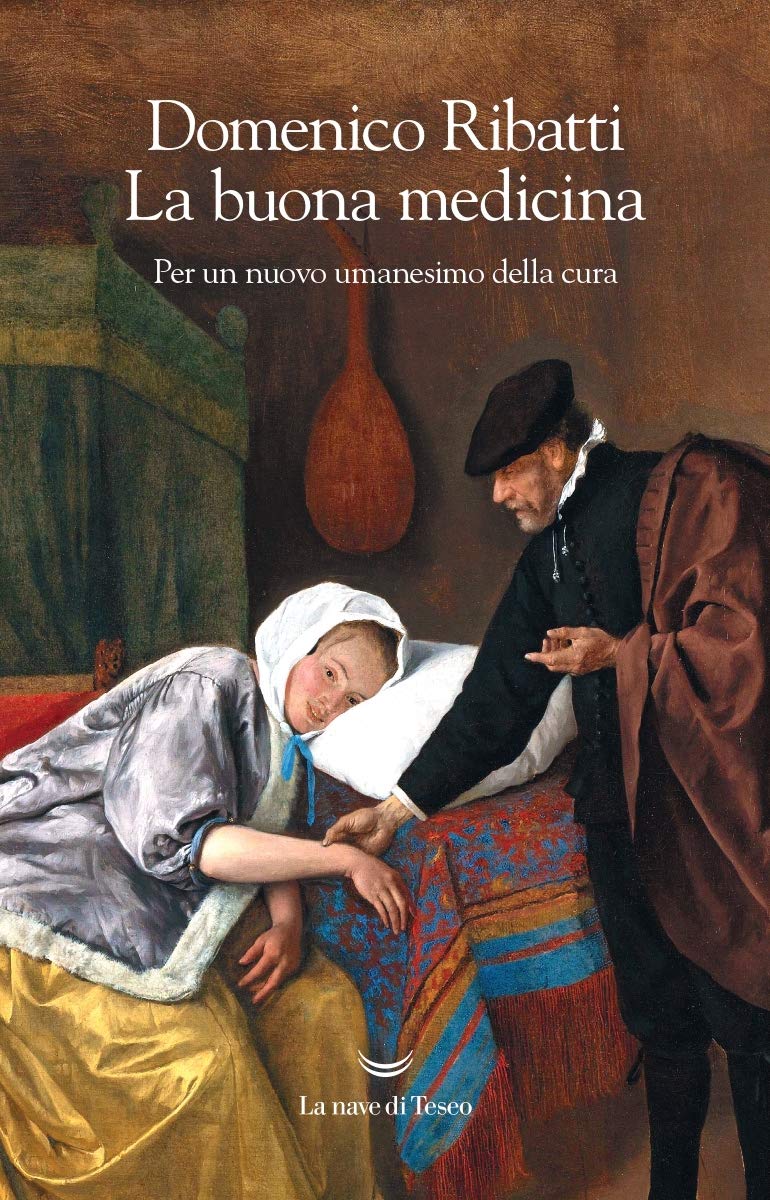






Commento all'articolo