Il senso della lotta – Nicola Ravela Rafele

SINTESI DEL LIBRO:
Corro tutte le mattine dispari della settimana. Mi impongo il lunedì, il
mercoledì e il venerdì, un argine al fluire dei giorni. Se non lo facessi,
abiterei uno stato di perenne stordimento.
Corro per un'ora, lo faccio per confondermi, per spossarmi, per affrontare
la giornata con il cerchio alla testa e i battiti cardiaci accelerati.
Lavoro al Corriere della Sera, redazione romana, cronaca romana, quarto
contratto temporaneo. Mi hanno preso dopo una carriera universitaria
scricchiolante e qualche sostituzione estiva nelle free-press, grazie
all'intercessione di un amico di famiglia.
Da quando ho messo piede in quella redazione, Diana, che è una
milanese vecchio stampo, mi guarda con altri occhi. Pronuncia quel nome,
Corriere della Sera, con un lento accento di trionfo sull'ultima ‘e’. La
allunga come in un festeggiamento tra iniziati, un party a numero chiuso per
chi presenta un invito su cartoncino bianco. Anche se l'invito lo ha scritto
un suo amico, anche se il mio spazio al Corriere della Sera è spesso quello
dell'ultima pagina prima dei cinema.
È sempre un inizio, no? È così che si dice.
Il pomeriggio, dalle 16 alle 21, lo passo in redazione.
Quando stacco e mi muovo da piazza Venezia, non torno mai a casa.
Esco ogni sera per annientarmi.
La consapevolezza è sempre stata un problema.
Ho provato con le droghe, come ogni buon cittadino della mia età, ma
non ha funzionato.
Anche oggi, mentre mi allaccio le scarpe, mentre chiudo la cerniera della
tuta, mentre cerco gli auricolari, nulla è diverso dal solito.
Mentre sollevo una gamba da terra e la piego all'indietro per tendere i
muscoli, mentre riempio una bottiglietta d'acqua e infilo le chiavi di casa
nella tasca dei pantaloncini. Mentre guido la macchina fino al parco. Mentre
parcheggio e poi mi avvio verso l'ingresso. Mentre attivo il GPS, mentre
scelgo la playlist da ascoltare tra quelle che ho salvato nello smartphone.
Mentre evito una pozzanghera lucida e colpisco un piccolo sasso con la
punta della scarpa. Mentre lancio uno sguardo distratto verso gli alberi
spogli, e poi verso l'area giochi (uno scivolo segnato da tag e disegni osceni,
un girello occupato da un bambino solitario), mentre passo camminando
lungo il viottolo che costeggia il piccolo canale melmoso. Nulla è diverso
dal solito. Le cose del mondo sono al loro posto, rese più nette da una
violenta luce invernale.
È il vento del Nord: il cielo è un compatto piano celeste che fa pensare al
coperchio di una scatola di cioccolatini.
Il sudore gela sulla pelle. Sento le pulsazioni leggere nelle tempie.
Il canale di acqua torbida alla mia sinistra è immobile, la salita sembra
sempre troppo lunga, le fronde dei platani proiettano ombre guizzanti sulla
strada.
Il primo giro dell'anello di Villa Pamphili lo percorro in poco meno di
ventitré minuti.
Seguo la strada che costeggia una staccionata di legno marcio. Uno
spinone con una lunga lingua penzolante mi sfreccia accanto per qualche
metro, poi la sua attenzione viene rapita da un ciuffo d'erba.
Supero la curva e mi giro, lo faccio ogni volta, verso destra per guardare
il lago. Questa mattina riflette il cielo, sembra la bocca di un vulcano
spento.
Quattro panchine vuote. Un belvedere che nessuno vede. C'è poca gente:
qualche bambinaia con passeggino. Cani.
La gamba non arriva bene alla fine dell'allungo. Il piede si pianta nella
terra morbida.
Prima di tutto arriva un'informazione al cervello. Perentoria: Fermati.
Il ginocchio sinistro si flette.
Un colpo di tosse.
Provo a mantenere l'equilibrio allungando la falcata con l'altra gamba.
Fermati.
Una massa calda tra le scapole. Una presenza improvvisa nel mio corpo.
Apro la bocca. Deglutisco, ma la carotide si stringe.
Il fiato si annoda in gola, qualcosa nel petto si contrae.
Il battito perde il tempo, si ingolfa.
Il cuore si agita come dentro un sacco nero.
Lo sento nella punta delle dita, nella testa, fino ai piedi. L'intero corpo
che batte. Qualcosa che preme per esplodere.
La paura mi disfa i muscoli. Stanno per cedere.
Non cado per il dolore, non c'è nessun dolore: cado per la paura.
Non è vero che la vita ti scorre davanti. Non pensi. Ascolti le cavità del
corpo. Il viso schiacciato contro il terriccio umido. E aspetti.
Apro gli occhi, cerco aria, non la trovo.
“Tutto bene ragazzo? Oh?”
Due runner, il primo fasciato in una tuta gialla, l'altro tutto griffato
Adidas, si sono fermati accanto a me. Sento il loro respiro ansimante.
Quello marchiato Adidas saltella sul posto per non raffreddare i muscoli.
Un corridore coscienzioso: nemmeno di fronte a un moribondo vuole
rischiare una contrattura ai bicipiti femorali.
“Ehi! Tutto bene?”
Il cuore non rallenta, provo ancora a deglutire, ma nessuna delle attività
automatiche dell'organismo funziona più. Il mio corpo sembra appena
costruito, non ancora programmato a compiere il suo dovere. Respirare, far
scendere la saliva, pompare sangue nel sistema, muovere un braccio, una
gamba.
Rassicuro i soccorritori con un gesto del pollice verso l'alto: sono
inciampato, va tutto bene.
Lo faccio per levarmeli dai piedi. Voglio morire da solo. Come gli
elefanti.
Loro aspettano qualche secondo, poi ripartono.
Mi alzo poggiando i palmi sulla terra e forzando sui gomiti. A metà del
gesto mi blocco, mi abbasso, mi rialzo, come chi fa le flessioni.
In piedi. Mi gira la testa. Ho paura.
Muovo qualche passo, poi mi siedo sulla staccionata che delimita il
laghetto. Mi fisso le mani, le dita tese. Ho le unghie troppo lunghe.
Per tre volte inspiro, ma l'aria si blocca sopra la lingua, il torace sale e
scende in movimenti convulsi fino a scatenare una crisi di tosse.
Le cuffie dell'iPhone sono stese lungo il mio corpo, sfiorano le scarpe.
Sento la musica uscire come un rantolo distante. I bassi che raschiano. Mi
sfilo la fascia elastica dal braccio, lascio cadere tutto per terra. Come se
alleggerirmi potesse aiutarmi a respirare.
Vedo piccoli vermi viola ballare sulla rètina, e macchie gialle allargarsi
sullo sfondo alberato.
Lentissimo, mi allontano dalla staccionata.
Nessuno sembra fare caso a me. Non quelli che corrono, non la coppia di
adolescenti che cammina rapida verso il prato dopo aver marinato la scuola.
Passeranno la mattina annoiandosi, lui sdraiato sull'erba bagnata, e lei con
la testa contro il suo petto che manda con il cellulare messaggi WhatsApp
alle compagne entrate a lezione.
“Musso Tommaso, nato a Parigi il 2.1.1979?”
“Esatto.”
“Nato a Parigi...”
Il medico ha il camice aperto, come una veste da camera poggiata su una
polo Ralph Lauren celeste e un paio di pantaloni scuri. Gli occhi neri sono
troppo vicini, la bocca non ha labbra, sembra disegnata a matita. Un viso
arredato da un architetto orientale, con pochi elementi che cercano di non
occupare troppo spazio.
Studia la mia scheda, poi mi dedica una contrazione dei muscoli facciali:
dovrebbe essere un sorriso.
“Parigi, Parigi...”, dice con un sospiro, ricorda il tono di un cantante di
una romanza d'Opera. Sembra ignorare che io sia in attesa di un responso.
“Ci vive ancora, a Parigi?”
“No. Non ci ho mai vissuto.”
La bella clinica dei Parioli che mi posso permettere grazie
all'assicurazione di famiglia è bianca, lucida, piena di piante ordinatamente
incasellate lungo il corridoio, tra una porta e l'altra.
Un posto adatto per scoprire che stai morendo: il paradiso potrebbe essere
così. Lindo e impersonale. Il terminal di un aeroporto definitivo.
L'ufficio al pianoterra del dottor Giacomo Pinto ha le pareti coperte di
libri non letti. Scuri dorsetti plastificati con i titoli in oro, e in oro sono
anche le pergamene che attestano le specializzazioni del dottore.
Libri in latino. Testi di medicina. E sulle pergamene: un master in
angioplastica pediatrica a Chicago. Un corso di aggiornamento in
diagnostica dell'ipertensione polmonare.
Ogni patologia su quegli attestati (lettere con svolazzi, carta spessa con
finto invecchiamento da copisteria) sento di averla.
Il dottor Pinto si passa una mano tra i capelli.
Si alza dalla scrivania, si gode il potere che ha su di me. Dopo tanti anni
non deve ancora essergli venuto a noia quel momento da imperatore
romano al Colosseo: pollice verso, pollice in su.
“Signor Musso, credo che il suo possa essere stato solo un episodio di
panico.”
Mi perdo con lo sguardo oltre la finestra, verso i palazzi ocra, verso le
terrazze dove le cameriere filippine stendono il bucato.
Pollice in su.
“In che senso ‘crede’? Gli esami?”
“Abbiamo misurato la pressione, e il responso è interlocutorio.”
“Non capisco.”
“Lei ha la pressione molto alta. Centocinquanta. È troppo. Dovrebbe fare
un elettrocardiogramma sotto sforzo, ma con la pressione così non si può”,
mi spiega.
Io non rispondo.
“Lei ha un'assicurazione, mi ha detto...”
“Sì.”
“Allora la tengo qui. Se si ricovera le pagano la visita. E io intanto le
faccio qualche altro esame...”
“Intende dire che potrebbe trovare qualcosa?”
I suoi occhi piccoli mandano una scintilla di sincera gentilezza. Il dottore
mi poggia una mano sulla spalla.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :




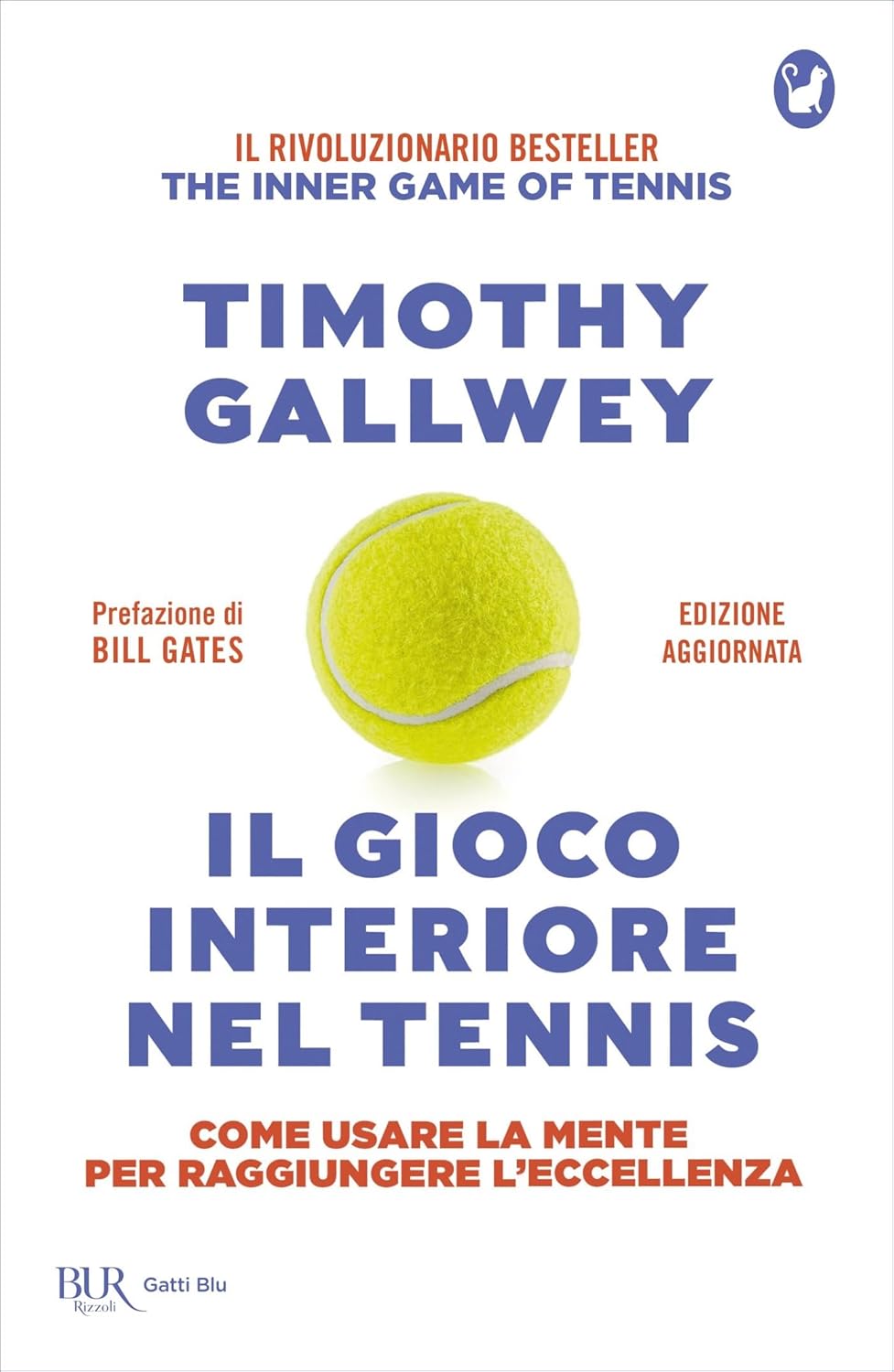

Commento all'articolo