Giuda – Il tradimento fedele – Gustavo Zagrebelsky
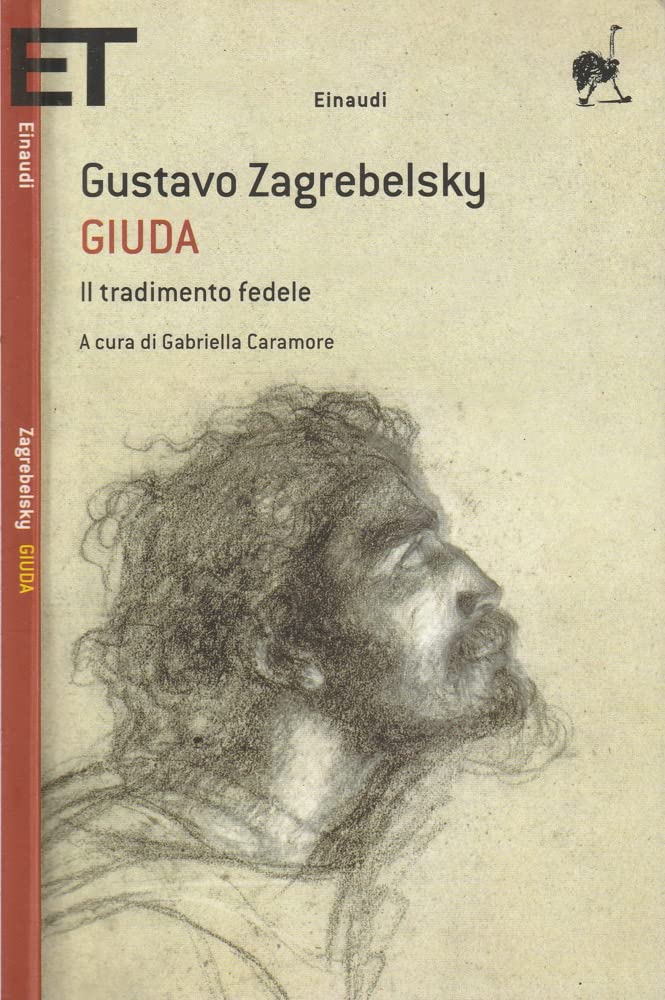
SINTESI DEL LIBRO:
La domanda è coinvolgente e, in certo senso,
intima. Ricordiamo entrambi il momento in cui l’idea di parlare di
Giuda ci parve promettente, per un dialogo su cose importanti. Non
immaginavo che l’attenzione sarebbe finita per spostarsi da una
vicenda di duemila anni fa, intrecciata col processo e con la morte di
Gesú di Nazareth, a un’interrogazione su noi stessi. Come per tutte
le grandi narrazioni bibliche, è però inevitabile che questo accadesse
anche per la figura di Giuda. Cosí, lei ora mi chiede perché è
interessante per me. Il che significa proporre Giuda come uno
specchio in cui siamo invitati a guardarci senza nasconderci ciò che
vediamo, cioè a non mentirci. Naturalmente, la risposta – anch’essa
– è ‘per me’, cioè valida per me. Per altri, non saprei. Diano la loro
risposta.
Credo di poter dire cosí: si tratta innanzitutto del fascino del
personaggio che si è cucito, o al quale è stato cucito addosso, l’abito
dell’abiezione. L’abiezione ci porta alla conoscenza piú autentica
dell’essere umano. Ricorda l’uomo del sottosuolo dostoevskjiano?
Quando sinceramente ci si rivela nell’abiezione, si è senza dubbio
piú sinceri, e quindi interessanti, di quando ci si mostra nel nostro
lato piú pulito, degno di stima e considerazione. Chi indossa o colui
al quale è fatta indossare una divisa da santo è di solito piú artefatto,
se non addirittura falsificato, di chi si rivela nella sua bassezza. Non
che manchi anche un esibizionismo dell’abiezione, ma certo Giuda
non può essere accusato di questo. Nessuno dei suoi gesti è
descritto come se fosse stato compiuto per essere notato, per fare
scandalo, per passare alla storia. Altri, tra i dodici, indulgevano talora
alla vanità. Giovanni, per esempio, anche a giudicare da quel che
dice di sé nel suo Vangelo, doveva essere un grande vanesio.
Giuda, il contrario. Nessun beau geste da parte sua, non nel bene e
nemmeno nel male. Non vuole lasciare un’impronta di sé, non cerca
di diventare un eroe agli occhi di chi gli sta attorno, o semplicemente
di assumere e rappresentare una sua parte in una ‘storia’. Agisce
avvolto nell’ombra e, a differenza di altri dei dodici, non pare affatto
desideroso di farsi notare. È cosí appartato che i Vangeli, al di là
della vicenda del tradimento di cui è protagonista, gli dedicano
pochissime parole alquanto insignificanti, oltre che non certo
lusinghiere. La sua morte è un suicidio disperatamente solitario.
Sarà pure un caso di damnatio memoriae da parte degli altri seguaci
di Gesú, registrata dai Vangeli per ragioni dettate da esigenze di
fondazione della fede e coesione dei fedeli. Ma questa mancanza di
esibizione conferisce indubbiamente al suo profilo il pregio
dell’autenticità. In certo senso, dobbiamo dargli credito. Almeno
questo, povero Giuda! Perciò, come ogni figura dell’autenticità
umana, anch’egli ci interpella immediatamente. E, anche se
l’interpello si manifesta nell’abiezione, ci pone tuttavia di fronte a una
possibilità che dobbiamo riconoscere essere implicita nella nostra
condizione di esseri umani.
Ecco un primo motivo per fermarci a riflettere un poco sulla sua
figura, direi: sulla ‘maschera’ che ci è offerta di lui,
indipendentemente dalla questione della veridicità storica della sua
vicenda, una questione che, in effetti, è stata sollevata. Credo che
nel corso di questa conversazione ci accadrà di parlare di un ‘Giuda,
fratello nostro’. Ecco, allora, la risposta alla sua domanda: un nostro
‘doppio’ che ci svela un lato di noi che non amiamo vedere e, tanto
meno, mettere in mostra.
Torniamo ancora per un momento a considerare l’abiezione. È vero
che i personaggi negativi incuriosiscono piú di quelli positivi, ma,
prescindendo dall’interesse morboso, qui ci troviamo di fronte a un
tipo di abiezione particolare: il tradimento. Giuda è un ‘traditore’, anzi
‘il’ traditore. E il tradimento è una forma sottile, nascosta, di
abiezione.
G.Z. Sí. Il tradimento è sempre nascosto. Il traditore si dissimula.
Agisce in modo tale che il tradimento non traspaia, tramite la
simulazione dell’amicizia e della fedeltà. Anche in questo il racconto
del tradimento di Giuda assume un andamento simbolico attraverso
il bacio, il bacio del traditore. Nessun altro segno sarebbe stato
altrettanto efficace, nella costruzione del paradigma del traditore
come figura d’ipocrisia. Naturalmente, anche il bacio, come ogni
altro elemento della narrazione evangelica, si presta a interpretazioni
diverse. Sarà necessario ritornarci. Quello anzidetto è solo il
significato, per cosí dire, piú facile, e forse anche banale.
E quello piú profondo? Piú difficile? Quello che ci fa guardare alla
figura di Giuda come all’abisso che si nasconde in ciascuno di noi?
G.Z. Perché il tradimento di Giuda non potrebbe parlare a noi di noi?
Forse perché si tratta del tradimento del giusto per eccellenza, del
figlio dell’uomo o del figlio di Dio, in una vicenda svoltasi duemila
anni fa che, secondo la fede cristiana, è irripetibile? Forse perché il
‘tradimento’ di Giuda assume significati che trascendono gli
accadimenti puramente umani, significati che nessun nostro
tradimento potrebbe avere? I Vangeli, però, non parlano della
passione e della morte di Gesú come eventi interamente guidati dal
soprannaturale. Perciò gli esseri umani che vi compaiono, non
operano come marionette mosse dall’alto, su un palcoscenico che
non potrà mai piú essere allestito. Se fosse invece cosí, tutti i
tradimenti di cui noi potremmo essere capaci non sarebbero
neanche lontanamente paragonabili a quello di Giuda, che finirebbe
cosí per riguardare solo lui, entro gli eventi che l’hanno travolto e ci
riuscirebbe totalmente incomprensibile. Piú ‘teologizziamo’ gli
avvenimenti e li consideriamo ‘fatti divini’, meno facilmente noi
riusciamo a rispecchiarci in essi. Li potremmo ricordare e,
eventualmente, celebrare, ma non certo rivivere in noi, come cose
nostre. Se invece consideriamo la vita e la morte di Gesú di
Nazareth, secondo le narrazioni evangeliche, innanzitutto come
vicende dell’umanità, ricche di umanità, allora la strada è spianata
per farcene coinvolgere, come di fronte a tutte le grandi narrazioni
che riguardano l’humana condicio e trovano nella corrispondenza a
questa una loro prima verità, anche indipendentemente dalla fede.
Le grandi figure e le grandi vicende bibliche si prestano cosí a
interpretazioni su piani diversi. La stessa cosa è anche per Giuda. Ai
lati estremi, mi pare si possa dire, c’è l’interpretazione di lui come
uno degli intimi del Signore, divenuto sordido traditore del ‘giusto’
per mero danaro. Al lato opposto, troviamo l’identificazione in lui
dell’atteggiamento dell’umanità intera, di fronte al divino che entra
nella storia. In mezzo, sta l’immagine della disperazione, del capro
espiatorio del primo gruppo di discepoli, dell’uomo posseduto da
satana, del rappresentante del popolo ebraico nel rifiuto del messia,
oppure dell’amico di Gesú, suo complice, del coadiutore di Dio
nell’opera della salvezza, dell’iniziato alla conoscenza delle verità
ultime...: una gamma d’interpretazioni, talora anche contraddittorie,
che portano con sé giudizi diversi, nella quale la fede conta solo
parzialmente. È difficile non trovarvi un posto anche per noi.
Naturalmente, la figura dell’abiezione, con quella connessa della
disperazione, è la piú facile da comprendere e quindi la piú diffusa.
Non per questo, però, è la piú banale, almeno per chi creda che ci
sia piú verità nell’abiezione e nella disperazione che nella santità e
nella pacificazione con se stessi.
Su Giuda, insomma, aleggia l’enigma. Numerosi sono gli elementi
non spiegati o difficilmente spiegabili e, nelle narrazioni evangeliche,
non manca nemmeno il pettegolezzo: rileggendo il racconto
dell’ultima cena tramandatoci dal Vangelo di Giovanni, l’indicazione
del traditore è inserita in una scena molto vivida che si presta a
considerazioni psicologiche sui discepoli, sul loro desiderio di
mettersi in mostra o di gettare ombre gli uni sugli altri.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo