Critica della ragione digitale – Come ci trasforma la rivoluzione tecnologica – Ermanno Bencivenga
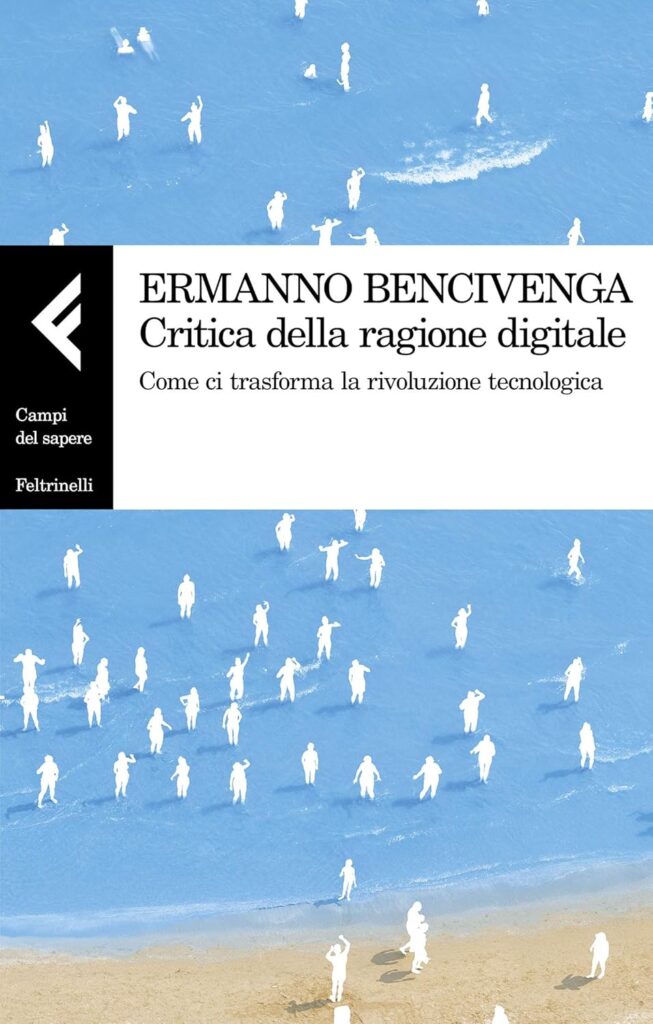
SINTESI DEL LIBRO:
Nel 2008 uscì sulla rivista “The Atlantic” un articolo dell’esperto di
tecnologia Nicholas G. Carr intitolato Is Google Making Us Stupid?
What the Internet Is Doing to Our Brains, in cui si formulavano dure
critiche contro l’effetto di Internet sui nostri processi cognitivi. La
rete, affermava Carr, erode la capacità di concentrazione e
contemplazione. Abituati alla velocità con cui accediamo a
informazioni scivolando, come su una tavola da surf, da un sito
all’altro, viene meno in noi la pazienza richiesta da un libro o da un
articolo lungo e complicato. Dopo una pagina o due ci innervosiamo,
perdiamo il filo, avvertiamo l’esigenza di occuparci d’altro, di
cambiare attività. La concentrazione nella lettura ci è divenuta
estranea. La spaventosa facilità con cui i dati risultano accessibili ci
ha resi alieni dalla fatica di cercarli noi in un testo, di passare ore a
decifrare periodi contorti e cosparsi di allusioni, ad ascenderne i
picchi e percorrerne le valli, a distinguere quel che conta, quel che fa
al caso nostro, da quel che è solo rumore.
Oggi probabilmente, grazie all’infinita marea di messaggi che ci
assediano, leggiamo più di prima, sosteneva Carr, ma come
leggiamo è cambiato. Citando la psicologa dello sviluppo Maryanne
Wolf, osservava che il nostro attuale stile di lettura esalta efficienza e
immediatezza a scapito dell’abilità di tessere una vasta tela di
associazioni, quindi anche di interpretare quel che leggiamo in
termini di quanto d’altro sappiamo e crediamo. L’enorme plasticità
del nostro cervello ci ha permesso di adattarci in breve tempo al
nuovo mezzo che abbiamo a disposizione; ma questo mezzo ci ha
trasformati in persone che hanno una diversa esperienza, si
esprimono diversamente e hanno una diversa identità. Più rapida,
più frammentaria, più inquieta, meno (molto meno!) disposta a
ritardare le proprie soddisfazioni, intellettuali e non.
L’articolo di Carr fu successivamente ampliato nel libro The
Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, del 2010 (la
traduzione italiana, pubblicata da Cortina nello stesso anno,
recuperava il titolo dell’articolo: Internet ci rende stupidi? Come la
rete sta cambiando il nostro cervello), e fu oggetto di vivace
discussione. Ci fu chi lo accusò di stupidità (!); chi lo criticò per aver
chiamato i caratteri cinesi ideogrammi (ma era solo per fare un
esempio); chi lo considerò un caso di luddismo (su questo termine
ritornerò); chi, in perfetta adesione al modello di mercato, assegnava
la responsabilità di mantenere equilibrio e saggezza al consumatore
e chi scaricava invece quella responsabilità sulla scuola (l’ente
ufficialmente delegato all’educazione, quindi, per molti, il luogo di
compensazione di ogni tensione sociale – come se il resto della
società, Internet compresa, non provvedesse a educare).
Fra le reazioni meno affrettate e superficiali comparve il libro di
Howard Rheingold Net Smart: How to Thrive Online – la traduzione
italiana, sempre per Cortina, s’intitolava in forma più belligerante e
meno fedele alle tesi dell’autore Perché la rete ci rende intelligenti. In
realtà Rheingold, senza negare la gravità del problema, forniva
alcuni consigli pratici su come affrontarlo, riducibili in sostanza a
due: esercitate un controllo cosciente sulla vostra attenzione e siate
sospettosi su quel che trovate in rete, verificandone e triangolandone
le fonti per assicurarvi di non incappare in una bufala. La
conclusione era anche per lui a carico dell’individuo: “Ho cercato di
darvi gli strumenti […]. Ora tocca a voi” (364), sentenziava. Tutto
quel che è successo dopo, e il mondo con cui abbiamo a che fare
adesso – le vere fake news e le notizie autentiche spacciate come
fake news da Trump, le malevole infiltrazioni di servizi segreti e
hacker nelle elezioni e nel clima politico di vari Paesi, la falsa
equivalenza tra opinioni scientificamente fondate (il riscaldamento
globale) e asserzioni sparate a casaccio (e in cattiva fede), che i più
non hanno il tempo e lo scrupolo di distinguere – dimostrano che i
pochi lettori di Rheingold e libri consimili (pochi in confronto ai
miliardi di frequentatori di Facebook) non hanno speranza
di modificare una deriva inarrestabile.
A lamentele come quelle di Carr mi sono associato anch’io, più
recentemente in La scomparsa del pensiero, dove mi sono spinto un
po’ più in là nel descrivere quella che ho chiamato una “catastrofe
gentile”. La fretta da un lato e l’enorme quantità di dati dall’altro ci
distraggono, è vero, fanno anzi della distrazione la nostra più
caratteristica modalità operativa, ma fanno anche altro: rendono
inutili quegli esercizi minimi di ragionamento che da sempre hanno
coltivato e “tenuto in forma” la nostra mente, così come i semplici
esercizi fisici di camminare e salire le scale ci aiutavano a
mantenere la forma fisica. Quando automobili e ascensori hanno
reso inutile l’uso del corpo, molti di noi, per non afflosciarsi in un
magma informe, sono ricorsi a esercizi artificiali in palestra; forse
dovremmo preoccuparci, suggerivo, che il nostro cervello non diventi
un magma informe e addestrarci quotidianamente in palestre della
mente – in caso contrario, la definizione aristotelica di essere umano
come animale razionale rischierebbe di divenire obsoleta.
Anni prima avevo espresso un diverso timore, forse più estremo.
Nell’articolo The Electronic Self, pubblicato nel 1991 ma letto in un
paio di università (State University of New York di Buffalo e
University of Nevada di Las Vegas) nel 1990, avevo sostenuto che la
rete era per noi un potenziale (e mostruoso) concorrente nella lotta
per la sopravvivenza. Le date sono importanti, perché l’anno di
nascita ufficiale del World Wide Web è il 1991, quindi non era quella
la rete di cui parlavo io. Erano invece, più modestamente, i bulletin
boards, le bacheche elettroniche cui ogni partecipante poteva
affiggere (eviterò l’orribile calco inglese “postare”) messaggi che
rimanevano a disposizione di tutti (un po’ come si fa oggi nei social
media). Il pericolo dal quale mi sforzavo di mettere in guardia i miei
lettori era che le bacheche iniziavano, combinando i contributi dei
loro utenti, a mostrare un comportamento ludico, che sfuggiva alla
consapevolezza e al controllo di ciascun utente; e il gioco, come
ripeto da una vita, è l’intelligenza – sviscerare un mistero, appianare
una difficoltà, risolvere un problema richiede che li si rigiri nel
pensiero (e, talvolta, fra le mani) ludicamente, provando questa e
quella angolatura, finché lo sguardo non cada (in modo fortuito) sulla
prospettiva giusta, da cui tutto per miracolo funziona. Se dunque un
cervello artificiale comincia a giocare a una scala inarrivabile per gli
esseri umani, questi ultimi saranno espulsi (come un tempo dal
mitico Eden) dalla nicchia ecologica di cui il gioco li aveva resi
(temporaneamente) dominatori incontrastati.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :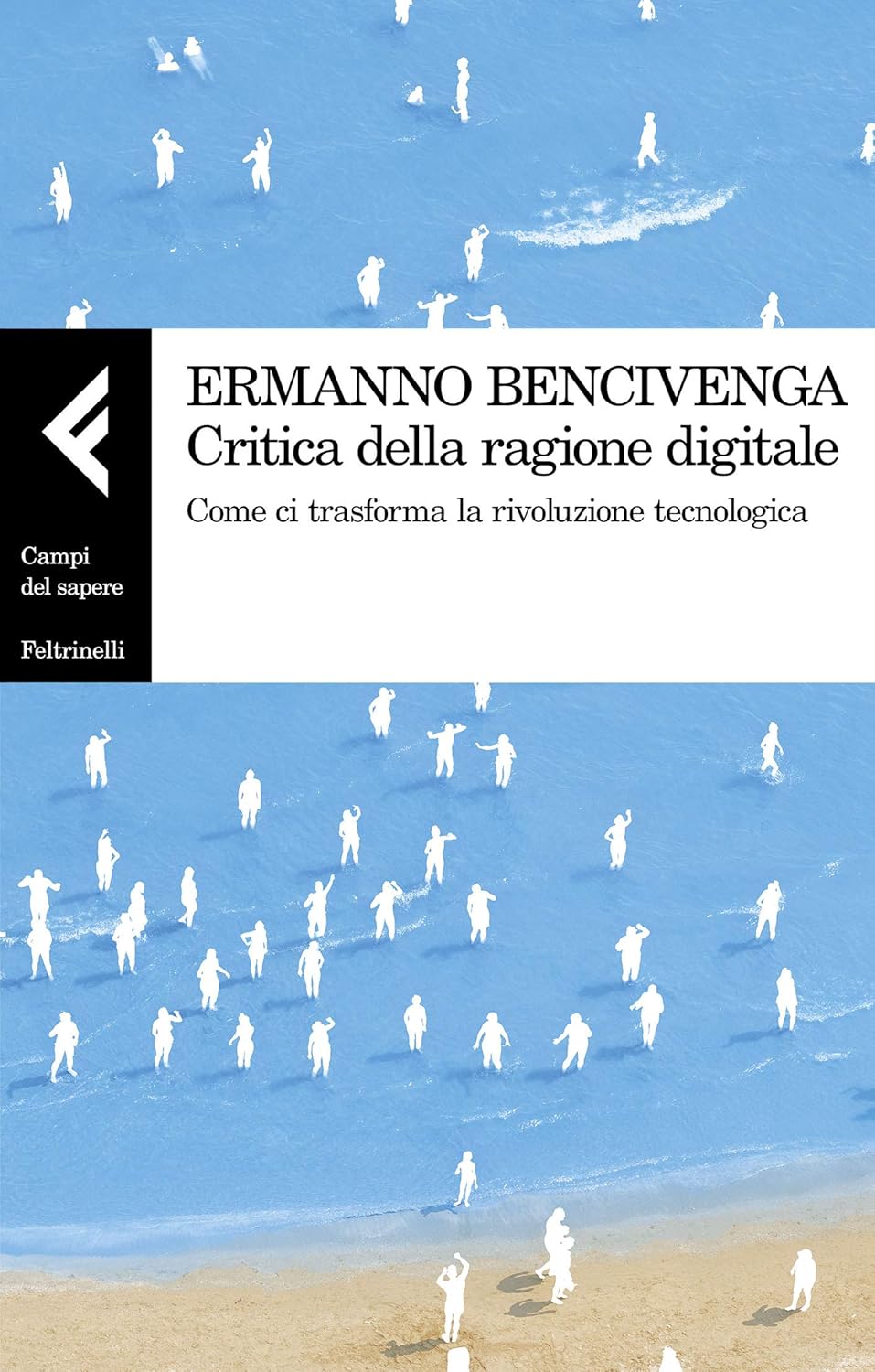






Commento all'articolo