Cristo con il fucile in spalla – Ryszard Kapuscinski
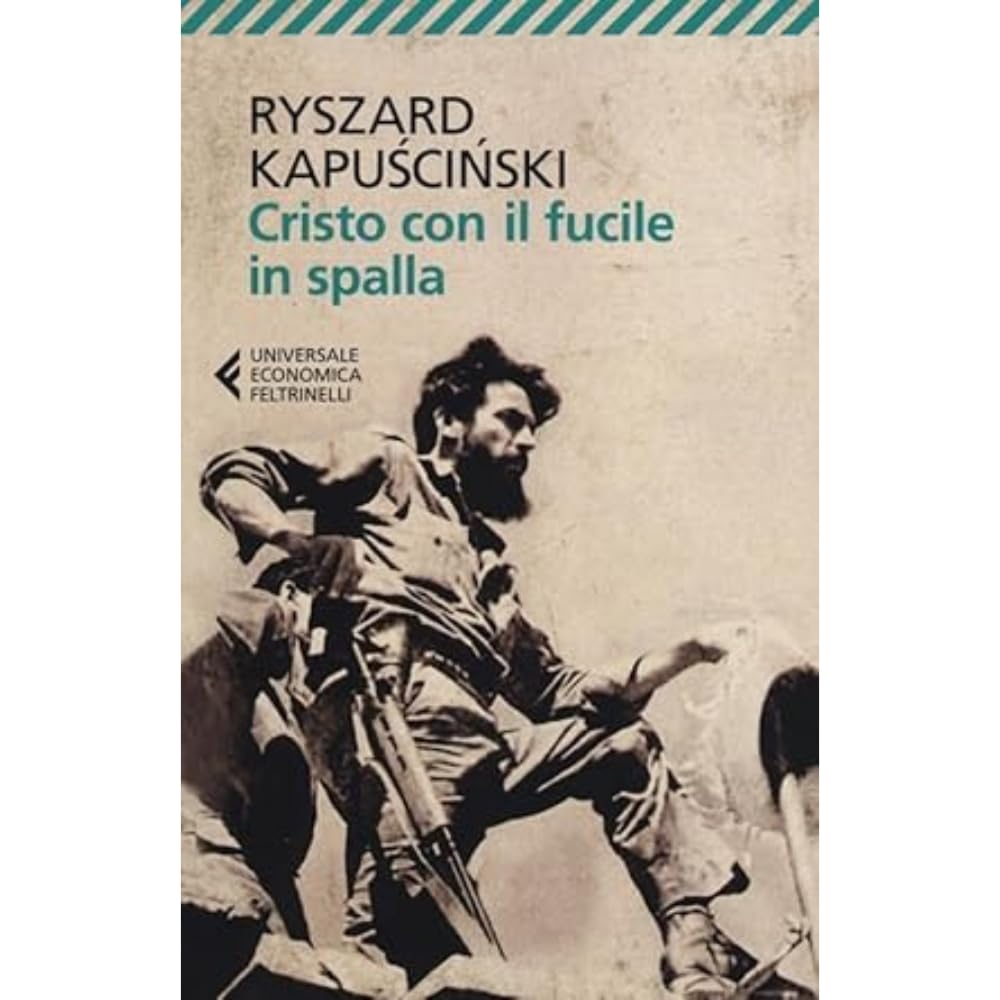
SINTESI DEL LIBRO:
I tre uomini in tuta di tela verde e armati di mitra sono fedayin. Appostati
lungo la strada che da Beirut porta alla frontiera israeliana, fermano le
macchine. Chi ha un valido motivo per andare avanti viene fatto passare; chi
invece è venuto senza una ragione precisa, oppure ha l’aria sospetta, deve
fare marcia indietro. Questa non è una meta turistica, qui c’è la guerra. Dieci
chilometri più avanti comincia Israele.
Mi guardo intorno: un paradiso in terra. Lungo entrambi i lati della strada
si estendono giardini di limoni, olivi, peschi. Più avanti, sulla destra,
comincia il mare, mentre a sinistra si ergono le montagne. Ovunque un
tripudio di verde e di fiori. E tutto, fino alla linea dell’orizzonte, immerso nel
sole.
I tre fedayin sono molto giovani. Il minore avrà sì e no quindici anni. È
serio, molto compreso nel suo compito di sorveglianza. Con il casco, la
mitraglietta e quella tuta che gli va troppo grande sembra un piccolo
portaordini dell’insurrezione di Varsavia. Vuole sapere dove siamo diretti.
Andiamo a Rashidyia, solo che non sappiamo in che punto svoltare. Da dove
veniamo? Dalla Polonia. Un attimo di riflessione, poi: “Dalla Polonia? A
posto! Solo un momento”. E chiama un altro fedayin che avanza solitario
lungo la strada. Alla fine decidono di farlo proseguire con noi. Svoltiamo in
direzione del mare e ci imbattiamo in un nuovo posto di controllo, dove sale a
bordo un secondo fedayin. Così scortati, entriamo a Rashidyia.
Rashidyia odora d’arance e di sangue.
Un obice ha preso in pieno un camion carico d’arance e sulla strada
principale scorrono rivoli di fragrante succo dorato. Poco più in là, un
vecchio arabo siede silenzioso e impietrito sulla soglia di una casupola
d’argilla. Di quella che fino a ieri era la sua casa non rimangono che il
pavimento e un pezzo di parete. Della sua famiglia, nessuno. “Questo è
sangue,” dice uno dei fedayin, indicando alcune macchie scure sul pavimento
di terra battuta. Prosegue la fila di misere abitazioni, qua e là occhieggiano gli
interni sventrati dagli obici. Armadi sfasciati, brandelli di stoffa insanguinata,
un bricco da tè scaraventato in mezzo alla strada dall’onda d’urto. Su una
parete, il ritratto di Nasser trafitto da una scheggia. In un punto ogni cosa è
stata ricoperta da un candido manto di farina. Più in là, un proiettile ha
colpito il tetto di una bottega senza distruggere la merce e l’arabo si è già
rimesso dietro al bancone: avanti, signori, venite pure a comprare.
Qui, però, non c’è nessuno che compri. Sono rimasti solo una postazione di
fedayin e qualche vecchio arabo: la popolazione è stata evacuata in
previsione di un nuovo attacco. Evacuata per l’ennesima volta, per
l’ennesima volta in cammino senza sapere dove andare. Ciascuno ha afferrato
in fretta e furia quello che aveva sottomano, chi una pentola, chi una coperta,
abbandonando il resto. Un resto che si riduce a ben poco, anzi praticamente a
nulla. Cianfrusaglie scassate: un vecchio comodino, cenci rattoppati, una
bambola di pezza senza una gamba.
Rashidyia è uno dei campi di rifugiati palestinesi in Libano, e i campi
palestinesi sono la cosa più triste che si possa vedere in Medio Oriente. Se
state viaggiando attraverso la Siria, la Giordania o il Libano, dove tutto è
bello e ben messo e, all’improvviso, vedete qualcosa di sconvolgente,
qualcosa che sembra un grande, misero cerotto fatto d’argilla battuta, lamiere
arrugginite, stracci vecchi e pali rotti, sul quale a ogni alito di vento si levano
nugoli di polvere incandescente, al cui interno brulicano torme di bambini
seminudi, mosche rabbiose e cani famelici, mentre gli uomini siedono a terra
appoggiati alle pareti in attesa di non si sa che, di una cosa qualunque –
ebbene, vuol dire che vi trovate davanti a un campo di profughi palestinesi.
Le strette viuzze di Rashidyia scendono dolcemente verso il mare.
L’attacco di ieri è venuto dal mare. Nel pomeriggio sono arrivate quattro
cannoniere israeliane che hanno bombardato Rashidyia per un’ora. Il Libano
non possiede una marina militare, per cui hanno potuto sparare impunemente.
Avrebbero anche potuto continuare per tutto il giorno, se non fosse che la
portata degli attacchi viene limitata per motivi politici: si uccide un numero di
persone sufficiente a servire da monito, ma non troppo elevato, per evitare
che dal mondo si levino voci di condanna.
E qual è il numero di vittime che il mondo riesce a digerire? Difficile
stabilirlo con esattezza. A Rashidyia sono morte dodici persone: la quantità
giusta. E se fossero state duecento? Probabilmente duecento sarebbero state
troppe. I comandanti delle cannoniere tirano alla cieca, senza sapere il
numero dei morti che verrà fuori: un numero che non dia nulla da temere, o
un numero capace di suscitare voci di condanna?
I particolari, comunque, verranno a saperli soltanto dopo, leggendoli sui
giornali.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :




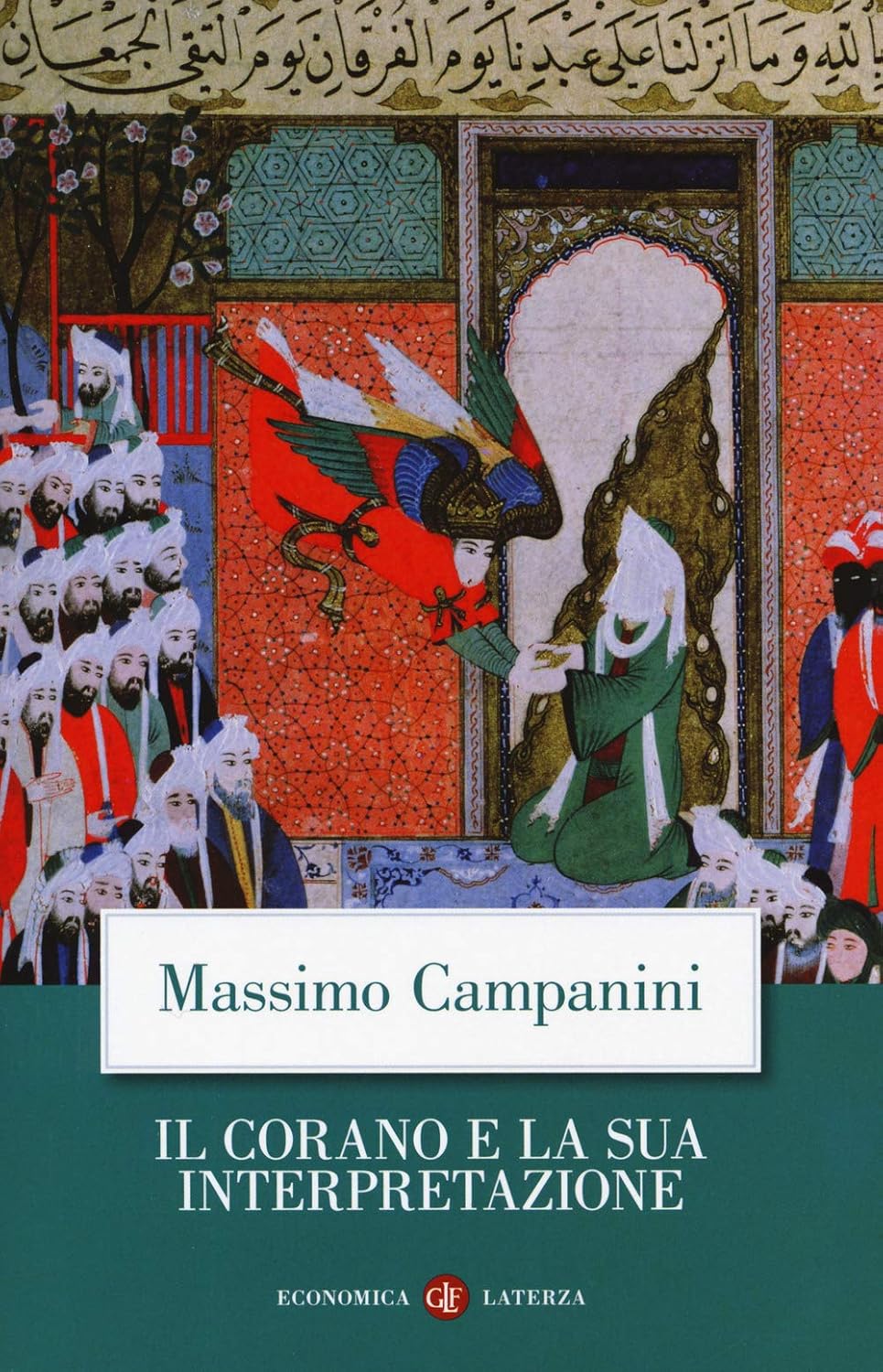
Commento all'articolo