Creature di un sol giorno – I greci e il mistero dell’esistenza – Mauro Bonazzi
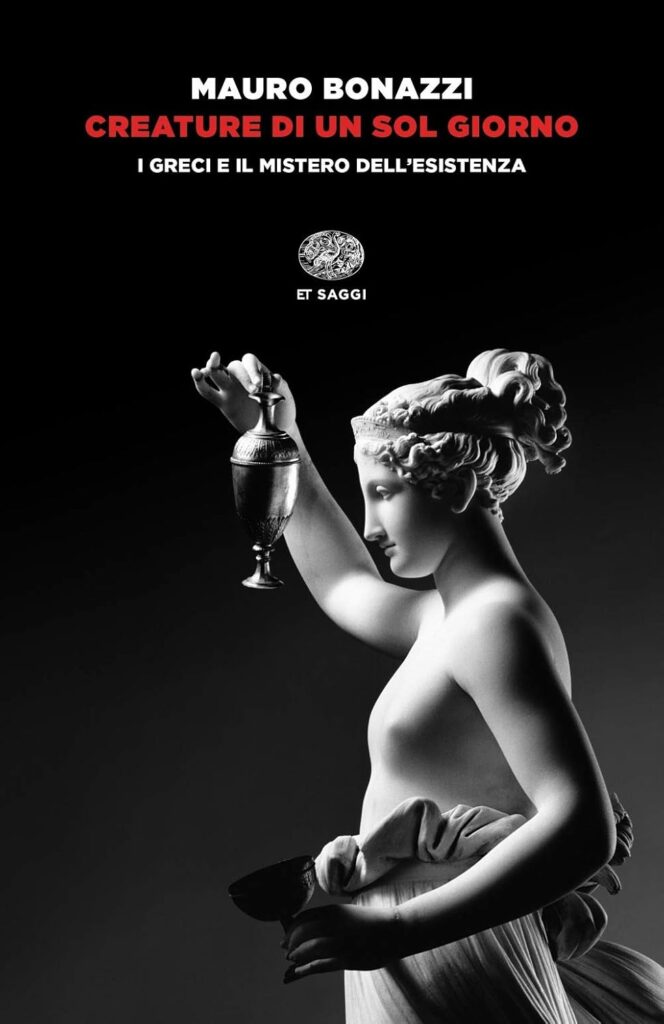
SINTESI DEL LIBRO:
La civiltà greca ha prodotto una riflessione luminosa sul senso
della condizione umana – su quello che siamo e sul valore delle
nostre vite – capace di attraversare i secoli, influenzando e
stimolando grandi scrittori e grandi pensatori. Lo ha fatto partendo
dal tema della morte: questo è il punto di attacco. La morte è uno
scandalo, un mistero, qualcosa che non riusciamo e non possiamo
accettare. Il problema non è tanto quello di dover morire; ne siamo
tutti consapevoli. A essere insopportabile è l’idea che questo fatto, il
fatto che prima o poi ce ne andremo, rischia di togliere valore alla
nostra esistenza, qui e ora. Quale è il senso di qualcosa che non
c’era, c’è e non ci sarà? Quale il valore di qualcosa destinato a
scomparire nell’oblio? È questa la domanda a cui bisogna trovare
una risposta, perché è qui la chiave per comprendere il senso della
nostra esistenza. Ci siamo noi e c’è questo immenso universo che ci
circonda: quale è la relazione? Siamo interamente riducibili a questa
realtà oppure no? E se no, qual è il senso di ciò che siamo e
facciamo? Come dare valore alla nostra esistenza? Le nostre
conoscenze si sono accresciute in modo esponenziale nel corso dei
secoli, ma queste domande sono ancora lí, in attesa di una risposta.
Offrirne una, con la pretesa che sia risolutiva, non è l’obiettivo di
queste pagine, che si pongono uno scopo molto piú modesto:
ricostruire le varie proposte che nel mondo greco (e in qualche
autore che su quella strada ha proseguito) sono state articolate, nel
tentativo di fare chiarezza su ciò che siamo. Esseri incompleti, noi
uomini siamo gli esseri desideranti per eccellenza. Ma di cosa siamo
davvero in cerca?
La tensione fondamentale che ci anima è quella che oppone
azione e conoscenza. Sono le due celebri definizioni dell’essere
umano di cui ha parlato Aristotele dando voce al sentire greco:
l’animale politico e l’animale razionale. Sembrano due definizioni
facilmente compatibili, di primo acchito. Non lo sono, come vedremo.
Per questo la nostra condizione è cosí complicata; il desiderio di
agire, di costruire e dimostrare quello che valiamo, non
necessariamente si accorda con il desiderio di capire, di
comprendere ciò che ci circonda e il nostro posto all’interno di un
universo immenso. E non è soltanto questo, naturalmente: se
comprendere la tensione tra vita attiva e vita contemplativa è
fondamentale, altre opposizioni non meno importanti, anche se piú
discrete, sono ugualmente decisive, nella misura in cui aiutano a
capire meglio quella centrale. Cosí il modello della vita contemplativa
si fonda sull’opposizione tra conoscenza e ignoranza, mentre il
modello della vita attiva si fonda sull’opposizione tra potenza e
debolezza. Ed è proprio nel rovesciamento di queste due polarità
che emerge la lezione forse piú interessante trasmessaci in eredità
dal mondo antico.
Non si tratta di una storia che procede verso una conclusione: a
ogni proposta si accompagnano dubbi e obiezioni, che ne mostrano i
limiti. Vale per la vita politica e vale per la vita contemplativa, che
costituiscono i due assi portanti della ricerca, perché è nell’azione e
nel pensiero che noi ci riveliamo per quello che siamo. Vale per la
poesia e per la filosofia, che su questi problemi si sono spesso
contrapposte. Non ci si propone insomma nessuna presa di
posizione in favore dell’una o dell’altra tesi, ma solo qualche
chiarimento, per aiutarci a vedere piú nitidamente i problemi e a
comprendere meglio la nostra complessità.
Raccontandoci le vicende di impavidi eroi e viaggiatori del
pensiero, di Achille o Atene, di Ulisse o dei filosofi, i Greci ci hanno
in fondo insegnato la bellezza della fragilità e l’importanza dei dubbi:
perché ancora non abbiamo costruito la città perfetta e neppure
abbiamo trovato le risposte di cui eravamo in cerca. Hanno cantato
la grandezza dell’eroe che inaugura il cammino politico degli uomini,
e hanno riflettuto sull’esigenza di conoscere e capire; anche questo
è un tratto fondamentale di ciò che siamo. Agire o conoscere?
Lontane e opposte, le due opzioni s’incontrano comunque in modo
inaspettato alla fine del percorso, ritrovando negli uomini lo stesso
impasto di miseria e grandezza. C’è qualcosa di patetico
nell’illusione di dominare gli altri e il mondo, o di conquistare e
comprendere tutti i segreti della realtà, in questa ambizione
ricorrente di diventare come gli dèi. Ma c’è anche qualcosa di eroico.
Siamo eroici proprio nella nostra fragilità ostinata, per questa
capacità di non arrenderci, di continuare a porci domande, tentando
di fare ordine nel mondo e in noi stessi, con le azioni e con i pensieri.
È una conclusione inattesa, insomma, se di conclusione si può
parlare, quella a cui sono arrivati i Greci. Erano partiti decisi a
sconfiggere la morte o a mostrarne la vanità e l’inconsistenza; alla
fine, però, quello che emerge è che proprio essa, o meglio la
consapevolezza del suo potere incontrastato, a renderci
propriamente umani: solo noi possiamo interrogarci e in parte capire
il suo mistero e il suo scandalo. Non lo possono gli animali o le
piante, e non lo possono neppure gli dèi, a cui i Greci hanno sempre
guardato con invidia. Non si tratta solo della morte. Altrettanto
importante è il tempo: anche di questo, del tempo che scorre, solo
noi – non gli animali, non gli dèi – possiamo capire la potenza
inesorabile. Anche questa sfumatura di significato, del resto, è
implicita in ephemeros, il termine che meglio di tutti esprime la
nostra condizione. «Creature di un sol giorno» sono gli uomini: e può
significare «esseri di breve vita» ma anche «esseri esposti, soggetti,
al mutare del tempo». Siamo esseri temporalmente determinati, e
dobbiamo imparare a vivere nel tempo, costruendo un equilibrio tra
noi e le cose, instabile ma comunque nostro. O meglio ancora – per
ripetere le parole di un grande poeta arcaico, Archiloco, citato in
esergo di questa prefazione – occorre imparare a riconoscere il
«ritmo» che domina l’esistenza degli uomini («conosci quale ritmo,
rusmos, domina gli uomini»). Non ci sono risposte definitive alla fine
della ricerca, ma solo la consapevolezza che il mestiere di vivere è
una sfida difficile, ma per questo appassionante.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :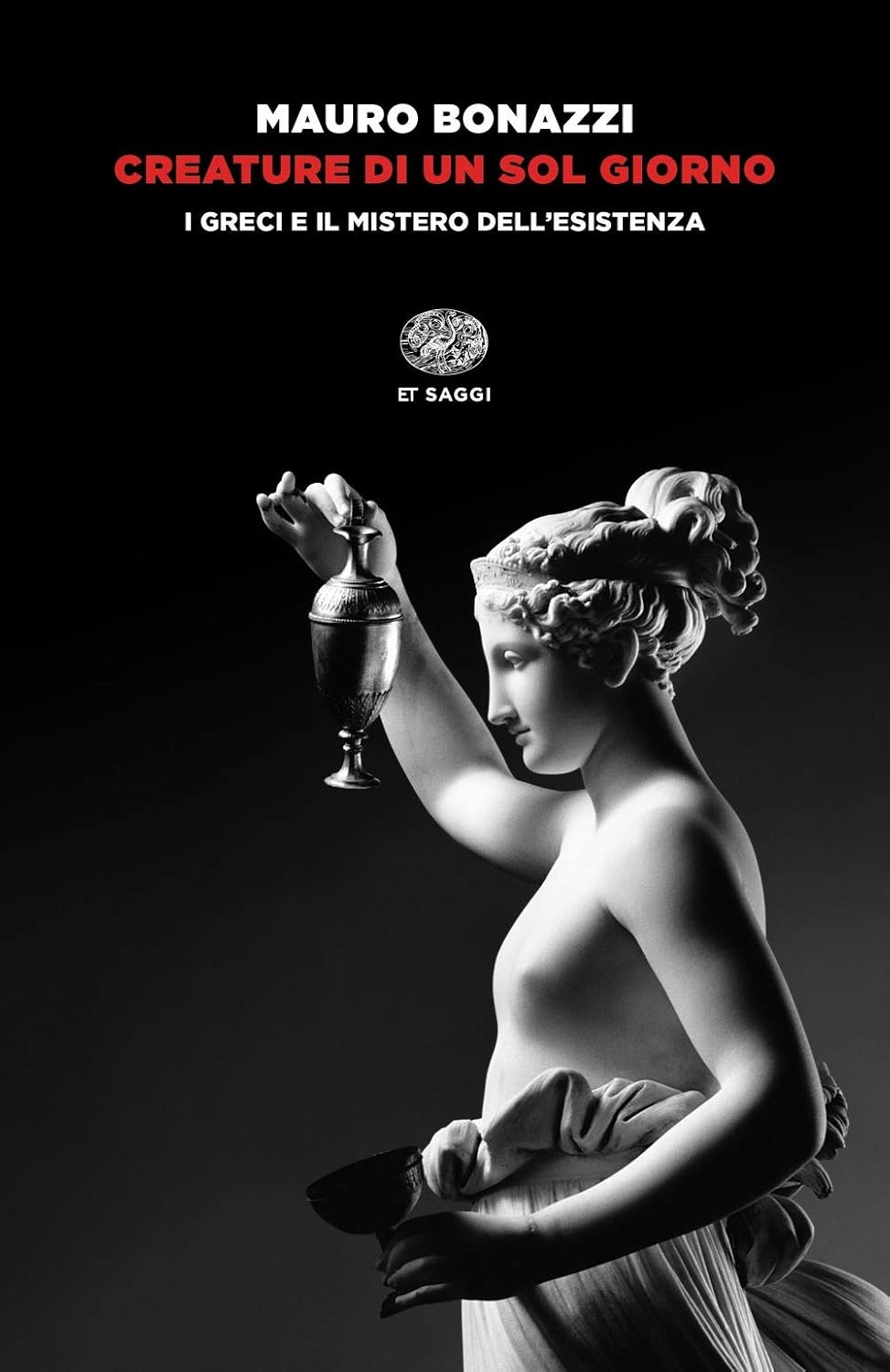






Commento all'articolo