La casa senza custode – Heinrich Böll
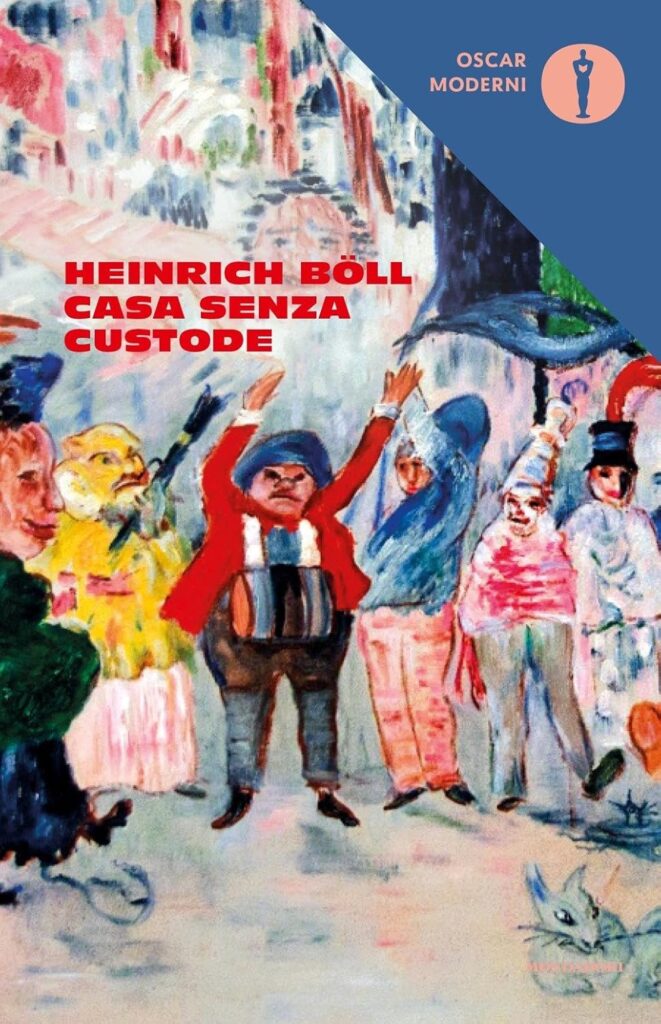
SINTESI DEL LIBRO:
Nelle riflessioni del giovane Heinrich, uno dei due ragazzi
protagonisti di Casa senza custode, Böll ha posto spunti significativi:
la ricerca di un’esistenza autentica non svilita da differenze di classe
o deformata da un passato che ancora ribolle sotto i paludamenti
conservatori del presente. La vita del ragazzo, costellata di privazioni
e di incertezze, si condensa in un’immagine che sfiora la sostanza
morale del libro: “era come camminare sul ghiaccio - pensa Heinrich
rispecchiandosi nella precarietŕ quotidiana -, sulla sottile lastra di
ghiaccio che copriva uno specchio d’acqua di profonditŕ ignota”.
Questa leggera ed ormai incrinata superficie, su cui valori e
presenze si relativizzano, č affollata da fantasmi maschili, dai tanti
Gert Erich Karl, surrogati frettolosi e indifferenti di quel padre morto
durante la guerra in qualche angolo di Russia.
Anche le loro tracce si disperdono e svaniscono nel tempo come
gli odori che si portano appresso. Resta solo qualche tangibile e
scomoda presenza come la sorellina Wilma, che la madre ha avuto
dall’ultimo amante, Leo, sbiadita immagine per Heinrich di solitudine
e vuoto affettivo.
Il mondo degli “zii”, degli amanti della madre (che riflette un reale
e difficile problema del primo dopoguerra tedesco), pur instillando in
Heinrich disagio e malessere, č paradossalmente l’unica veritŕ di cui
egli dispone.
Questa certezza lacerante e traumatica, invischiata in umiliazioni
e in un incessante disorientamento, non si traduce solo nel bisogno
di definire piů precisi paradigmi morali con cui stigmatizzare l’azione
e il comportamento degli adulti. Heinrich ha come sentore che la
precarietŕ della esistenza, con cui sua madre deve incessantemente
confrontarsi fino ad accettare i piů spiacevoli compromessi, sia una
realtŕ per alcuni inevitabile, una sorta di barriera che nasconde ogni
altro orizzonte. Gli č pertanto difficile supporre che un giorno o l’altro
non dovrŕ piů camminare sul ghiaccio: ci sono le crude condizioni di
vita a ricordarlo, il lunario da sbarcare, gli sguardi di riprovazione dei
vicini, i malumori o l’indifferenza degli “zii”.
Heinrich, l’orfano proletario, un susciŕ con spiccata tendenza
germanica all’autoriflessione, buon amministratore, nonostante l’etŕ,
delle scarse riserve familiari e sagace risparmiatore, č investito di un
compito che, in misura diversa, spetta anche all’amico Martin,
rampollo piů fortunato di famiglia borghese; mettere a confronto
ideologia e realtŕ, fragili speranze e durezza quotidiana e, non
ultimo, retorica pedagogica e sobrietŕ morale. Per questo ciň che il
maestro e il cappellano dicevano, “brulicava in un gioco di bolle
iridescenti e remote sotto la lastra di ghiaccio su cui egli camminava,
ma non arrivava mai fino a lui”. Nella prospettiva dei ragazzi, nel loro
rigorismo, che lascia filtrare la critica di Böll ad una societŕ che
predica bene ma razzola male, morale predicata e morale vissuta
divergono sensibilmente.
Simile a Woyzeck, anche Heinrich, piů che Martin, ha modo di
scoprire nel proprio destino il profondo legame che collega la morale
con la storia e con le condizioni materiali di vita degli individui ed
infine la sostanza dolorosamente umana di tante contraddizioni. “Per
lui esistevano tre mondi: - si dice di Heinrich nell’ultima parte del
romanzo - la scuola, tutto ciň che veniva loro detto a scuola e
durante l’ora di religione era in contrasto con il mondo di Leo, in cui
egli viveva, e il mondo di Martin era giŕ di nuovo un altro mondo”.
Egli non puň che rivendicare, a questo punto, la necessitŕ di un
proprio spazio esistenziale: l’autonomia di giudizio, ha compreso,
significa emancipazione da ogni idealizzazione o demonizzazione
della realtŕ.
Heinrich e Martin, orfani come tanti eroi
dickensiani, anelano, nella ricerca di un’ottica personale da cui
osservare il mondo e il proprio microcosmo sociale, ad un ruolo e ad
un’identitŕ, che anche gli adulti hanno smarrito. In tal senso Böll
ripercorre a modo suo la strada del vecchio romanzo di formazione
che ha scandito e registrato le varie tappe della borghesia tedesca.
In Casa senza custode il processo di maturazione rientra in una
dimensione psicologicomorale; la promesse du bonheur della realtŕ
resta per ora un interrogativo che le forze umanistiche presenti nel
romanzo - primo fra tutti Alberto - si pongono senza poter risolvere.
Martin, che riconosce inadeguate le risposte del catechismo
rispetto ad una realtŕ disarmonica e complessa spesso in contrasto
con il formalismo della precettistica religiosa, trova nella
contraddizione uno stimolo per maturare al dubbio e alla
responsabilitŕ. In quell’ultima suggestiva pagina del romanzo, che
mette fine ad una fase della sua vita, egli sembra accostarsi al
giovane Törless musiliano alle prese con una realtŕ spalancatasi per
un attimo sull’ambiguitŕ e la doppiezza: una fantasmagorěa che
incute qualche brivido, ma incide nell’adolescenza i segni d’una
critica consapevolezza.
Heinrich, dal canto suo, impara, soffrendo in silenzio la scelta
della madre di andar a vivere con il pasticciere, che il bisogno e le
necessitŕ materiali non escludono per sempre la speranza: quella
che balugina sul volto disfatto di sua madre mentre pensa ad
Alberto, laico redentore in un mondo di dolore e di scelte aspre ed
inevitabili.
Con Casa senza custode, pubblicato nel 1954, Böll ha scritto un
romanzo che non tematizza piů la guerra, trauma incontrastato della
sua primissima narrativa, ma ne scorge i riflessi nella ricostruzione,
difficile ed ambigua, del presente. Se l’ottica di Heinrich e Martin
diviene uno strumento prezioso per lacerare ogni velo di pietŕ o di
bonaria condiscendenza verso gli adulti, e per cogliere la realtŕ in
una dimensione di straniamento ironico e non di rado grottesco,
come nelle scene in cui č protagonista nonna Holstege, questa
prosa non intende tuttavia annodare le fila di una storia di
adolescenti disadattati o prematuramente coinvolti nella lotta per
l’esistenza. Piů che sulla loro presenza o sull’incrociarsi dei loro
destini, il romanzo č costruito sull’assenza di quei padri “giovanissimi
e sorridenti” che dai loro ritratti sembrano esorcizzare un passato
inoppugnabile. Appesi da qualche parte e mescolati come reliquie
fra amuleti e cianfrusaglie, i volti dei padriefebi, che talora, non a
caso, dileguano, come nel sogno di Martin, non sanno irraggiare
certezze e i loro sguardi si stemperano in una adolescenza
indefinita.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :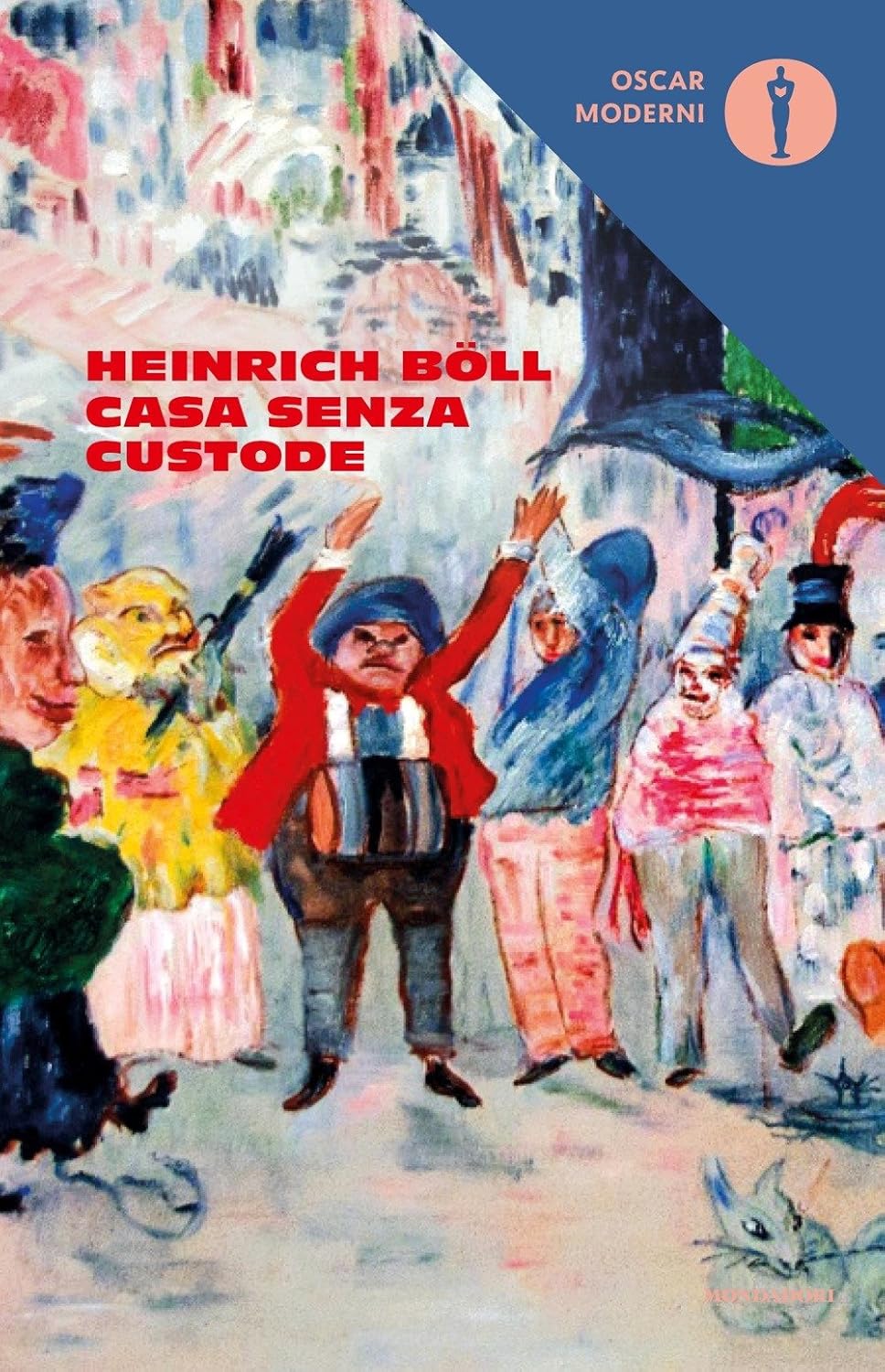






Commento all'articolo