Aspetti del nuovo radicalismo di destra – Theodor W. Adorno
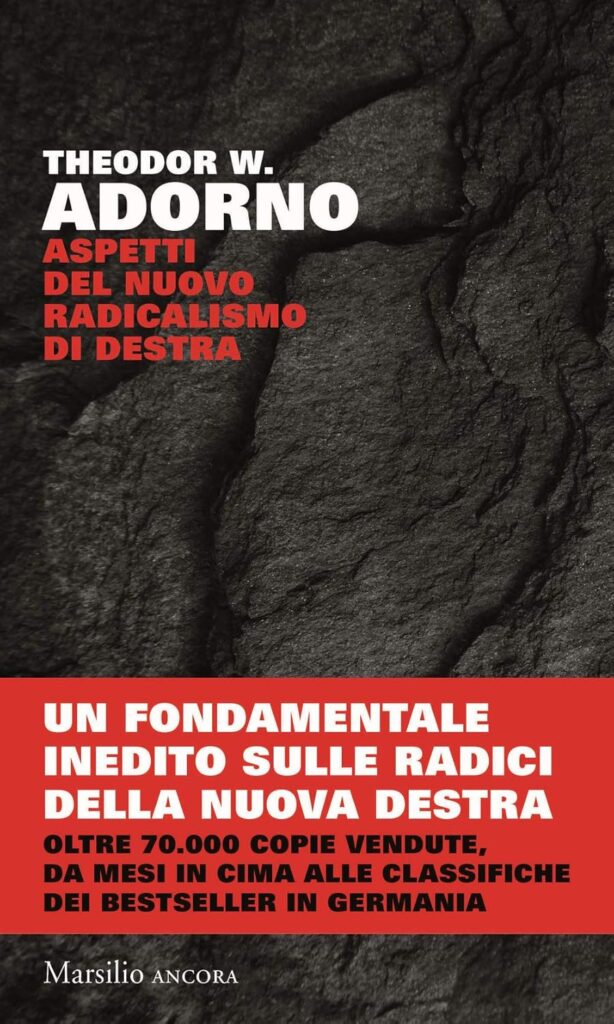
SINTESI DEL LIBRO:
Non ho intenzione di provare a offrirvi qui una teoria del
radicalismo di destra con ambizioni di completezza, ma di
sottolineare alcuni aspetti attraverso considerazioni sparse che,
tuttavia, potrebbero non essere così evidenti a tutti voi. Con ciò
non voglio escludere altre interpretazioni teoriche; voglio
semplicemente tentare di conferire maggiore compiutezza a
quello che in generale si sa e si pensa di queste cose.
Nel 1959 ho tenuto una conferenza dal titolo Che cosa significa
elaborazione del passato nella quale ho illustrato la tesi secondo
cui il radicalismo di destra, o il potenziale di un radicalismo di
questo genere, può essere spiegato con il fatto che, oggi come
allora, continuano a sussistere le premesse sociali del fascismo.
Vorrei partire dall’idea che, nonostante il loro crollo, le premesse
dei movimenti fascisti continuano a sussistere sul piano sociale, se
non anche su quello direttamente politico. Penso in primis alla
tendenza del capitale alla concentrazione, dominante oggi come
allora, della quale non si può affatto dubitare, per quanto la
statistica, con tutti i suoi artifici, tenti di farla scomparire dalla
faccia della terra. Questa tendenza alla concentrazione significa,
d’altro canto, oggi come allora, che resta sempre possibile il
declassamento di strati sociali che dal punto di vista della loro
coscienza di classe soggettiva risultano del tutto borghesi, i quali
intendono mantenere i loro privilegi e il loro status sociale e, ove
possibile, rafforzarli. Questi gruppi hanno sempre la tendenza a
odiare il socialismo o ciò che loro chiamano socialismo, ossia
danno la colpa del proprio declassamento potenziale non agli
apparati che lo producono, ma a coloro che si sono contrapposti in
chiave critica al sistema nel quale avevano potuto godere di quello
status. Che lo facciano ancora oggi o che questa sia tuttora la loro
prassi, è un’altra questione.
Il passaggio al socialismo o – più semplicemente – anche solo
l’adesione a organizzazioni socialiste è sempre stato molto difficile
per questi gruppi e oggi, per lo meno in Germania – la mia
esperienza si riferisce naturalmente in primo luogo alla Germania
–, è diventato ancora più difficile di quanto non fosse prima.
Soprattutto perché l’SPD, il Partito socialdemocratico tedesco, si
identifica con un keynesismo, con un liberalismo keynesiano che,
da un lato, modifica i potenziali di cambiamento della struttura di
classe per come erano stati definiti nella teoria marxiana classica,
e tuttavia, dall’altro, intensifica la minaccia dell’impoverimento,
quantomeno come conseguenza, per gli strati sociali di cui ho
parlato. Vorrei ricordare il semplice dato dell’inflazione, un
fenomeno strisciante ma facile da rilevare, che costituisce proprio
una delle conseguenze dell’espansionismo keynesiano, e vorrei
richiamare inoltre una tesi che ho sviluppato nel citato lavoro di
otto anni fa e che in questo periodo comincia a diventare sempre
più attuale: nonostante la piena occupazione e nonostante tutti i
segni di prosperità, lo spettro della disoccupazione tecnologica
continua ad aggirarsi tanto che, nell’epoca dell’automazione – che
indubbiamente in Europa centrale soffre ancora di un qualche
ritardo, il quale tuttavia verrà presto recuperato –, anche gli
esseri umani che si trovano all’interno del processo produttivo in
realtà si sentono già – per dirla in modo molto estremo –
potenzialmente superflui o potenziali disoccupati. A ciò si
aggiunge, naturalmente, la paura nei confronti dell’Est, proprio
per via dei bassi standard di vita e della mancanza di libertà cui
sono sottoposti realmente e senza mediazioni gli esseri umani e le
masse, oltre alla sensazione di una minaccia politica esterna
percepita almeno fino a poco tempo fa.
Bisogna ora ricordare la particolare situazione che domina
nell’epoca dei grandi blocchi di potere in merito al problema del
nazionalismo. All’interno di questi blocchi il nazionalismo
continua, infatti, a sopravvivere nei grandi gruppi di cui stiamo
parlando come organo della rappresentanza collettiva di interessi.
Non c’è dubbio che ci sia, tanto a livello di psicologia sociale
quanto sul piano reale, una paura molto diffusa di essere assorbiti
dai grandi blocchi e di restarne gravemente danneggiati sul piano
dell’esistenza materiale. Perciò, quando parliamo del potenziale
del radicalismo di destra nel settore dell’agricoltura, la paura nei
confronti della Comunità economica europea e delle sue
conseguenze per il mercato agricolo è molto forte.
Allo stesso tempo, però – e qui vorrei toccare la questione del
carattere agonistico del nuovo nazionalismo o del radicalismo di
destra –, esso ha qualcosa di finzionale nel rappresentare il mondo
raggruppato in questi due enormi blocchi, nei quali le singole
nazioni e i singoli Stati giocano un ruolo subordinato. Nessuno ci
crede più davvero. La singola nazione è straordinariamente
limitata nella sua libertà di movimento dall’integrazione nei
grandi blocchi di potere. Ma non bisogna trarne la conseguenza
affrettata che il nazionalismo, in quanto superato, non giochi più
un ruolo chiave; viceversa, accade spesso che alcune convinzioni o
ideologie assumano un aspetto demoniaco o autenticamente
distruttivo proprio quando non risultano più sostanziali in base
alla situazione oggettiva. I processi alle streghe non sono avvenuti
nei tempi in cui era in auge il tomismo, ma durante la
Controriforma, e qualcosa di analogo potrebbe accadere con il
nazionalismo «patico», se così si può chiamare. Già ai tempi di
Hitler c’è stato un momento simile, nel quale esso ci è stato
rifilato senza che ci si credesse davvero. E questa titubanza,
questa ambivalenza tra un nazionalismo ostentato e i dubbi che
esso suscita e che tornano a rendere necessario mascherarlo – per
convincere nello stesso tempo se stessi e gli altri – era già
osservabile allora.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :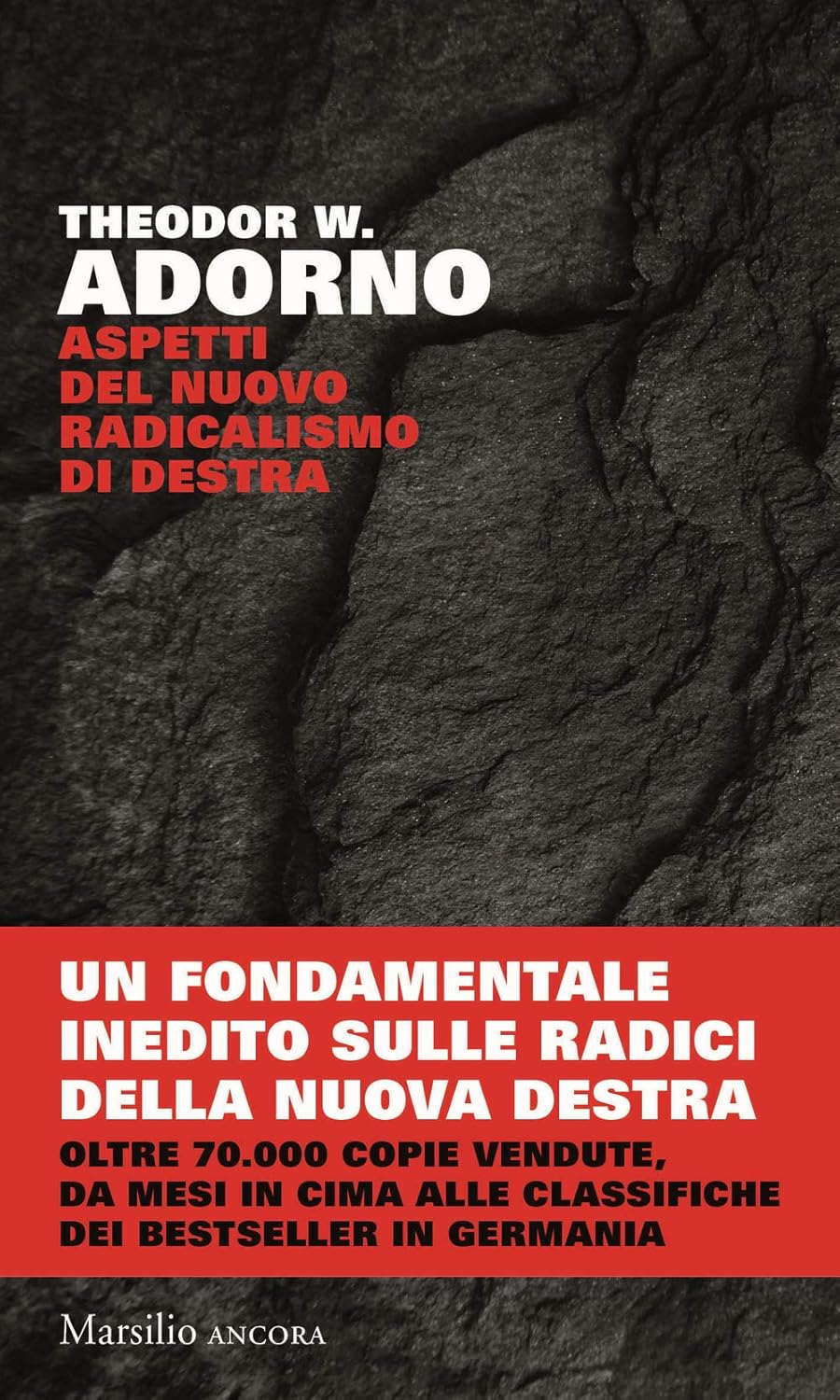






Commento all'articolo