Al Tayar – La corrente – Mario Vattani

SINTESI DEL LIBRO:
Impossibile senza occhiali da sole.
Li rimetto subito, dopo essermi asciugato la fronte e il naso col
fazzoletto. La luce mi abbaglia fin dentro l’automobile, dal
parabrezza, da dietro la nuca, dal finestrino.
Stiamo andando avanti a passo d’uomo. Di lato, vedo allontanarsi e
poi di nuovo avvicinarsi la grossa ruota di un camion.
Richiudo il vetro. Troppo fumo, troppa polvere ovunque, la sento
fino in fondo alla gola. Avrei dovuto prendere una bottiglietta d’acqua
in aeroporto, ma avevo troppa fretta di uscire, dovevo seguire il
gruppo di italiani con il cappellino giallo, quelli che forse mi hanno
salvato la giornata.
Le palme e le altre piante dalle grandi foglie opache che dividono le
corsie di marcia sono immobili, non c’è un filo di vento.
Bisogna respirare profondamente, riempire il torace. Bisogna
ristabilire il ritmo del cuore dietro lo sterno. La testa mi pulsa ancora
forte da quando abbiamo superato l’ultimo posto di blocco all’uscita
dell’aeroporto, non riesco ancora a rallentare i battiti.
Il cielo è di un azzurro perfetto, liscio, trasparente, eppure è come
se ritmicamente, ogni mezzo secondo, ma solo ai lati del mio campo
visivo, diventasse viola. È per via delle pulsazioni nelle tempie, che si
aggiungono al ritmo frenetico che anima tutto ciò che mi circonda, sia
dentro sia fuori da questo vecchio taxi scassato. Il ticchettio della
freccia, i colpetti di clacson di centinaia di macchine intorno a noi, il
riflesso cangiante del cd appeso allo specchietto retrovisore, che gira e
rigira mentre l’autista continua a picchiettare con le dita sul volante,
mastica la sua gomma americana, si piega in avanti per verificare
dove stia andando il furgone che ci stringe a sinistra, si sistema gli
occhiali sul naso, non sta mai fermo, né lui né le luci led azzurre della
sua radio, da cui chiacchierano in arabo un uomo e una donna, non c’è
nulla che si interrompa un istante per lasciarmi respirare, tutto
accelera, tutto si moltiplica finché mi sento mancare il fiato.
Sto sudando, ho la camicia attaccata alla pelle. Mi faccio aria più
forte che posso con il cappellino giallo, quello che mezz’ora fa ho
sottratto di nascosto dal carrello della signora con lo sguardo
rassegnato. C’è cucito sopra un logo con due chiavi e una tiara, è un
simbolo del Vaticano.
Mi dispiace per la signora, ma se non avessi avuto questo
cappellino non sarei riuscito a passare insieme a loro. Tutti quegli
italiani, con i berretti che li facevano sembrare la versione invecchiata
di una classe di bambini in gita scolastica, dovevano essere
sicuramente dei pellegrini. Per questo agli arrivi gli egiziani avevano
organizzato una fila a parte, dedicata solo a loro, un corridoio
preferenziale, sia per i visti, sia per il controllo passaporti. Nel caos è
stato facile mettere sulla testa il cappellino, estrarre il mio passaporto
italiano, abbandonare la fila dei passeggeri arabi arrivati con il mio
volo Middle East Airlines, e passare tutti i controlli insieme ai
pellegrini di Roma, che oltretutto mi somigliavano di più.
C’era una tale confusione nella hall degli arrivi che è stato come
muoversi nell’acqua. Una volta fuori, è bastato riprendermi il mio
trolley prima che venisse caricato sul loro pullman, e avviarmi verso i
taxi.
Forse è sempre così, in Oriente. Se fai finta di sapere cosa stai
facendo e dove stai andando, nessuno ti dice nulla, anzi fanno tutti
come vuoi tu, perché riescono a indovinare di cosa hai bisogno.
Infatti il tassista mi ha agganciato subito. Ero ancora lì a
scambiarmi un segno col portantino, che non capiva perché mi
allontanavo dai pellegrini e me ne andavo via con una delle valigie.
Ma gliene importava poco in realtà, poiché io con gli occhi gli facevo
capire che era tutto ok, che il trolley era mio e che andava bene così, e
l’autista del taxi che voleva portarmi con sé ormai faceva segno anche
lui al portantino che era tutto ok, e diceva tutto ok anche a me, tutto
ok, e facevamo tutti parte di un ampio movimento fluido, un triangolo
fatto di occhiate e di sorrisi che progressivamente si allargava finché
da un momento all’altro ero seduto in quest’automobile, con il mio
trolley, dietro al mio tassista.
«Where from?»
È la seconda volta che me lo chiede, vedo i suoi occhi riflessi nello
specchietto retrovisore. Ho il cappello da pellegrino, potrei dirgli che
vengo da Roma e basta.
«Marriott. Marriott Hotel, Zamalek.»
Lo avevo già detto prima, e ora glielo ripeto, anche se è la risposta
sbagliata. L’autista scuote la testa con un mezzo sorriso, e guarda di
nuovo il traffico, masticando la gomma. Si sta annoiando, voleva farsi
una chiacchierata.
«I’m sorry, no english» gli aggiungo, così mi lascia in pace.
Non mi va di dirgli che arrivo da Londra, magari mi stanno
cercando adesso, all’aeroporto. Senza far rumore, inizio a strappare
l’anello di carta con il codice che è ancora attaccato alla maniglia del
trolley.
Quando mi sarò sbarazzato di questa roba potrò stare tranquillo.
Sono riuscito a nascondere nella valigia il pacchetto trasparente che
sembra materiale medico, svuotando semplicemente il mio nécessaire.
Invece il blocchetto di cartoni per ricomporre le scatole di medicinali
sono riuscito a sistemarlo di piatto, sul fondo del trolley. I blister con
un’infinità di pasticche ho dovuto infilarli a strati fra le camicie e le
magliette. Erano talmente tanti che mi hanno riempito metà del
bagaglio.
Non ho avuto molto tempo per sistemare tutto, perché la hostess
nervosa a Heathrow con gli occhi super truccati e l’uniforme della
MEA mi ha consegnato la merce al gate, in una busta del duty free,
quando ormai avevano appena chiamato il volo per Beirut, dove ho
fatto scalo in piena notte. Era terrorizzata. Ho dovuto riorganizzare di
corsa il bagaglio chiudendomi nel bagno dei disabili, sempre col
dubbio che qualcuno mi stesse osservando attraverso una telecamera
nascosta. Sono sicuro che a Heathrow ci sono telecamere nascoste
anche nei gabinetti.
Io non so che roba sia, quella che mi hanno dato, ma sicuramente è
illegale. A prima vista sembrano medicine, durante tutto il viaggio ho
continuato a pensare che quei bastardi volessero semplicemente farmi
prendere dagli egiziani, usarmi come specchietto per le allodole,
sviare l’attenzione da un trasporto molto più importante. È gente che
senza farsi tanti problemi manda cocaina fino in Giappone nei
container, ho pensato, figuriamoci se perdono tempo a far arrivare in
Egitto qualche chilo di pasticche su un volo Londra-Beirut-Cairo.
Per questo alla fine ho tentato il trucco del cappellino giallo.
Da quando siamo usciti dallo stradone di Heliopolis, il traffico
scorre meglio. Ci siamo immessi in un sistema di alte e strettissime
sopraelevate da cui si scorge la linea dell’orizzonte, e così ora
planiamo su questa città color sabbia da dove spuntano qua e là dei
grattacieli bassi e tozzi, centinaia di moschee con le loro torri di tutte
le forme, ma anche chiese, campanili, e poi dei ciuffi di verde
polveroso a perdita d’occhio.
Sono riuscito a rallentare il mio battito cardiaco. Forse a
tranquillizzarmi è stata questa strana caotica armonia intorno a noi,
un equilibrio che ha qualcosa di liquido, una serenità cadente,
rassegnata. È come se alla nostra velocità sonnolenta stessimo
seguendo un percorso sottomarino. Come se, ancorati alle rotaie di un
angusto corridoio di cemento armato, stessimo sfiorando palazzi che
somigliano a grandi rocce bucherellate a cui si sono attaccate nei
decenni, come strani molluschi elettronici, migliaia di antenne
paraboliche di tutte le dimensioni.
È la prima volta che vengo in Egitto, la prima volta che vedo la sua
capitale, e finalmente riesco ad appoggiare la nuca indietro sul sedile,
perché adesso dal finestrino aperto entra un’aria secca che sa di
benzina, di asfalto e di pneumatici bruciati, e che in qualche modo mi
rasserena, e finisce di svuotarmi.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :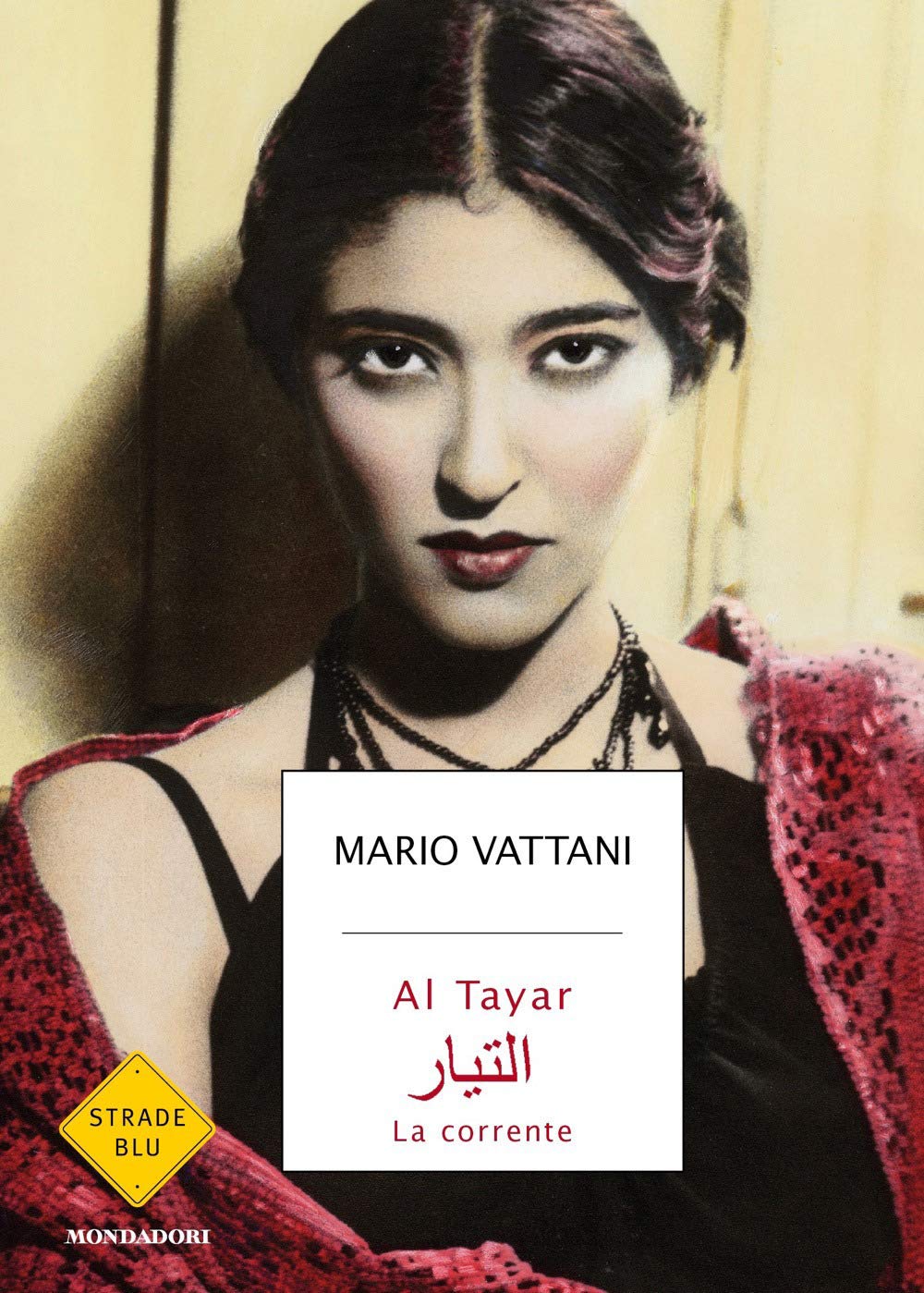






Commento all'articolo