Abuso di parola, abuso di potere – Josef Pieper
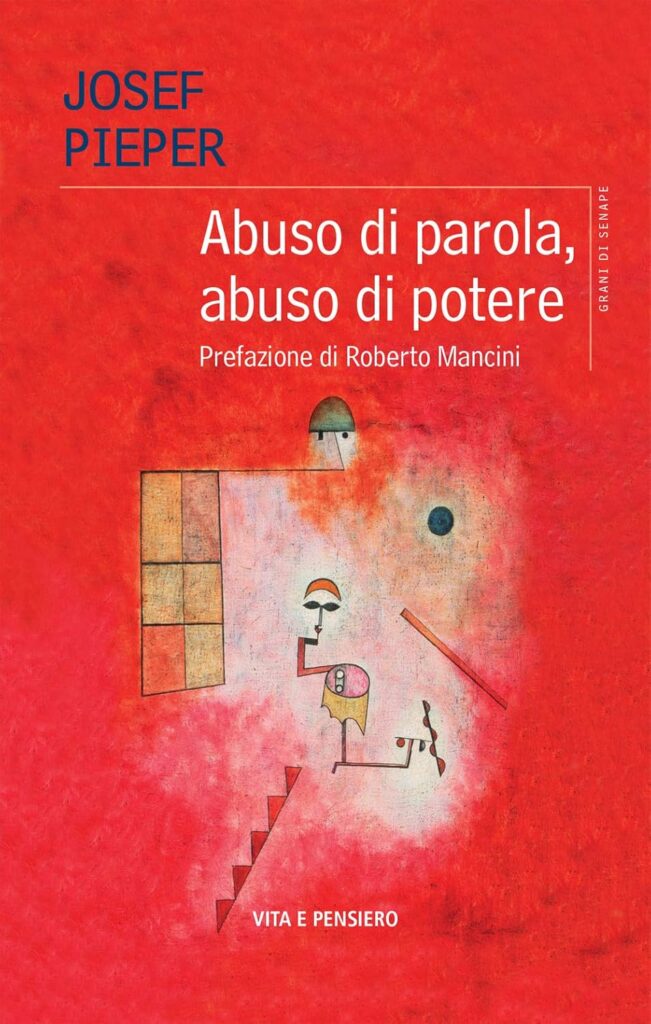
SINTESI DEL LIBRO:
All’argomento di questa riflessione – che si potrebbe anche formulare
come: «l’abuso di linguaggio e il suo nesso con l’abuso di potere» –
vorrei accostarmi seguendo due percorsi diversi tra loro, di cui
tuttavia proverò a mostrare l’intima connessione.
Il primo riguarda la storia del pensiero antico, in particolare la
battaglia condotta per tutta la vita da Platone contro i sofisti, quei
maestri nell’arte della distorsione del linguaggio ben pagati e
sostenuti dal plauso delle masse, in grado di esaltare il negativo
trasformandolo in positivo e di rendere nero il bianco. Si tratta di quei
personaggi che Platone nei suoi dialoghi mette a dibattere con
Socrate. Tuttavia non è la dimensione storica ciò che in questo caso
mi interessa in modo particolare. La posizione di Platone, e questo è
il secondo percorso, dovrebbe essere considerata anzitutto come un
caso esemplare in cui, a mio parere,leggenditaly.com si possono
ravvisare alcuni elementi che riguardano direttamente la nostra
situazione oggi. Vi sono buone ragioni per ritenere che Platone abbia
riconosciuto, citato e combattuto, nella sofistica a lui contemporanea,
un pericolo e una minaccia che accompagnano da sempre la vita
dello spirito e la vita della società.
Ciò che dunque, nel seguito, potrebbe sembrare a un primo
sguardo una descrizione e un’interpretazione puramente storiche
deve invece essere inteso nel senso di una precisa allusione
all’attualità. E, al contrario, ciò che sembrerà inizialmente una mera
critica dell’epoca presente, riferita al solo momento attuale, vorrei che
fosse compreso come il riferimento a una tentazione eterna contro
cui l’essere umano nella storia è stato da sempre chiamato a
resistere e continuerà a esserlo anche in futuro. A proposito di questo
significato atemporale, sempre attuale, del fenomeno della sofistica,
Hegel ha espresso alcune osservazioni significative, ma anche
inquietanti. Egli definisce i sofisti dell’epoca di Socrate «gente molto
colta», un elogio però piuttosto ambiguo nella terminologia hegeliana.
Proprio in questa cultura, afferma Hegel, in questa riflessione che
dissolve ogni oggetto, che con la dialettica mette in questione tutto, in
questa riflessione libera e pensante, in questo «ragionamento colto»
– locuzione ricorrente in Hegel – si annida un elemento pericoloso.
Quasi inevitabilmente, infatti, si è portati a credere che, se tutto
dipende dalle ragioni addotte, si può dimostrare qualunque cosa.
«Non si ha una cultura molto sviluppata», afferma Hegel, «se non si è
in grado di difendere con buone ragioni le peggiori convinzioni. Ciò
che da Adamo nel mondo è avvenuto di male è avvenuto per ottime
ragioni». Secondo Hegel, si tratta evidentemente di un pericolo
immanente, intrinseco allo spirito, superabile forse, ma non evitabile
fin da principio. Un pericolo che può diventare tanto più minaccioso
quanto maggiore è il livello di coscienza critica, di cultura, dunque.
Potrebbe essere assolutamente vero ciò che viene scritto nelle
monografie sui sofisti: Werner Jäger, dopotutto, li ha definiti «i primi
umanisti»; altri li hanno elogiati come grandi pedagoghi e maestri di
didattica, come alfieri della libertà spirituale e così via. Tutto ciò
potrebbe essere assolutamente vero. Ma l’aspetto complesso e
problematico risiede nel fatto che, proprio sulla base di queste
conquiste, viene reso possibile quel fenomeno distruttivo che anche
per Hegel è indicato propriamente dal nome «sofistica». E su questo
punto il filosofo tedesco sta chiaramente al fianco di Platone.
Entrambi parlano di qualcosa di attuale che va oltre le loro epoche,
entrambi parlano di un pericolo che sempre minaccia lo spirito e la
società.
Ma, naturalmente, in questo modo non è soltanto il fenomeno della
sofistica a tornare di nuovo attuale e interessante, ricevendo
probabilmente un’attualità sempre maggiore in misura della
progressiva differenziazione della coscienza. «La sofistica non è così
lontana da noi come si pensa», afferma Hegel. E vorrei prendere
questa frase come motto implicito di quest’intera mia riflessione,
insieme alla nota postuma di Nietzsche: «L’epoca dei sofisti? La
nostra epoca!». Come dicevo, non è soltanto la sofistica a diventare
di nuovo interessante sotto questo profilo, ma forse lo sono ancora di
più le argomentazioni contrarie di Platone, il suo confronto con essa.
Ma su quale punto egli si oppone propriamente alla sofistica? Dove
rinviene il suo aspetto peggiore? Che cosa esattamente vede
minacciato da essa? A che cosa, secondo Platone, non si può
assolutamente rinunciare affinché l’essere umano possa condurre
una vita autenticamente umana? Dunque, di nuovo: qual è il punto su
cui Platone si oppone ai sofisti?
L’aspetto esteriore di questi uomini, come tratteggiato nei dialoghi
platonici, è piuttosto noto. Ma ci sono tratti ovvi e altri meni ovvi, e
qualcuno che ovvio lo è solo in apparenza.
Anzitutto, questi uomini hanno un successo di tipo molto
particolare, circostanza cui Socrate rivolge di continuo la sua ironica
ammirazione. Si tratta della vendita della sapienza, dell’ignoranza
sull’incommensurabilità tra denaro e spirito, come se non sussistesse
differenza tra ciò che un tempo erano le artes liberales e ciò che noi
oggi chiamiamo lavoro intellettuale, come se non sussistesse
differenza tra onorario e stipendio. La questione è molto più attuale di
quanto sembri a prima vista. Bertrand Russell, nella sua Storia della
filosofia occidentale, ha osservato in modo piuttosto sprezzante che i
professori di oggi non avrebbero alcun diritto a mettersi sul piedistallo
e contestare i sofisti perché si facevano pagare per i loro discorsi.
Anche loro infatti ricevono denaro – e non poco. Ma ciò non coglie il
punto decisivo. In questo quadro il punto decisivo, quello
dell’incommensurabilità, non viene affatto sollevato. Esso viene
invece citato in modo molto più chiaro da un’osservazione incidentale
di Socrate. Nel Cratilo – che, per inciso, si occupa anche del
problema del linguaggio – si sta parlando di una questione specifica
che ora non ci interessa approfondire. Socrate tace, finché gli viene
chiesto: «Qual è la tua opinione, Socrate?». E lui allora risponde: «Se
io avessi già ascoltato da Prodico [uno dei maggiori sofisti!] il suo
corso da cinquanta dracme […] nulla impedirebbe che tu venissi a
conoscere subito la verità […]: invece, di fatto, ho seguito il suo corso
da una dracma. Di conseguenza, non so quale sia la verità su tale
problema». Ecco che viene espresso in modo molto più chiaro il
punto decisivo in questione.
Qualche anno fa, un amico di Einstein ha pubblicato sulla
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» alcuni ricordi in cui, tra l’altro,
racconta che Einstein un giorno gli avrebbe detto: «Un’università
americana mi ha offerto mezzo milione di dollari per l’originale in
dodici fogli manoscritti della Teoria della relatività. Quest’offerta mi ha
fatto passare un brutto momento. Non si può vendere lo spirito». E
Sartre, nella Presentazione nel 1945 del primo numero della rivista
«Les Temps Modernes», affrontando la situazione dello scrittore nella
nostra epoca, toccava certo molti punti, ma anche quello di cui ci
stiamo occupando: «Perché mai proviamo imbarazzo, perché
arrossiamo quando si parla di denaro? Riceviamo semplicemente
uno stipendio, come ogni altro lavoratore!». Per un sonetto da
quattordici versi, si riceverà allora un onorario a verso, oppure una
paga oraria, o che altro? Forse si è impiegato soltanto cinque minuti
per scriverlo, o magari sei mesi! Il punto essenziale sta
nell’incommensurabilità tra denaro e spirito. Bisogna tenerlo
presente, a mio parere, se si vuole trattare questi argomenti nel
senso di Platone.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :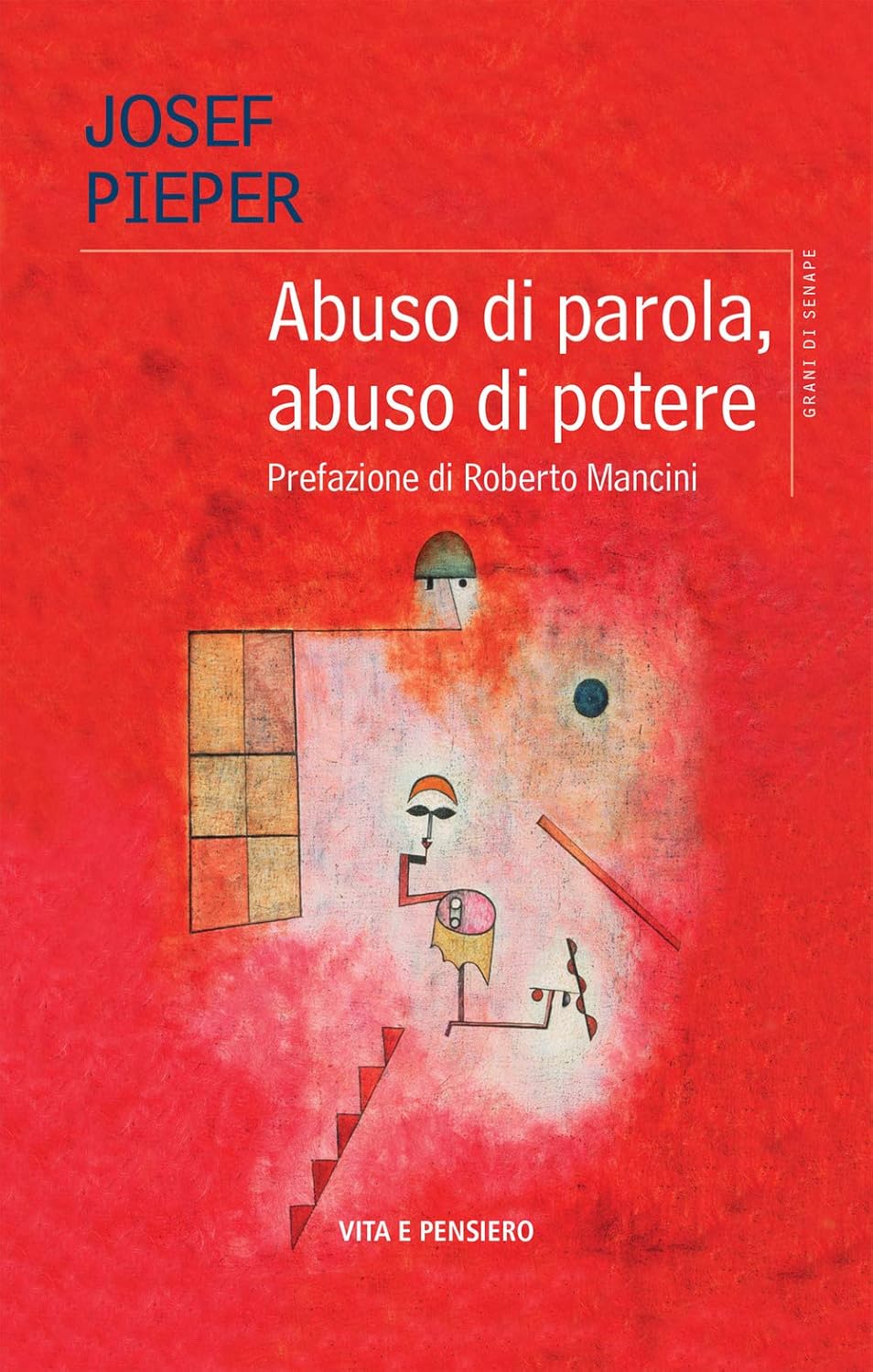






Commento all'articolo