Una visita guidata – Alan Bennett
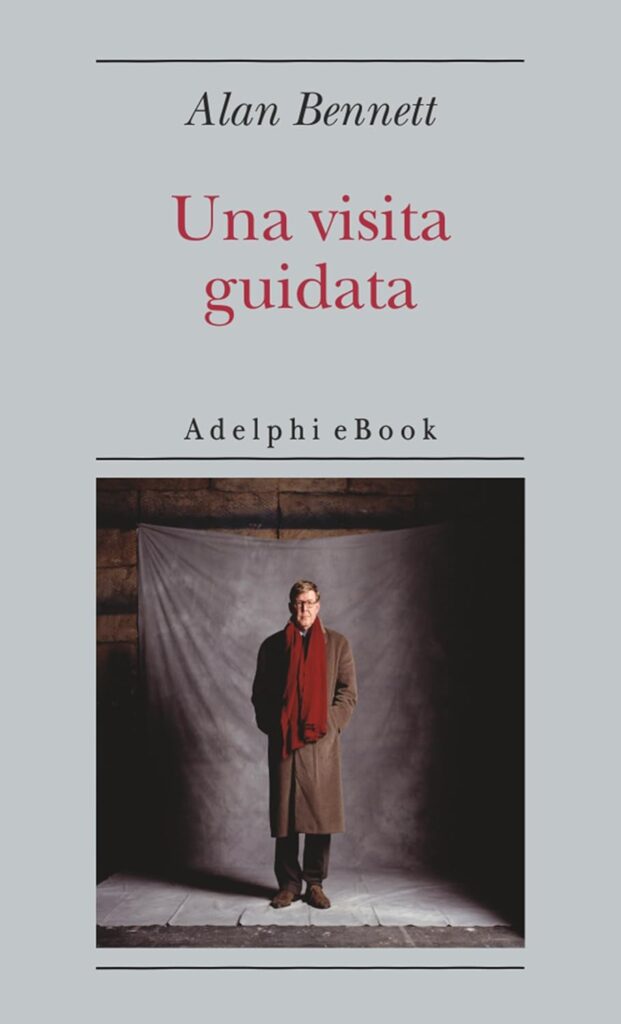
SINTESI DEL LIBRO:
Fui nominato trustee della National Gallery nel 1993, in
un momento in cui l’ingresso gratuito nei musei e nelle
gallerie statali era ancora argomento di dibattito, mentre
spero che oggi non lo sia più. Fu in quel periodo che tenni
questa conferenza, incentrata sul mio rapporto con la
pittura e le esposizioni d’arte in generale. Naturalmente
non tutte le immagini proiettate per l’occasione sono
riprodotte qui, ma mi auguro che il testo sia comunque di
piacevole lettura.
La prima volta che misi piede alla National Gallery era, se
non sbaglio, l’inizio del 1957, e fu per guardare il Dittico
Wilton – due pannelli realizzati alla fine del Trecento da un
artista ignoto su commissione di Riccardo II. Il sovrano è
inginocchiato nel pannello di sinistra ed è accompagnato da
un trio di santi – Edmondo, re e martire, Edoardo il
Confessore e Giovanni Battista – che lo presentano al
cospetto della Vergine. La Vergine, nel pannello di destra, è
circondata da un coro di angeli che, in segno di celestiale
sintonia e incoraggiamento, ostentano sulla veste il cervo
bianco, lo stemma, appunto, di Riccardo II.
Si tratta probabilmente di un piccolo altare portatile, e
nel 1957 era l’unico dipinto di tutta la National di cui
sapessi qualcosa. Non perché avessi nozioni o interessi nel
campo della storia dell’arte – che peraltro nel 1957 e-ra
piuttosto in ombra, bazzicato, almeno a Oxford, soprattutto
da saccenti mocciosi di Stowe e giovani sottoprodotti di
Ronald Firbank. No: sapevo qualcosa del Dittico Wilton solo
perché quell’anno seguivo un corso di storia su Riccardo II,
del quale continuai a occuparmi anche dopo la laurea,
quando rimasi a Oxford come ricercatore.
La mia ricerca non approdò a nulla e anzi, di tanto in
tanto – quando tengo una conferenza, ad esempio –, mi
tornano in mente ricordi piuttosto mortificanti. Le
conferenze non sono l’attività naturale del commediografo,
abituato com’è a spartire la responsabilità di quel che dice
con i suoi personaggi, tanto che il pubblico non sa mai chi
stia parlando, se io o loro. Mi capitò solo una volta di
tenere una conferenza su Riccardo II, presso una società
storica a Oxford, davanti a un pubblico di professori e
studenti. Alla fine di quel discorso assai poco elettrizzante
chiesi se ci fossero domande. Seguì un silenzio infinito,
finché un timido studente dal fondo alzò la mano:
«Potrebbe dirmi dove ha comprato le sue scarpe?».
Non molto tempo dopo abbandonai gli studi storici per
dedicarmi al palcoscenico.
Dissolvenza: ci troviamo ora a Boston qualche anno dopo,
e sono in tournée con il mio Beyond the Fringe. Un
pomeriggio libero vado a Fenway Court, il museo e l’ex
domicilio dell’ereditiera bostoniana Isabella Stewart
Gardner (ricorderete il celebre ritratto che le fece
Sargent). La casa è rimasta in gran parte com’era ai suoi
tempi, e la ricordo un tantino trasandata. Da allora forse ci
hanno fatto dei lavori – l’ultima volta che l’ho vista era il
1975 –, ma spero proprio di no, è quel tipo di museo così
esemplare del suo tempo che dovrebbe proprio stare in un
museo.
La maggior parte dei quadri della collezione di Mrs
Gardner fu scelta e acquistata per lei da un americano
trapiantato in Europa – per l’esattezza un bostoniano
trapiantato –, lo storico e intenditore d’arte Bernard
Berenson. Mrs Gardner morì nel 1924, ma nel 1962,
quando visitai per la prima volta il museo, Berenson era
morto da poco e venivano pubblicati regolarmente suoi
diari, biografie e zibaldoni. Così mi sono interessato a lui.
In retrospettiva vorrei non averlo fatto, perché molte delle
mie ansie sull’arte – di cui parlerò parecchio in questa
conferenza – risalgono a quel periodo.
Sebbene Berenson abbia raccolto in seguito un grande
archivio fotografico, i suoi studi e la sua schedatura dei
pittori italiani ebbero inizio prima che le riproduzioni delle
opere fossero agevolmente reperibili. In qualche modo
questo determinò il suo metodo, anche se sospetto che, foto
o non foto, il metodo di Berenson sarebbe comunque stato
lo stesso: consisteva, molto semplicemente, nel guardare,
guardare, e ancora guardare. Era capace di restare per ore
davanti a un dipinto, finché ogni minimo dettaglio non gli si
imprimeva nella memoria.
A un certo punto, nel corso della sua contemplazione,
Berenson veniva travolto da una sorta di estasi, molto
simile, immagino, a ciò che tante più persone provano
ascoltando la musica. E non è casuale che il suo mentore,
quando il giovane Berenson arrivò a Oxford da Harvard, sia
stato Walter Pater, il cui motto più celebre è, mi pare:
«Tutta l’arte aspira alla condizione della musica».
Devo confessare di non aver mai sperimentato un senso
di estasi, o comunque una forte sensazione fisica, stando in
piedi di fronte a un quadro, tranne forse un certo dolor di
gambe o, per citare Nathaniel Hawthorne, «Quel freddo
demone della spossatezza che infesta i grandi musei».
Eppure succede: i quadri influiscono fisicamente sulle
persone che li guardano. Prendiamo George Eliot, nel 1858:
«Ero seduta su un divano della Kunstgalerie di Dresda, di
fronte a un dipinto (era la Madonna Sistina di Raffaello), e
una sorta di meraviglia, come se all’improvviso mi trovassi
in presenza di un essere traboccante di gloria, mi fece
sobbalzare il cuore a tal punto che non potei star ferma e
dovemmo precipitarci fuori della sala».
Be’, a me non è mai capitato nulla del genere, e avendo
letto di Berenson ero convinto che mi mancasse qualcosa,
se non altro la pazienza o la resistenza fisica per restare a
guardare abbastanza a lungo. In seguito ho scoperto che
rispetto a quella carenza di sensazioni ero in ottima
compagnia (Bertrand Russell, per esempio, che era cognato
di Berenson, si crucciava che i quadri non gli dessero mai
neanche il voltastomaco) ma nei musei mi sentivo sempre
bocciato all’esame di sensibilità, e ogni volta me ne uscivo
con un senso di inadeguatezza.
Prima mi succedeva quando uscivo di chiesa. Da ragazzo
ero molto religioso, e la mia incapacità di reagire
emotivamente ai dipinti era simile alla mia incapacità di
provare sentimenti per Dio: si presumeva che uno dovesse
amarLo, ma io non capivo che cosa significasse. Quei
patemi me li ero lasciati alle spalle da tempo, ma ora mi
ritrovavo daccapo – solo che stavolta era con l’Arte.
Leggere di Berenson mi ha messo ansia anche sul piano
sociale. Via via che avanzava con l’età, il Saggio teneva
corte nella sua villa di Fiesole, I Tatti, dove riceveva non
solo gli amici del mondo dell’arte, ma chiunque fosse
qualcuno e si trovasse a passare di lì. Nessun premio Nobel
è mai stato mandato via.
Tutti i suoi ospiti dovevano assecondare la sua meticolosa
presentazione di sé e il suo inflessibile cerimoniale. Pochi
protestavano, perché evidentemente quello stile di vita
privilegiato appariva loro come una forma di devozione
all’arte, con la quale – per come la vedo ora – aveva in
realtà ben poco a che fare.
Mi accorgo col senno di poi che Berenson a quel tempo
mi metteva in agitazione, tanto è vero che stavo scrivendo
una cosa su di lui. Quando ho cominciato a scrivere,
all’inizio degli anni Sessanta, ero spesso spinto da un
sentimento di ambivalenza, e mediante la pièce teatrale o
lo sketch o qualunque cosa fosse mi sforzavo di prendere
posizione. Sicché quando, nel 1964, scrissi la parodia di
una visita a Berenson e la intitolai Ta Ta I Tatti, stavo dando
voce ai miei dubbi su quella santificazione sociale dell’arte.
In effetti, ripensandoci, non so proprio perché mi sia
preso la briga di farlo. Rileggendo Berenson per questa
conferenza, l’ho trovato insopportabile e stupido. Come si
può prendere sul serio uno che, in un carteggio con Ernest
Hemingway sull’argomento del sesso, scriveva di se stesso
che «aveva amato molto ma copulato poco, sebbene con il
piacere che si destinerebbe a dell’ottimo champagne»?
Oltre a essere pretenzioso, Berenson era anche un
briccone. Per gran parte della sua vita è stato a libro paga
del mercante d’arte Duveen; vale a dire che le sue
attribuzioni erano spesso basate, più che su considerazioni
accademiche, sull’interesse personale. Berenson ha influito
più sulla storia delle collezioni e dei musei americani che
non da noi; ma ha avuto un ruolo nella complicata vicenda
della Schiavona di Tiziano, acquisita dalla National Gallery
nel 1942, e che all’inizio lui riteneva fosse una copia di un
Giorgione perduto.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :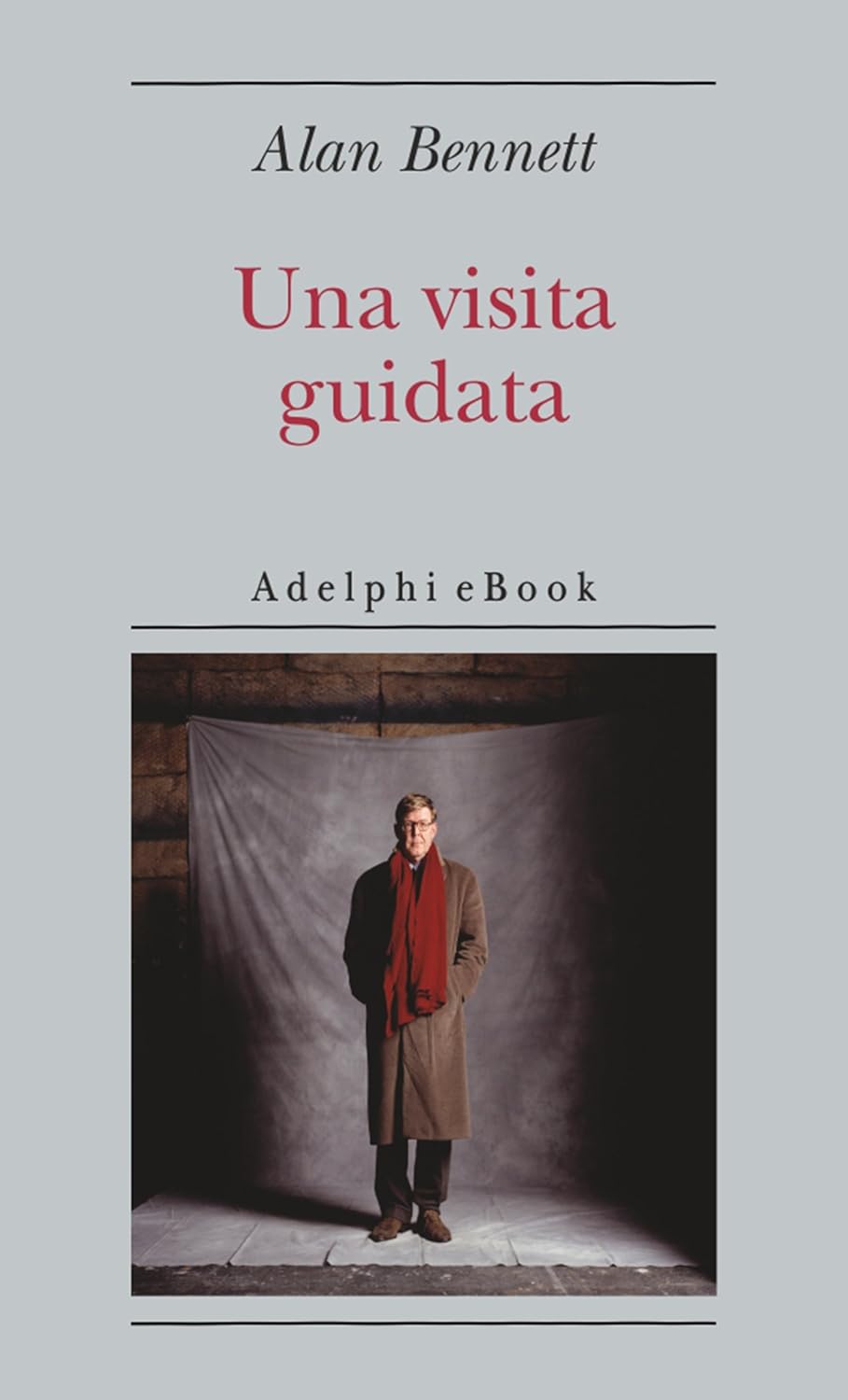






Commento all'articolo