Una giovinezza inventata – Lalla Romano
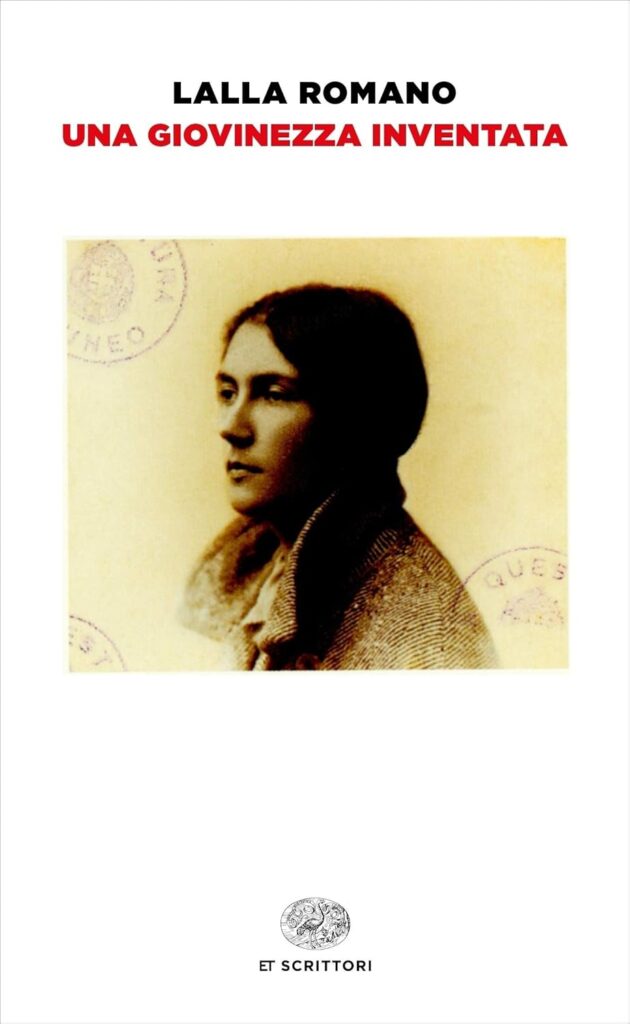
SINTESI DEL LIBRO:
Suppongo che a quel tempo le valige fossero tutte a soffietto;
comunque la nostra io la portavo con disinvoltura. Era di pelle –
come faceva notare la mamma – e non pareva che in fatto di valige
si potesse andare piú in là. Doveva risalire al viaggio di nozze e
certo era servita nei viaggi di prima della guerra, quando, secondo
una mia impressione, eravamo stati ricchi. Non credo che la valigia
fosse molto pesante, quel giorno; del resto la portava papà.
Quel giorno papà aveva un’aria speciale. Avevo sempre
osservato che in viaggio appariva piú signore. Aveva la sua aria
distratta e insieme concentrata, ma, a differenza del solito, un po’
triste, quasi di cortese rassegnazione; eppure mostrava anche un
vago orgoglio come se partecipasse a una solennità. Infatti portava –
come al concerto – gli occhiali: d’oro, a pince-nez. Papà era miope
ma portava gli occhiali solo a teatro e per guardare i quadri.
Credevo di sapere tutto di lui. Papà era una parte nota di me: la
montagna, la caccia, Giulio Verne. Ora contava la parte ignota che
mi aspettava. Non ero propriamente ansiosa; infatti ero distratta,
sicura che le cose importanti si sarebbero imposte. Credo che
camminassi guardando lontano davanti a me, anch’io come papà.
Del resto non pensavo a lui quel giorno, anzitutto perché non
volevo star male. Consideravo la nostra separazione definitiva.
Come se uno di noi due – lui – morisse.
II.
Papà, che prendeva sul tragico le cose della scuola, aveva
trovato opportuno che anticipassi la partenza per passare un certo
periodo di tempo in casa dello zio Giuseppe, professore
universitario, e incominciare cosí ad ambientarmi.
Gli zii abitavano all’ultimo piano di un grande palazzo d’angolo
sulla piazza Castello, alla confluenza di una strada elegante con due
strade antiche e buie. La casa, per quanto moderna, aveva qualcosa
di inquietante. L’androne, che dava sui portici, era molto alto e
semibuio, chiuso in fondo da una vetrata opaca; le pareti erano
tappezzate dalle vetrine di un fotografo: mentre passavo, le facce dei
medaglioni da cimitero mi guardavano.
Lungo tutto lo scalone severo era diffusa una musica strana,
velata e come ronzante. Ora vicina, ora quasi remota. Era una
musica da ballo, fortemente ritmata; sprofondava in singulti,
prorompeva in boati o improvvisi clangori: però sempre attutiti,
distanti. Se ero sola, provavo una vaga paura.
Su una porta a vetri era scritto a grandi caratteri dorati TEA ROOM.
Lo zio – saliva e scendeva le scale rapidissimamente – si fermò di
botto davanti alla scritta: – Quella non è una «e» ma una «i». Quella
«a» non è «a», ma «e»… – E compitava: – Ti… e… – Il «rum»
diventava «lum» nella sua pronuncia blesa. Poi riprese a scendere
correndo, assorto nei suoi pensieri. Qualcosa del mago aveva
sempre avuto. Un mago delle Mille e una notte: arabo, dalla barba
rada e dagli occhi fulminanti.
La sera a tavola disse improvvisamente, rivolto alla zia: – Nina, la
nostra brava nipotina oggi ha imparato l’inglese. – Benissimo, –
approvò la zia, tra le prime avvisaglie del sonno, e mi sorrise con la
piccola bocca a punta. Masticava a bocca chiusa coi denti davanti,
piccoli e graziosi, che mostrava nel sorriso.
I pranzi erano buonissimi. Una delle meraviglie che la mamma
raccontava degli zii era appunto questa, che quando la zia Nina non
aveva voglia di cucinare, faceva «venir su» la cena «dal Milano». Il
«Milano», come appresi, era il caffè-concerto del primo piano, dal
quale provenivano le misteriose musiche.
Io dormivo in uno stanzino cieco, che riceveva una luce molto
fioca da un lucernario color nebbia in un angolo del soffitto. I rumori
della città, nuovi per me – clacson di automobili, scalpitare e rotolare
di carrozze, scampanellare di tram – vi giungevano soffocati e
tuttavia angosciosi.
C’era un divano – il mio letto – e tutt’intorno alle pareti, fin nel
mezzo della stanza, pile e pile di libri intonsi dalla copertina celeste.
Erano il Formulario e altri testi di Analisi Matematica. Avrei
desiderato di leggerli – non ponevo nessun limite alla mia curiosità,
nemmeno quelli della difficoltà o della noia – ma si trattava di
impossibilità, almeno per ora. Pensavo infatti che ci sarei riuscita col
tempo.
Di giorno mi aggiravo quieta per le stanze, contenta che mi
lasciassero star zitta. Il rispetto della libertà altrui era totale da parte
degli zii.
L’ingresso era ingombro di nuove edizioni, di estratti, di riviste; la
cucina era piccola, e sul tavolo c’era sempre una quantità di roba
ammucchiata come per un trasloco. La zia diceva, macinando il
caffè: – Domani viene Rina da Cavoretto a fare la pulizia.
La stanza da pranzo – nel senso che era quella dove si pranzava
– aveva nel mezzo un grosso tavolo scuro, di quelli da osteria.
Facendo ribaltare il piano, appariva un fondo assai capace, pieno di
giochi matematici; alcuni erano modellini ricavati dai trucchi dei
baracconi (il «mago», raccontò la zia Nina, aveva pregato lo zio di
non rivelarli al pubblico). Dal soffitto pendeva una lampadina col
piatto di ferro smaltato, uguale a quella della cucina. Due armadi a
vetri erano pieni di grossi libri rilegati, enciclopedie e dizionari; in un
angolo torreggiava un torchio da tipografo. Alle pareti erano appesi
grandi fogli stampati: il calendario dell’università, orari e regolamenti.
In questa stanza lo zio riceveva le visite: studenti, per lo piú
stranieri – perfino cinesi – ossequiosissimi, dal sorriso esitante,
l’inchino a scatto; e scienziati, in genere molto diversi da lui. Uno
aveva i capelli grigi ondulati come quelli delle signore e le mani
bianche, un sorriso insinuante e dolce. Guardavano lo zio con
venerazione. Mentre lui, cupo, la barba arruffata, andava avanti e
indietro nella stanza, scuotevano la testa. Quando si accorgeva di
me, lo zio si rallegrava e mi presentava ai colleghi.
La camera degli zii era grande, anzi grandissima. Alle pareti
erano appesi molti quadri, o meglio fotografie di quadri. Erano tutti di
soggetto pompeiano, in stile floreale: donne avvolte in pepli
giocavano con le colombe bianche tra i colonnati.
Sapevo che la zia e le sue sorelle avevano posato per quei quadri
del padre pittore. Lei aveva, anche adesso che era vecchia, un viso
molto dolce, un profilo delicato che pareva imitato da quei quadri.
Non era grassa, ma aveva il ventre gonfio per una malattia, e
camminava un po’ curva per questo. Quando rideva, il ventre
sussultava.
Sul comò trovai una scatola di cipria: era rosa pallido. Mi posai il
piumino sul naso, poi mi specchiai: era rimasta una macchia bianca.
Passavo molto tempo alla finestra; guardavo in basso il
marciapiede di fronte. Nella mia città nessuna casa era cosí alta.
C’era una calzoleria di lusso, con specchi tra le vetrine: molte
persone si fermavano per specchiarsi, gli uomini si aggiustavano la
cravatta.
I rumori della città che mi angosciavano la notte, giungevano netti,
quasi violenti. Erano «la città». E le grandi città per me erano
«America». Le pensavo come Philadelphia, Chicago: nomi familiari,
perché quand’ero bambina mio padre riceveva da un amico
americano una rivista illustrata.
Lo zio, per aiutarmi a vincere l’imbarazzo, mi mandava a
comprare i giornali all’edicola d’angolo. Erano parecchi. – Guardati
dall’uomo di un solo giornale! – soleva dire. Dovevo riferirgli quali si
vendevano di piú. Ciò era in relazione a sequestri e censura, cioè al
fascismo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :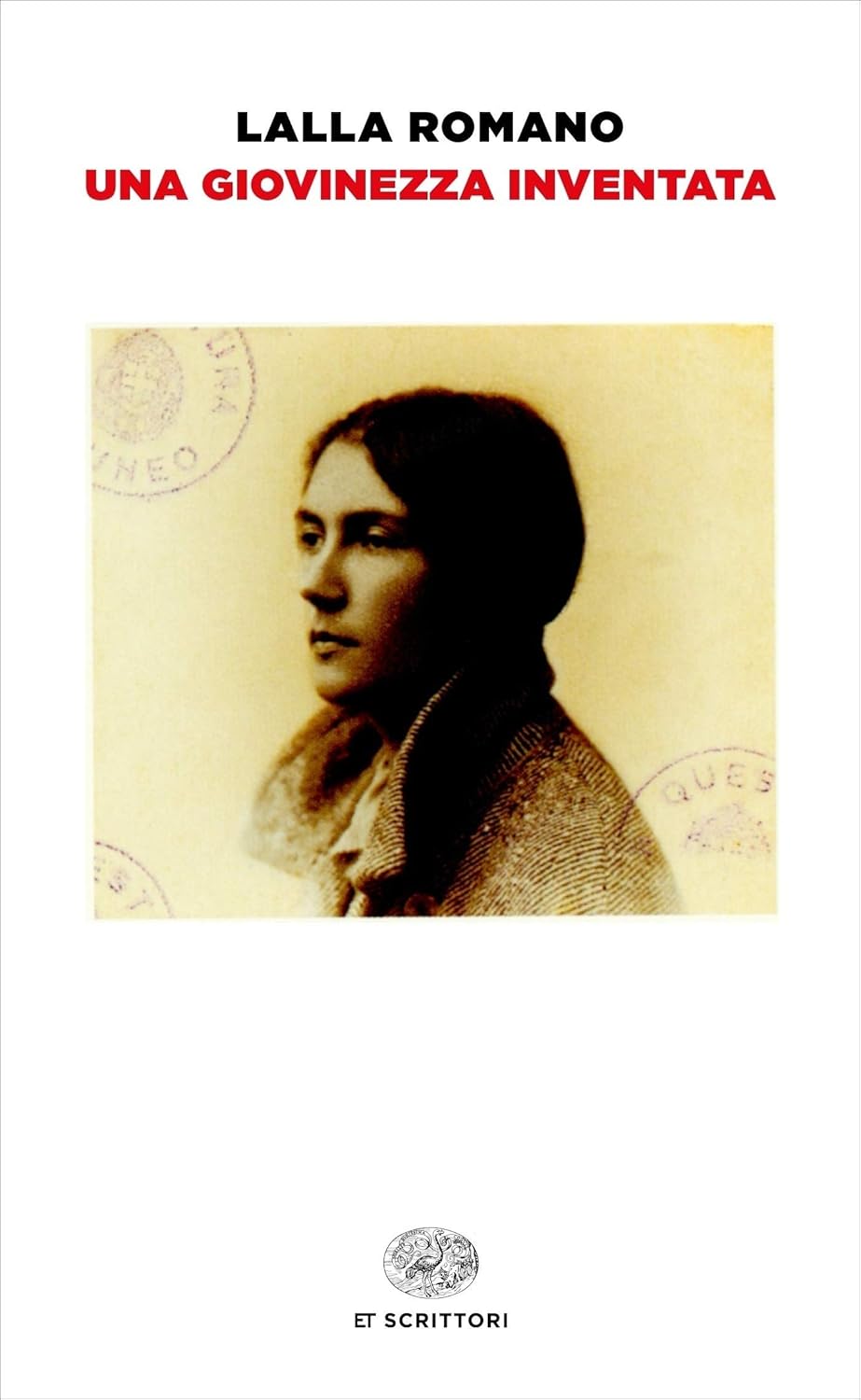






Commento all'articolo