Teorie del tutto – Frank Close
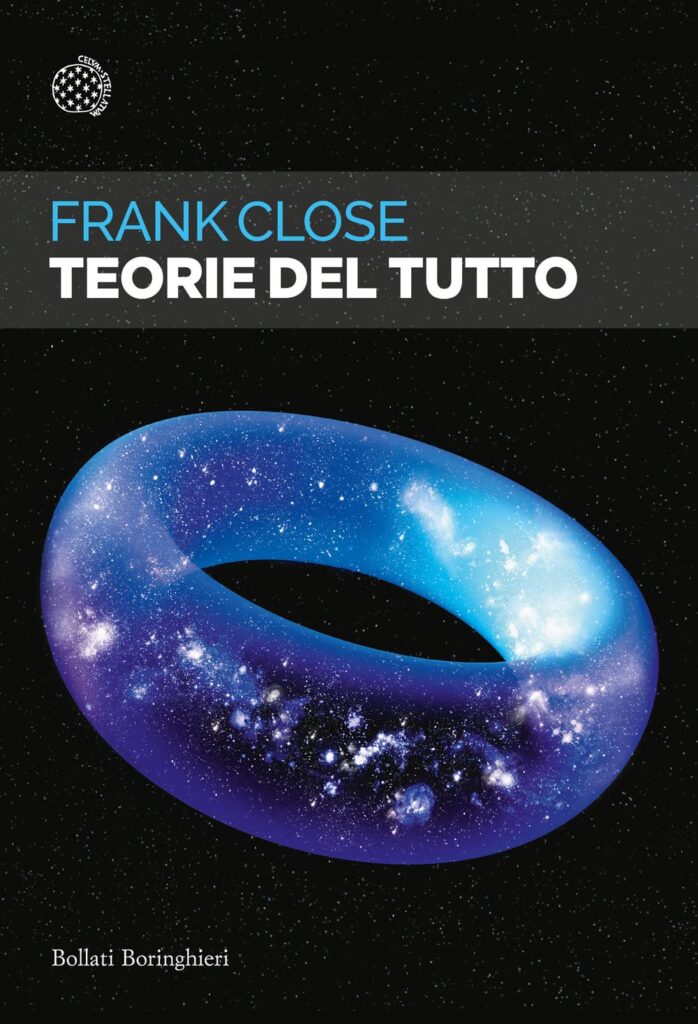
SINTESI DEL LIBRO:
Nel 1980 Stephen Hawking ipotizzò che la fine della fisica teorica
fosse vicina, e che in cambio sarebbe presto comparsa una teoria
del tutto. Stava forse inconsciamente riecheggiando lo scienziato
americano Albert Michelson, che nel 1894 affermò che «i grandi
principi di base sono stati saldamente stabiliti. Ulteriori verità della
fisica vanno ricercate nella sesta posizione decimale»,1 o Lord
Kelvin, che nel 1900 proclamò che «ormai non c’è più niente di
nuovo da scoprire nel campo della fisica. Non rimangono altro che
misurazioni sempre più precise»?2 Probabilmente no.
Solo la natura sa cosa si estende oltre l’orizzonte della nostra
visione attuale, e mette ripetutamente a nudo i limiti della nostra
immaginazione. Pochi anni dopo le dichiarazioni di Lord Kelvin, la
scoperta dell’atomo nucleare e l’avvento della meccanica quantistica
e della relatività fecero apparire ingenua l’esuberanza di quei giganti
della scienza del XIX secolo. Tuttavia la verità è più sfumata, e di
conseguenza le implicazioni sono parecchio diverse. Le parole di
Lord Kelvin (senza alcun dubbio) e quelle di Albert Michelson (fino a
un certo punto) sono state estrapolate dal loro contesto e spesso
citate a sproposito. Se interpretate con attenzione, invece,
racchiudono un messaggio profondo per chi è alla ricerca della
teoria del tutto.
Di fatto, le osservazioni di Michelson si ispiravano proprio alla
ferma e duratura convinzione di Lord Kelvin che lo scopo principale
della fisica fosse misurare grandezze note con un elevato grado di
precisione. Lord Kelvin era influenzato sia dalla teoria della
radiazione elettromagnetica di Maxwell sia dalla termodinamica, una
descrizione del calore basata sulla meccanica di cui lo stesso Kelvin
era uno dei maggiori artefici. Secondo lui sarebbe stato possibile
comprendere il concetto di energia in termini di moto delle particelle,
dal momento che i principi generali sottostanti sembravano a portata
di mano.
Il 27 aprile 1900, un venerdì, Kelvin tenne una conferenza a
proposito di questa idea alla Royal Institution di Londra, il luogo dove
Michael Faraday aveva compiuto le scoperte negli ambiti
dell’elettricità e del magnetismo su cui si reggeva la nuova fisica.
Anziché dichiarare in maniera acritica che la sintesi di luce, calore e
meccanica significava che la fine della fisica era imminente, Kelvin
esordì con queste parole: «La limpida bellezza della teoria dinamica,
secondo cui il calore e la luce sono modalità del moto, è al momento
oscurata da due nubi».3 Fu così che la conferenza passò alla storia
come il discorso delle «due nubi».
La leggenda narra che Lord Kelvin stesse annunciando con
arroganza la fine della fisica, ma in effetti stava richiamando
l’attenzione su due enigmi irrisolti. Se si sbagliava, era nella
speranza che le «due nubi» fossero piccole nuvolette in un cielo
altrimenti limpido e azzurro. In realtà erano un presagio di tempesta.
Per eliminarle sarebbe stato necessario costruire i due grandi pilastri
della fisica del XX secolo: la teoria della relatività di Einstein, da un
lato, e la teoria quantistica, dall’altro.
Insomma, Lord Kelvin si sbagliava nei dettagli, senza dubbio, ma
era comunque ben consapevole dei limiti della fisica di fine XIX
secolo. Di fatto, quando tenne la conferenza, gli indizi delle
incombenti rivoluzioni nella fisica del XX secolo erano già, con il
senno di poi, perfettamente evidenti. Sarà il caso di tenerlo a mente
quando esamineremo le proclamazioni moderne secondo cui la fine
della fisica è di nuovo vicina.
2. Cos’è una teoria del tutto, e cos’è «il tutto»?
Le teorie del tutto si definiscono in generale come teorie che si
basano sugli studi in ogni campo rilevante del sapere attuale – fisica,
astronomia, matematica eccetera – per cercare di spiegare tutto ciò
che sappiamo a oggi dell’universo. Da ciò si evince facilmente che
una teoria del tutto è una realtà mutevole. Una spiegazione
dell’universo conosciuto può regnare sovrana per decenni,
addirittura per secoli. In quell’arco di tempo può fungere da base per
numerosi progressi scientifici e tecnologici. Poi, magari come
risultato diretto o indiretto di quei progressi, viene compiuta una
nuova scoperta che accresce il «tutto» già noto e che la teoria
accettata non può spiegare senza entrare in contraddizione con se
stessa. A quel punto serve una nuova teoria del nuovo «tutto». E il
ciclo continua.
Le due nubi di Lord Kelvin preannunciarono cambiamenti
paradigmatici nel nostro modo di comprendere sia lo spazio e il
tempo sia la struttura microscopica della materia. Dato che la fisica
nucleare e la fisica quantistica sono caratterizzate da una ricchezza
e una vastità straordinarie, e dato che la teoria della relatività di
Albert Einstein assorbì il grande lavoro di Isaac Newton sulla
meccanica e la gravitazione, come è possibile che la scienza del XIX
secolo sia stata così cieca? Se questi pilastri fondamentali del
sapere rimasero nascosti tanto a lungo mentre Isaac Newton, James
Clerk Maxwell e Lord Kelvin elaboravano teorie del tutto relative alle
conoscenze dell’epoca, la spiegazione ha a che fare con proprietà
profonde del nostro universo, e probabilmente con la nostra capacità
di decifrarne con successo le leggi.
Una teoria del tutto (o TOE, dall’inglese theory of everything)
dovebbe descrivere la natura a qualsiasi livello di distanza, tempo ed
energia. La nostra esperienza è limitata a una piccola porzione di
queste ampie distese, anche se nel corso dei secoli si è ingrandita.
Nella pratica, la natura non offre una copertura omogenea dello
spettro, pertanto possiamo formulare teorie di sottoinsiemi di
fenomeni nel momento in cui l’ignoranza in un ambito non impedisce
i progressi in un altro.
Se siamo riusciti ad avanzare nel nostro modo di comprendere le
cose senza possedere una vera teoria del tutto, è perché i fenomeni
naturali possono essere raggruppati in regimi discreti: essi formano
ciò che definisco una «cipolla cosmica» costituita da strati collegati
tra loro i cui contenuti sono però, con un’ottima approssimazione,
indipendenti l’uno dall’altro. Una «teoria del tutto per un singolo
strato» funziona perché la natura mette efficacemente in quarantena
le manifestazioni degli altri strati. Isolate in maniera opportuna,
queste non hanno alcun peso effettivo nella descrizione dei
fenomeni al livello di nostro interesse.
In questo libro intendo illustrare la compartimentazione
dell’universo materiale in scale dimensionali discrete, e quantificare
le diverse scale di energia, temperatura o risoluzione spaziale che
dobbiamo studiare per svelarne le dinamiche. Prima del XX secolo,
per esempio, la fisica si limitava ai fenomeni che non superavano la
temperatura degli altiforni: i milioni di gradi a cui subentra la fisica
nucleare erano fuori portata, per non parlare dei milioni di miliardi a
cui diventa visibile il bosone di Higgs.
Possiamo dunque formulare una teoria del tutto dove tutto
significa «all’interno di un livello di energia specifico e limitato». È
così che la scienza si è evoluta nel corso della storia. Ci sono voluti
secoli per raggiungere le condizioni rivelate dal Large Hadron
Collider del Cern, ma nel frattempo gli scienziati hanno sviluppato
una serie di teorie applicabili ai vari livelli dell’energia.
Alla scala umana, per esempio, una teoria del genere esiste già.
Le relazioni matematiche che spiegano tutto ciò che è più grande di
un nucleo atomico nascono dal lavoro del fisico austriaco Erwin
Schrödinger, del fisico tedesco Werner Heisenberg e del matematico
di Cambridge Paul Dirac, e le conosciamo da novant’anni. Le loro
equazioni descrivono il comportamento di elettroni e atomi e
vengono insegnate agli studenti. Eppure sono di una semplicità
fuorviante, dato che, salvo pochi casi, sono difficili da manipolare e
impossibili da risolvere. È stato solo negli ultimi anni, con la
comparsa di computer potenti, che la gamma dei problemi risolvibili
si è ampliata. Da tali equazioni nessuno ha dedotto le proprietà degli
amminoacidi semplici, né tantomeno il funzionamento del DNA, ma
questo non ha certo ostacolato l’incredibile sviluppo della biologia
moderna. Allo stesso modo, partendo dalla «teoria del tutto per ciò
che è grande e si muove» di Isaac Newton, possiamo prevedere con
certezza le eclissi solari e lunari, ma non il tempo atmosferico.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :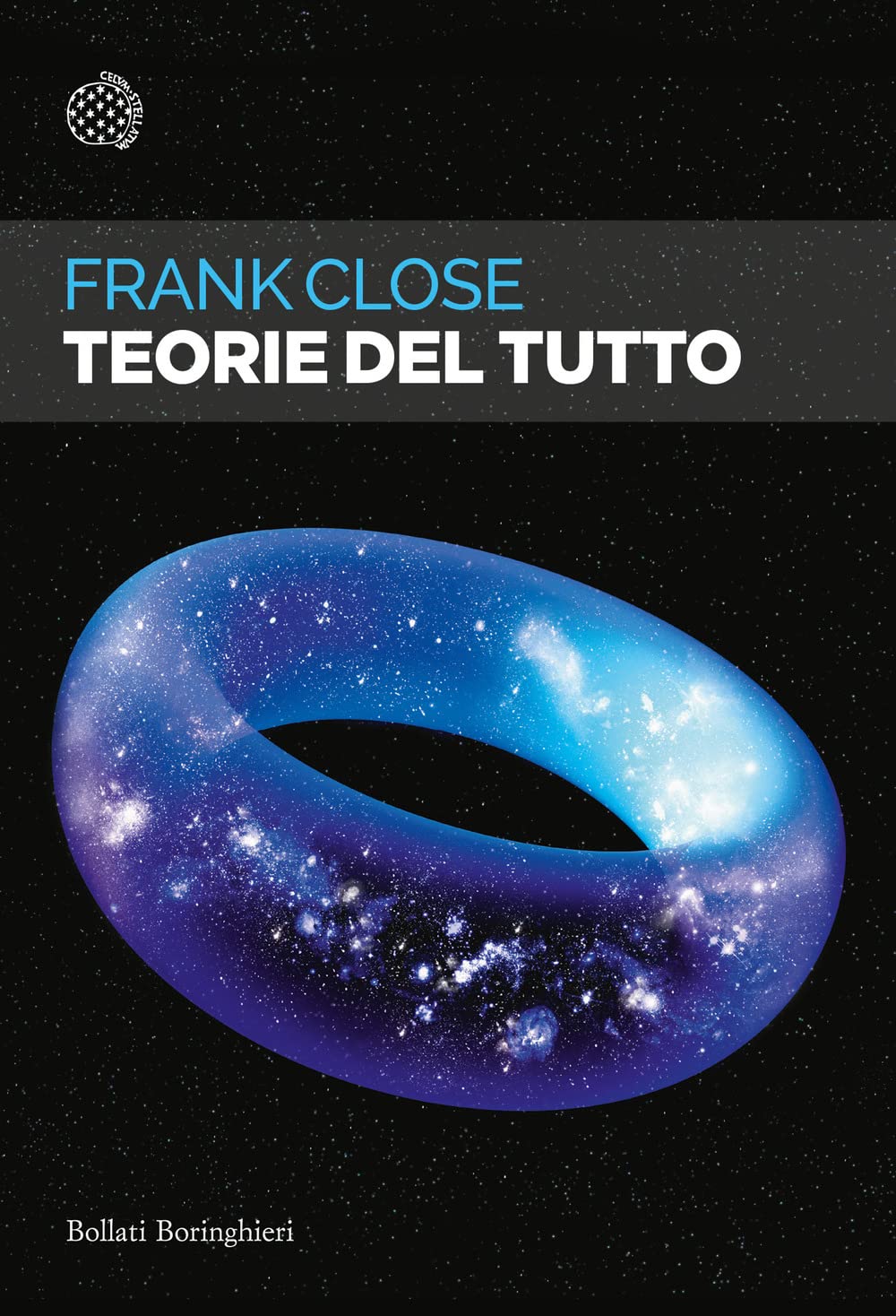





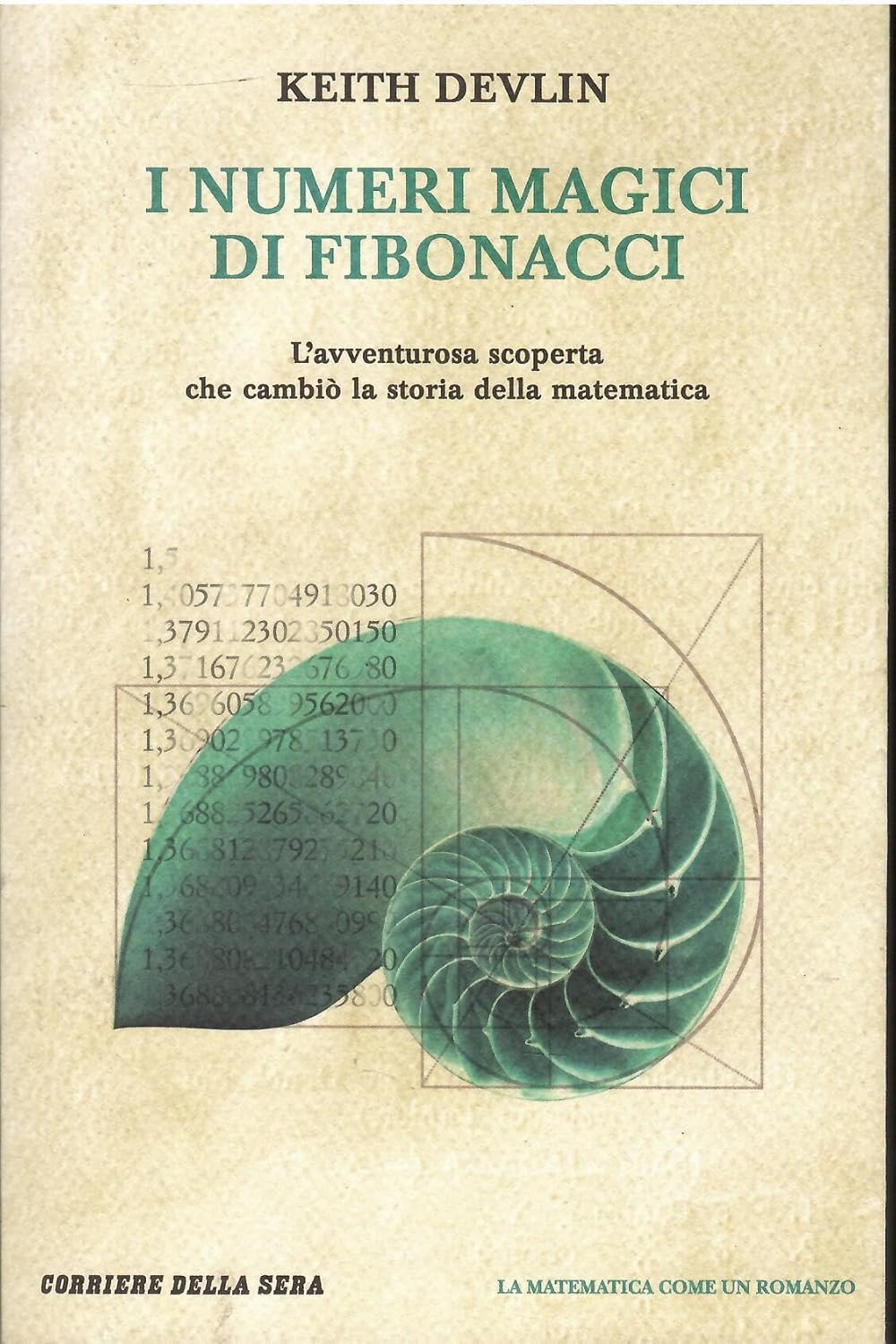
Commento all'articolo