Torino magica – Vittorio Del Tufo
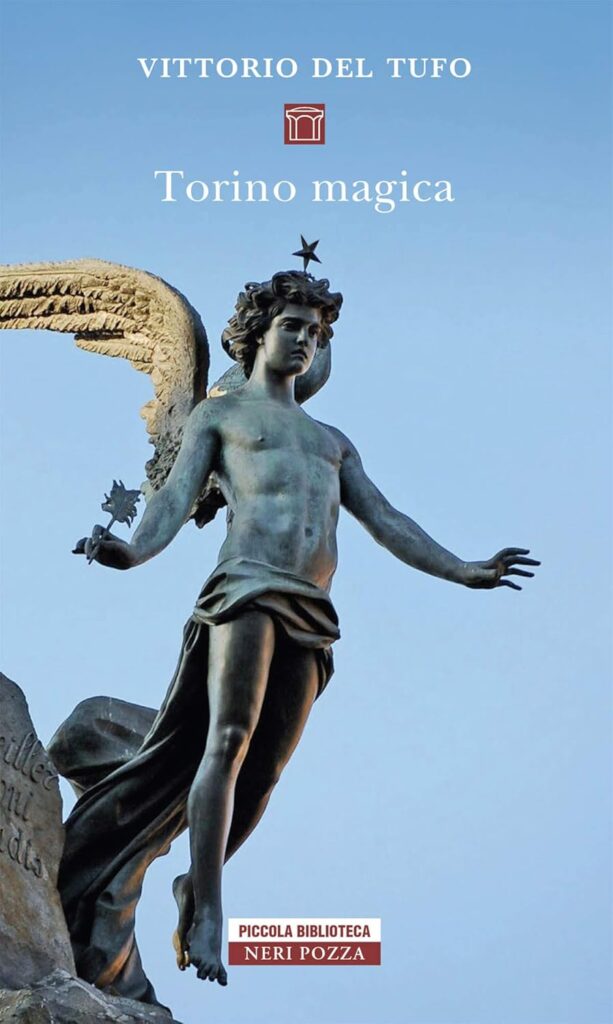
SINTESI DEL LIBRO:
Torino, esterno giorno. Un uomo al volante della sua auto
percorre le strade della collina. Durante il tragitto si ferma, qua e là,
a sbirciare nei giardini. Cerca la Dracaena indivisa, una rara pianta
esotica che potrebbe aiutarlo a venire a capo del giallo che si è
impegnato a risolvere. Risalendo la collina che dalla Gran Madre
conduce al Monte dei Cappuccini e poi più su, fino al parco di Villa
Genero, l’uomo, che si chiama Marc, incrocia antiche residenze
ducali e reali immerse in parchi storici di ippocastani e tigli. Villa
Regina, Villa Cossavella, Villa d’Agliè, Villa Magri. Infine, vede la
pianta esotica troneggiare dall’alto di un giardino. Accosta, scende
dall’auto. Affacciandosi alle inferriate del maestoso cancello, capisce
che in quella spettrale dimora è nascosto, forse, quello che sta
cercando. In un attimo è dentro. Scrostando l’intonaco di una parete,
Marc rinviene un rozzo affresco, disegnato con tratto infantile.
Mostra un bimbo con in mano un coltello insanguinato e di fianco un
uomo con un’enorme ferita sul petto.
Siamo tra le quinte di uno dei luoghi entrati con maggior forza
nell’immaginario collettivo degli amanti del thriller: Villa Scott,
l’edificio progettato nel 1902 dall’ingegnere torinese Pietro Fenoglio
e usato per alcune riprese di Profondo rosso, diretto nel 1975 da
Dario Argento e interpretato da un cast di attori straordinari, tra i
quali David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia e Glauco
Mauri. Villa Scott è la «villa del bambino urlante», in assoluto il set
più celebre dell’intera storia del cinema di Argento.
Ben quarantacinque anni sono trascorsi dall’uscita di Profondo
rosso, eppure questa villa simbolo del liberty torinese, al civico 57 di
corso Giovanni Lanza, è ancora meta di pellegrinaggio e di
attenzioni quasi morbose. Fu costruita per volontà di Alfonso Scott,
che a quell’epoca era amministratore delegato della Rapid, casa
automobilistica torinese oggi scomparsa. Poi passò all’ordine delle
Pie Suore della Redenzione, che la adibirono a collegio femminile,
con il nome di Villa Fatima. Nei primi anni del Duemila è stata
acquistata da privati, che l’hanno restaurata e riportata allo
splendore originario. I curiosi non possono visitarla; continuano,
però, ad accostarsi alla cancellata e sbirciarne l’interno.
Diceva Gabriel García Márquez che ogni uomo ha una vita
pubblica, una vita privata e una vita segreta. Anche le città, come gli
uomini, hanno una vita segreta, che è fatta di tracce, di voci, di
storie, di memorie, di suggestioni, di pietre e di ombre. Nata
all’incrocio di due fiumi e molte leggende, rebus di luce e tenebre,
Torino è una città che nasconde più di quanto non mostri, che
occulta più di quanto non sveli.
Misteriosa. Simmetrica. Inafferrabile. Ma anche austera, lineare,
superba. Costruita in una pianura adorna di colline e abbracciata da
un orizzonte di Alpi. Molti registi hanno cercato di esplorare il mistero
di Torino, i suoi luoghi oscuri. Con i suoi film Dario Argento è riuscito,
forse meglio di altri, a penetrare nell’anima della città, a trasfigurare,
con i suoi occhi visionari, le austere, eleganti e (in molti casi)
inquietanti architetture sabaude. «Ricordo che per Profondo rosso io
e il mio architetto girammo in auto per la collina di Torino e a un certo
punto passammo davanti a questa villa, che mi piacque subito. Era
abitata da monache che vi tenevano delle ragazze disadattate,
ragazze anche abbastanza grandi. La produzione pagò a tutte
(monache comprese) un mese di vacanza a Rimini e quelle,
contente, partirono»1
. Villa Scott conservava al suo interno, ai tempi
di Profondo rosso, anche simboli e oggetti religiosi che il regista
decise di lasciare al loro posto. Come il ritratto di un ecclesiastico
che Argento inquadra quasi in primo piano: si tratta di Léon Gustave
Dehon (1843-1925), prete francese fondatore della congregazione
dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù.
Tra le sequenze più note di Profondo rosso v’è quella
ambientata al Teatro Carignano. La scena è dominata dalla figura di
una sensitiva – Helga Ulmann, interpretata da Macha Méril – che
“avverte” in sala una presenza malefica: «I suoi pensieri sono
pensieri di morte... Tu! Hai già ucciso, e sento che ucciderai di
nuovo. Quel canto infantile... e quella villa laggiù...». Il contrasto tra
la dimensione onirica del film e gli ambienti urbani freddi e razionali
della città è più che mai evidente nelle scene ambientate in piazza
CLN, dove «il minimalismo stilistico del razionalismo amplifica in
qualche modo il senso di angoscia e desolazione»2
. Con le sue
forme geometriche, piazza CLN sembra appartenere a una città
aliena. Dario Argento decide di aggiungervi un bar e nel farlo si
ispira al celebre quadro di Edward Hopper Nighthawks (I nottambuli).
Così fa ricostruire un bar identico a quello che si vede nel quadro: un
luogo (o non luogo) quasi sospeso in un sogno, addossato alle
colonne della piazza, dove gli avventori sono persone in carne e
ossa che però restano immobili per l’intera durata della scena,
«esattamente come in un quadro». Il regista illumina la piazza quasi
a giorno, e per riprenderla usa la Chapman, un dolly capace di
raggiungere i dodici metri di altezza: questo espediente la farà
apparire ancora più ampia e profonda di quanto sia nella realtà.
Piazza CLN – originariamente piazza delle Due Chiese e poi
piazza delle Due Fontane – deve il suo aspetto alla ristrutturazione
avvenuta in pieno regime fascista, quando lo scultore Umberto
Baglioni, nel 1937, realizzò le due fontane poste sul retro delle
chiese “gemelle” di piazza San Carlo (Santa Cristina e San Carlo). In
Profondo rosso sono proprio le fontane, con le allegorie
antropomorfe dei fiumi Po e Dora Riparia, a catturare l’attenzione del
pubblico. La più inquadrata è la scultura raffigurante il Po: il
protagonista Marc (Hammings) e il suo amico pianista Carlo,
interpretato da un giovane e magistrale Gabriele Lavia, vi stazionano
a lungo discorrendo di arte prima di essere interrotti da un urlo
proveniente da uno degli appartamenti affacciati sul colonnato. È il
grido della sventurata Helga, colpita da una mannaia da macellaio!
Negli anni dell’occupazione nazista il luogo era tristemente noto
per la presenza, nell’Albergo nazionale, del comando della Gestapo,
presieduto dal maggiore delle SS, Hugo Kraas. Il nome della
piazzetta fu poi dedicato al Comitato di Liberazione Nazionale,
costituitosi in Italia al termine del fascismo. Le due fontane furono
svuotate nel 1987, il Comune le riattivò solo vent’anni dopo.
Per il ruolo dell’assassino, in Profondo rosso, Argento sceglie
un’attrice di lungo corso, dimenticata dal pubblico, avvertendo forse
l’esigenza di salvarla dall’oblio: è Clara Calamai, grande diva negli
anni Quaranta3
. Con un autentico colpo di genio, il regista decide di
mostrare a tutti il volto dell’assassino, senza che nessuno se ne
renda conto. Subito dopo l’omicidio della sensitiva Helga, il
protagonista, nel vano tentativo di soccorrerla, percorre un lungo
corridoio abbellito da quadri antichi e cornici di ogni genere. E il
killer, provando a mimetizzarsi contro un quadro che rappresenta un
insieme scomposto di volti, per un istante si mette in bella vista
piazzandosi a favore di uno specchio4
.
Perché Torino esercita su Argento, e non solo su di lui, una
fascinazione così sinistra? Nel libro Paura, pubblicato da Einaudi nel
2014, è lo stesso regista a svelare l’origine della sua infatuazione.
«Tutti si aspettavano che facessi riferimento all’esoterismo, o alle
“dimore filosofali” care all’alchimista Fulcanelli. Il fatto che Torino sia
una città che fa parte tanto del triangolo della magia nera (insieme a
Londra e San Francisco) quanto di quello della magia bianca
(insieme a Lione e Praga) è un elemento che di per sé suggeriva già
una risposta»5
. In realtà ad affascinare il regista, con l’atmosfera
«sinistra e un po’ morbosa» di certe vie lunghe e diritte, è soprattutto
il liberty torinese della Belle Époque, con le sue architetture singolari
e bizzarre, ricche di dettagli curatissimi: agli occhi dell’inquieto
maestro, set già disegnati e pronti per ambientarvi i suoi gialli; dal
Gatto a nove code a Quattro mosche di velluto grigio, entrambi girati
nel 1971, fino a Profondo rosso (1975), trionfo dell’estetica horror,
dove i luoghi stessi della città sono al servizio dell’immaginario
onirico e allucinato del regista.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :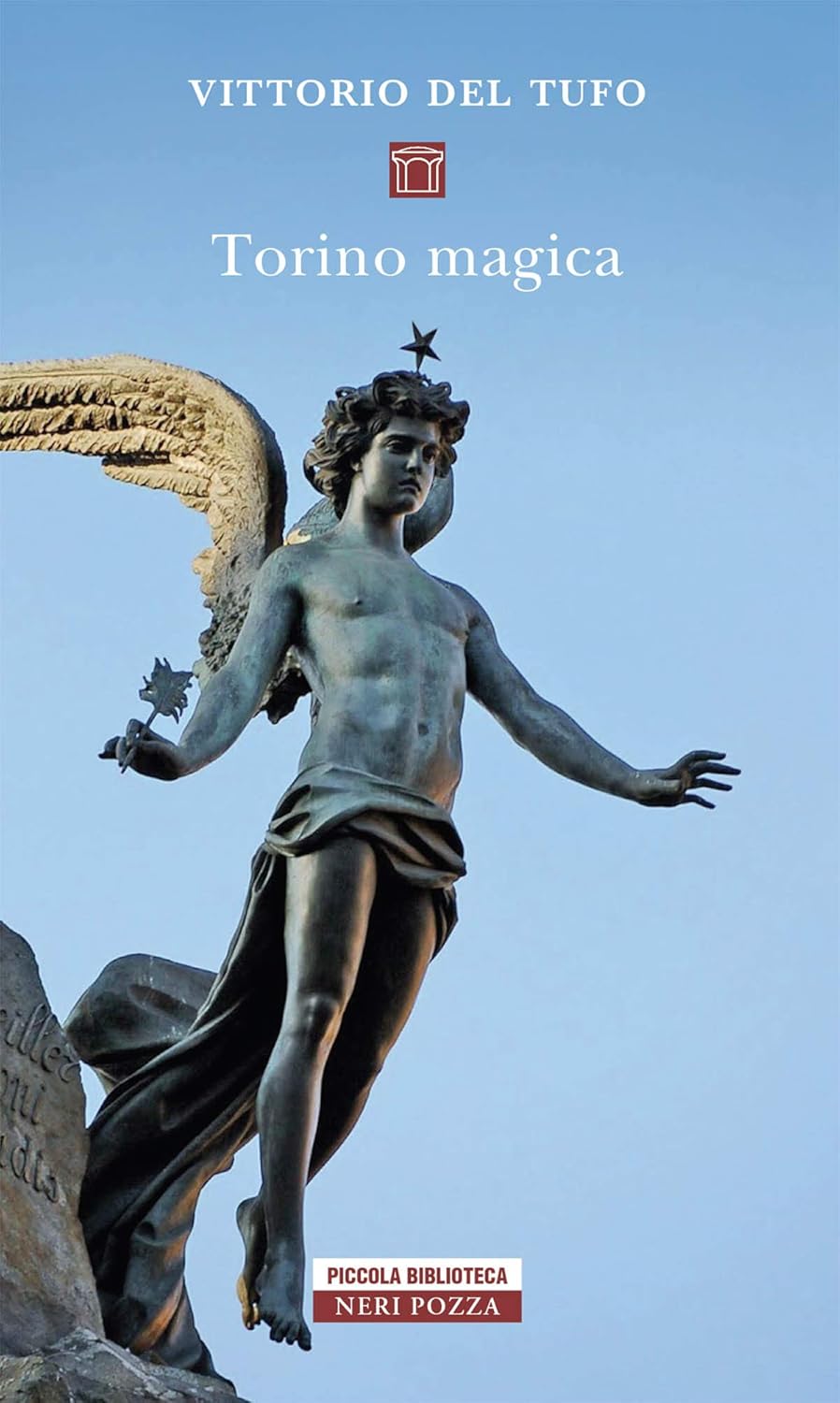






Commento all'articolo