Stranieri residenti – Una filosofia della migrazione – Donatella Di Cesare
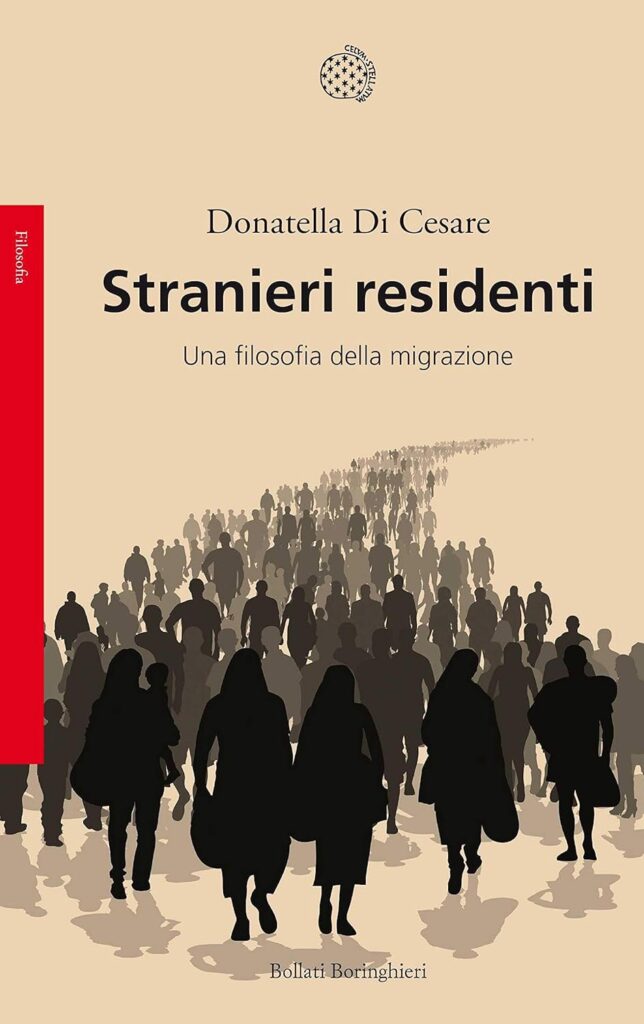
SINTESI DEL LIBRO:
Viaggiavano per settimane tra le onde dell’oceano, nel fondo della
stiva, quasi sotto la linea di galleggiamento, ammassati in bui
dormitori, dove l’aria era sempre più consunta, stipati su vecchi
pagliericci, uomini, donne, bambini, anche duemila passeggeri. Solo
quelli della terza classe sbarcavano a Ellis Island. Per chi aveva
denaro abbastanza da permettersi la prima o la seconda classe,
pochi e rapidi controlli erano compiuti a bordo da un medico e da un
ufficiale di stato civile.
Fieri piroscafi e possenti transatlantici salpavano da Amburgo e
Liverpool, da Napoli e Marsiglia, da Riga e Anversa, da Salonicco e
Copenhagen, diretti verso quell’unica meta: la Golden Door, la Porta
d’Oro dell’America favolosa. Dopo una traversata estenuante,
quando infine la nave entrava nelle acque del fiume Hudson, e in
lontananza si scorgeva la costa del New Jersey, i passeggeri
risalivano sul ponte per vedere la Statua della Libertà. Era il
benvenuto che avevano sognato. L’emozione aveva la meglio su
fatica, inquietudini e affanni. Con toni quasi epici Kafka descrive
l’arrivo di Karl Roßmann, protagonista del suo romanzo America.
Quando il sedicenne Karl Roßmann – che i poveri genitori avevano mandato
in America perché una domestica l’aveva sedotto e aveva avuto un figlio da lui
– entrò nel porto di New York a bordo della nave che aveva già rallentato, vide
la statua della dea della libertà, che da tempo stava osservando, come
circonfusa da una luce solare fattasi improvvisamente più intensa. Il braccio
con la spada svettava come se fosse stato appena sollevato e i venti
soffiavano liberi attorno alla figura.2
La Statua della Libertà ha una storia singolare. Portata nel Nuovo
Continente, dono francese, pegno di valori europei, nel tempo
diventò simbolo d’accoglienza per i dannati del Vecchio Continente,
sfruttati e asserviti, decimati da carestie, guerre, miseria, vittime
dell’odio. «Madre degli esuli» la chiamò la poetessa ebrea Emma
Lazarus nel sonetto, scritto nel 1883, inciso sul piedistallo della
statua.
«Tieniti pure, vecchio mondo, la tua vana pompa», grida con labbra mute.
«Dammi le tue masse stanche, povere e oppresse, desiderose di respirare
libere, dammi il rifiuto miserabile dei tuoi lidi affollati. Manda a me questi
senza-dimora, che la tempesta ha vinto, e io solleverò la mia fiaccola accanto
alla porta dorata».
L’ingresso sul suolo degli Stati Uniti, dove quei reietti avrebbero
potuto riscattarsi, diventando pionieri di una terra vergine, edificatori
di una società giusta, cittadini del Nuovo Mondo, fu aperto quasi fino
al 1875. In quei primi tempi era stato adibito a stazione di
smistamento Castle Garden, il vecchio forte a Battery Park, nella
parte meridionale di Manhattan. In seguito cominciarono a essere
applicate misure restrittive finché, il 1° gennaio 1892, venne
inaugurato il centro di Ellis Island. L’immigrazione, prima senza
vincoli, diventò istituzionalizzata. Tuttavia il grande flusso non fu
ostacolato e, tra il 1892 e il 1924, oltre 16 milioni di persone
passarono per Ellis Island. Da cinque a diecimila al giorno. Pochi
vennero respinti, il due per cento circa – quasi nulla a confronto con i
numeri odierni. Ma pur sempre duecentocinquantamila persone. I
suicidi furono più di tremila.
Ellis Island affiorava, tra le brume, dietro la Statua della Libertà.
New York, la terra promessa, era proprio lì, a poche braccia di mare.
Ma i passeggeri della terza classe sapevano che il loro viaggio non
era finito. Dal Nuovo Mondo li separava ancora quella piccola isola,
quasi un relitto del Vecchio, un luogo di transito, dove tutto era
ancora in gioco, dove chi era partito non era ancora arrivato, dove
chi aveva lasciato tutto non aveva ancora avuto nulla.
Gli indiani mohegan l’avevano chiamata Isola del Gabbiano, gli
olandesi l’avevano ribattezzata Isola delle Conchiglie, fin quando il
mercante Samuel Ellis, acquistandola, non impose il suo nome,
segno di possesso di quello stretto banco di sabbia nello Hudson. Il
nome restò, mentre la proprietà passò alla città di New York che, a
più riprese, ingrandì l’isola grazie a una discarica creata con la
zavorra delle navi e il terreno estratto dai tunnel della metropolitana.3
Per i migranti fu semplicemente l’Isola delle Lacrime – in tutte le
lingue dei popoli che la attraversarono: island of tears, île des
larmes, isla de las lágrimas, ostrov slez ecc. Chi aveva fortuna
rimaneva solo poche ore nel Federal Bureau of Immigration. Il tempo
di essere sottoposti a un controllo medico. Con una lettera alfabetica
venivano segnalati i sintomi di possibili malattie o le parti del corpo
da controllare: C per la tubercolosi, E per gli occhi, F per il viso, H
per il cuore, K per l’ernia, L per la claudicazione, SC per il cuoio
capelluto, TC per il tracoma, X per l’«infermità mentale».
Rapidamente, con il gesso, gli ufficiali sanitari tracciavano una
lettera sulle spalle di quei passeggeri che, assegnati a esami medici
più approfonditi, venivano trattenuti sull’isola per giorni, settimane,
mesi. Dove si accertavano invece o un male contagioso, tubercolosi,
tracoma, tigna, oppure l’«infermità mentale», si procedeva al
rimpatrio immediato.
Nelle testimonianze rimaste i passeggeri raccontano le lunghe
angosciose attese, il frastuono babelico, la spasmodica incertezza,
la vergogna provata per il marchio sulle spalle. Chi aveva superato il
controllo medico si metteva in fila per il legal desk, davanti a cui
doveva rispondere, con l’aiuto di un interprete, alle ventinove
domande rivolte a bruciapelo dall’ispettore di turno. «Qual è il suo
nome? Da dove arriva? Perché è venuto negli Stati Uniti? Ha denaro
con sé? E dove? Me lo mostri. Chi ha pagato la sua traversata? Ha
parenti qui? Famiglia? Amici? Chi può garantire per lei? Ha un
contratto di lavoro? Qual è il suo mestiere? È per caso un
anarchico?» Se l’ispettore si riteneva soddisfatto, timbrava allora il
visto e augurava al nuovo immigrato: Welcome to America!. In caso
contrario, laddove avesse avuto dubbi, scriveva su un foglio due
lettere, SI, che significavano Special Inquiry, indagine speciale. Il
passeggero era rinviato a una commissione costituita da tre ispettori,
uno stenografo e un interprete. L’interrogatorio ricominciava, più
duro e circostanziato.
Quelli che avevano superato tutte le ispezioni e tutte le domande
correvano verso la navetta che li avrebbe portati a New York. Così,
nel giro di poche ore, un paio di controlli e qualche vaccinazione, un
ebreo lituano, un siciliano, un irlandese diventavano americani. Per
loro si apriva la Porta d’Oro, l’Eldorado della modernità. Ciascuno
avrebbe potuto ricominciare da capo, lasciando dietro di sé il
passato, la propria storia e quella dei suoi antenati, il paese a cui
doveva la nascita, ma che gli aveva negato la vita. Presto, però,
molti avrebbero dovuto ricredersi. L’America non era la terra libera
che avevano sognato, né le strade erano lastricate d’oro. Quelli che
erano arrivati per primi si erano già appropriati di ogni cosa e ben
poco restava da spartire, se non i posti nelle fabbriche di Brooklyn e
del Lower East Side, dove si lavorava quindici ore al giorno. Quanto
alle strade, poi, erano ancora in gran parte da costruire, insieme con
le ferrovie e i grattacieli.
Quelli che erano entrati negli Stati Uniti all’alba del Novecento
dovevano tuttavia considerarsi privilegiati. Furono gli anni in cui si
raggiunse il picco quantitativo. Solo nel 1907 passarono per Ellis
Island 1004756 migranti. Già la prima guerra mondiale contribuì a
ridurre il grande flusso. Ma a frenare l’immigrazione furono
soprattutto le misure restrittive prese dal governo federale. Cinesi e
asiatici erano già stati banditi dal 1870. Il bando venne però
ufficializzato solo nel 1917 con l’Immigration Act – o anche Asiatic
Barred Zone Act – che estendeva l’etichetta di «indesiderabili» ad
anarchici, omosessuali, matti, alienati ecc. Si chiamava anche
Literacy Act perché prevedeva che gli immigrati, oltre a provare di
saper leggere e scrivere nella propria lingua, fossero sottoposti a
test di intelligenza. Qualche anno più tardi il numero degli ingressi
venne ulteriormente ridotto, prima con l’Emergency Quota Act del
1921, poi con il National Origin Act del 1924, che impose un limite
annuo di 150 000 persone. Quest’ultimo, in particolare, era un
provvedimento manifestamente razzista, perché mirava a ostacolare
l’immigrazione dai paesi dell’Europa meridionale e orientale. La
quota italiana, prima addirittura un quarto del totale, fu ristretta al
quattro per cento. Non stupisce che, negli anni trenta, queste leggi
ispirassero la politica nazista.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :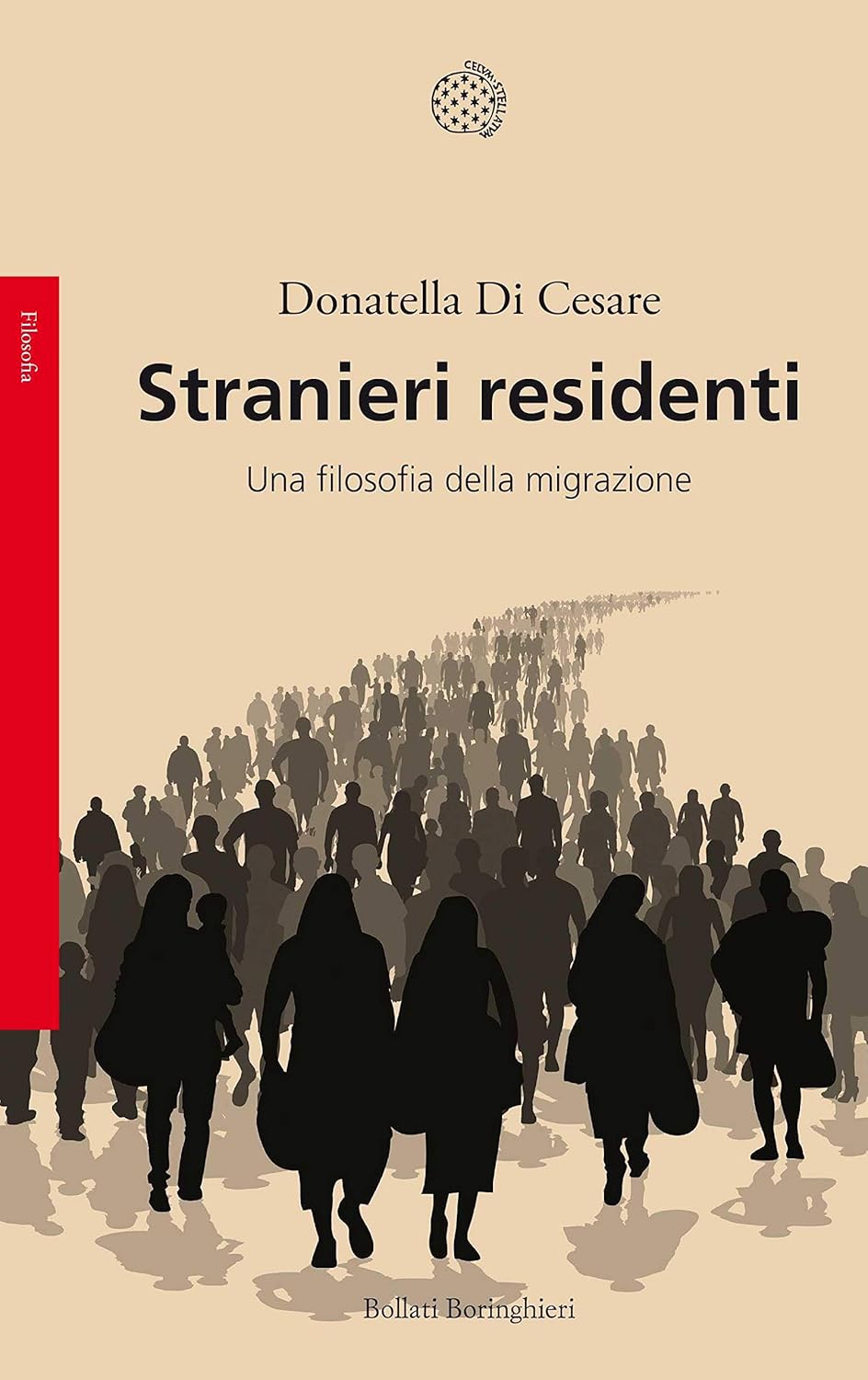






Commento all'articolo