La paura in Occidente. Storia della paura nell’età moderna – Jean Delumeau

SINTESI DEL LIBRO:
Onnipresenza della paura
1. «Mer variable où toute crainte abonde» (Marot, Complainte I
er
)
Nell’Europa degli inizi dei tempi moderni, la paura, mascherata o manifesta, è
presente dappertutto. Ciò si verifica in ogni cultura tecnicamente mal attrezzata a
rispondere alle molteplici aggressioni di un ambiente minaccioso. Ma,
nell’universo di un tempo, esiste uno spazio dove lo storico è sicuro
d’incontrarla senza nessun travisamento. Questo spazio è il mare. Per alcuni
arditissimi – gli scopritori del Rinascimento e i loro epigoni – il mare ha avuto il
significato di una provocazione. Ma per la maggioranza esso ha continuato per
molto tempo a voler dire dissuasione ed è stato per eccellenza il luogo della
paura. Dall’antichità al XX secolo, dalla Bretagna alla Russia, vi è un’enorme
quantità di proverbi che consigliano di non arrischiarsi per mare. I latini
dicevano: «Loda il mare e tienti a terra». Un detto russo consiglia: «Ammira il
mare seduto sulla stufa». Erasmo fa dire a un personaggio del dialogo
Naufragium: «Che pazzia affidarsi al mare!». Perfino nella marittima Olanda
circolava la sentenza: «Meglio stare sulla landa con una vecchia carretta che sul
mare in una nave nuova».
1 Era un riflesso di difesa da parte di una civiltà
essenzialmente terrestre, che confermava l’esperienza di quelli che, malgrado
tutto, si arrischiavano lontano dalle rive. La formula di Sancho Panza: «Se vuoi
imparare a pregare, vai per mare» si ritrova, con molteplici varianti, da un capo
all’altro d’Europa, talvolta con sfumature d’humour, come in Danimarca, dove si
precisava: «Chi non sa pregare deve andar per mare e chi non sa dormire deve
andare in chiesa».
2
Sono innumerevoli i mali arrecati dalla immensa liquida distesa: la Peste nera,
s’intende, ma pure le invasioni normanne e saracene e più tardi le scorribande
barbaresche. Leggende come quella della città d’Ys o quella dell’organo
sommerso di Wenduine che talvolta si sente suonare il Dies irae hanno a lungo
evocato le sue furiose avanzate.
3 Elemento ostile, il mare si contorna di scogliere
selvagge o di paludi insalubri e riversa sulle coste un vento che impedisce le
coltivazioni.
Ma il mare è pericoloso anche quando giace immobile, non increspato dal
minimo soffio. Un mare calmo, «inerte come una palude», può significare la
morte per i marinai bloccati al largo, vittime di «un’aspra fame» e di «una sete
ardente». L’oceano ha per molto tempo sminuito l’uomo, che si sentiva piccolo e
fragile davanti ad esso e sopra di esso: ragion per cui la gente di mare veniva
paragonata ai montanari e agli uomini del deserto. Dal momento che, fino a un
periodo recente, i flutti incutevano paura a tutti e particolarmente alla gente dei
campi, costoro si sforzavano di non guardare il mare quando il caso ve li
conduceva vicino. Dopo la guerra greco-turca del 1920-1922, dei contadini
cacciati dall’Asia Minore furono sistemati nella penisola del Sunio. Essi
costruirono le proprie case con un muro cieco dalla parte del mare. A causa del
vento? Può essere. Ma più ancora, senza dubbio, per non vedere tutto il santo
giorno la minaccia costante delle onde.
Nel periodo di trapasso dal Medioevo all’età moderna, l’uomo occidentale
conserva la prevenzione contro il mare non solo in forza della sapienza dei
proverbi, ma altresì di due richiami paralleli: il primo proveniente dal discorso
poetico, l’altro dai racconti di viaggi, specialmente di quelli dei pellegrini che si
recavano a Gerusalemme. A partire da Omero e Virgilio fino alla Franciade e ai
Lusiadi non vi è stato un poema epico senza qualche tempesta, che d’altronde è
sempre stata in primo piano anche nei romanzi medievali (Bruto, Rou, Tristano
ecc.): la tempesta che all’ultimo istante divide Isotta dal suo amato.
4 «Quale
tema è più scontato» osservava G. Bachelard «di quello della collera
dell’oceano? Un mare calmo viene visto improvvisamente corrucciato, mentre
romba e ruggisce. Al mare vengono applicate tutte le metafore della furia, tutti i
simboli animali del furore e della rabbia […] Il fatto è che la psicologia della
collera è in fondo tra le più ricche e sfumate […] Si possono proiettare molti più
stati psicologici nella collera che nell’amore. Le metafore del mare sereno e
buono saranno quindi meno numerose di quelle del mare cattivo.»
5 Comunque,
la tempesta non è solo un tema letterario e un’immagine delle violenze umane. È
anche, in primo luogo, un fatto d’esperienza che tutte le cronache della
navigazione verso la Terrasanta riferiscono. Nel 1216 il vescovo Jacques de
Vitry si reca a San Giovanni d’Acri; al largo della Sardegna, i venti e le correnti
spingono un’altra nave verso quella su cui egli si trova: l’urto sembra inevitabile,
tutti gridano, si precipitano a confessarsi con grandi pianti di pentimento. Ma
«Dio ebbe pietà della nostra afflizione».SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
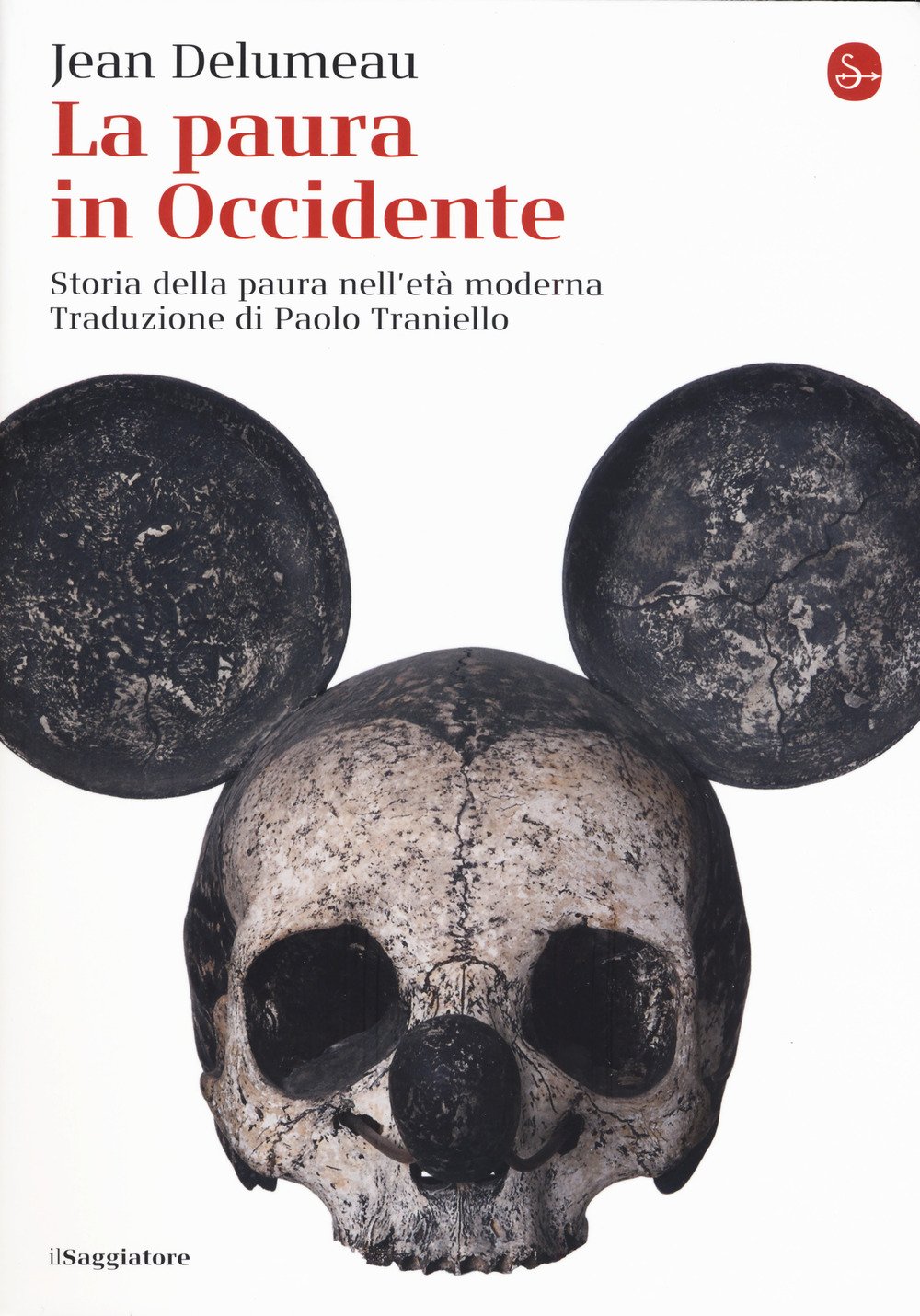






Commento all'articolo