Piccole e grandi paure. Conoscerle per superarle e ritrovare la libertà perduta – Giampaolo Perna
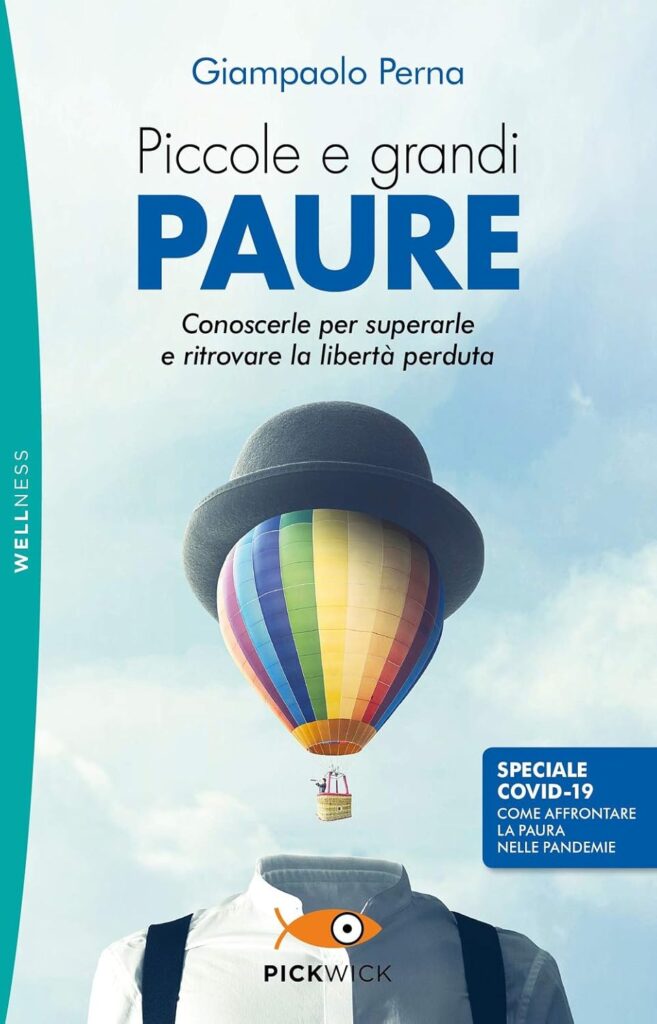
SINTESI DEL LIBRO:
La pandemia da COVID-19 è un avvenimento che ci ha colto alla
sprovvista negli ultimi mesi, ma non è l’unica emergenza da epidemia
che ha vissuto il genere umano.
Anche in altri periodi storici (durante la diffusione di malattie
infettive come la peste, il vaiolo, l’influenza Spagnola, l’Asiatica,
l’Ebola, la SARS, solo per dirne alcune...) l’uomo si è dovuto
confrontare con rischi e pericoli sostanzialmente invisibili ai suoi
occhi, ma estremamente aggressivi.
Ed è proprio l’invisibilità del nemico che può scatenare in noi forti
reazioni di ansia e paura e portare al panico, popolarmente inteso
come un’emozione di estrema paura e angoscia.
In questi momenti, la nostra mente gioca in difesa in modo da
minimizzare i rischi e ci costringe a comportamenti che limitano le
nostre capacità di esplorazione, mettendoci in attesa fino a
immobilizzarci.
Di fronte a un pericolo come quello della pandemia, è giusto
avere paura?
Una delle funzioni principali della nostra intelligenza emotiva è quella
di aiutare sia noi come soggetti individuali sia l’essere umano, come
comunità e specie, a sopravvivere. Il bagaglio delle nostre emozioni
primarie è composto da un’emozione positiva, la gioia; una neutra, la
sorpresa; e ben quattro negative: la rabbia, la paura, il disgusto e la
tristezza. Dunque, ben il 66% delle nostre emozioni primarie sono
negative. Questo perché il processo evolutivo ha selezionato le
emozioni negative come il miglior sistema di difesa per la nostra
sopravvivenza. Dunque, vivere la paura, la rabbia e la tristezza in un
momento pericoloso per noi come individui e per il genere umano è
assolutamente naturale. In quest’ottica, il generalizzato senso di
paura e ansia, se da un lato ci crea disagio, dall’altro potenzia le
nostre capacità di difenderci stimolando l’attenzione, la cautela,
rendendoci più reattivi. La paura e l’ansia diventano così preziose
amiche per mettere in atto tutte le difese e i comportamenti necessari
per superare il momento difficile.
☞ Ricordate: Avere paure ed essere in ansia di fronte a un pericolo è normale e utile.
Una delle migliori strategie che la nostra mente mette in atto, di
fronte a una minaccia come il virus, è quella di identificare il più
possibile il nemico. Per questo ci aggrappiamo a telegiornali,
trasmissioni di informazione televisiva e radiofonica, ci catapultiamo
ansiosamente nel mare magnum del web, cercando notizie,
suggerimenti, rassicurazioni, con il rischio di essere attratti da ciò che
vogliamo vedere e di cadere in uno stato confusionale, sopraffatti
dall’incertezza dovuta alle troppe informazioni contradittorie. È poco
più di una banale influenza, è pericolosa solo per gli anziani, ha un
tasso di mortalità molto maggiore dell’influenza, distruggerà
l’economia, la sanità sarà al collasso, abbiamo uno dei sistemi
sanitari più validi del mondo, state a casa, a lavorare, usate le
mascherine, le mascherine non sono così utili, e così via. La
confusione, l’incertezza, il senso d’impotenza ci assalgono e ci
invadono sempre di più, scatenando angosce e paure che si
accompagnano a comportamenti non sempre davvero utili, se non
addirittura dannosi.
Come possiamo avere la giusta dose di paura?
La reazione emotiva deve essere ovviamente proporzionata al
pericolo che dobbiamo affrontare e la risposta è tanto più adeguata
quanto più il pericolo è conosciuto. Avere informazioni chiare,
precise, di facile comprensione è la chiave per trovare il giusto livello
di ansia, allerta, e di paura. La responsabilità di una corretta
comunicazione da parte degli organi istituzionali e della stampa è
fondamentale, come pure la nostra capacità di discriminare le
informazioni affidabili da quelle che non lo sono. Quando il pericolo
non è ben definito e le informazioni risultano incoerenti, allora ci
mettiamo nel massimo grado di ansia, allerta e paura.
☞ Ricordate: Per avere una reazione ansiosa e una paura adeguate è fondamentale
avere informazioni chiare e corrette.
Nelle situazioni di emergenza, l’informazione gioca un ruolo
fondamentale, perché permette di attivare correttamente le nostre
difese nel modo più appropriato. Di fronte a qualsiasi pericolo,
possiamo scegliere i comportamenti ottimali soltanto se abbiamo
un’idea chiara del “nemico” che dobbiamo affrontare, e quando
questo è invisibile, come nel caso delle infezioni batteriche e virali,
diventa ancor più cruciale saper scegliere dove attingere le
informazioni valide. Spesso queste fonti sono gli esperti in materia,
che hanno gli strumenti per leggere meglio la situazione, come con
una specie di lente d’ingrandimento, e che ci forniscono dati e
opinioni aiutandoci ad avere il miglior quadro possibile della
situazione.
Tuttavia, spesso in questi frangenti, opinionisti ed esperti sembrano
dividersi in due categorie distinte: i “rassicuranti” e i “catastrofizzanti”.
Persone di alto profilo ed esperienza discutono i dati, i
provvedimenti, le esperienze professionali portando punti di vista
differenti. E allora, come mai tutta questa confusione? Come mai
esperti autorevoli e persone di riconosciuta saggezza danno tante
informazioni incoerenti e opinioni molto diverse tra loro, se non
addirittura opposte? La risposta sta nel cosiddetto “bias
confirmatorio” che, in poche parole, non rappresenta altro che la
tenacissima tendenza a rimanere attaccati ai propri punti di vista in
maniera pregiudizievole. Anche gli esperti, tutti, me compreso, siamo
in balia di questo limite.
L’espressione bias confirmatorio (letteralmente “tendenza alla
conferma”) definisce in psicologia uno dei fenomeni più umani e
frequenti in ogni tempo e latitudine. È un termine tecnico, ma che
potrebbe essere semplicemente definito come pregiudizio, nel suo
significato più comune di: giudizio che viene dato prima di conoscere
fatti o persone, e che condiziona quello che vediamo e quello che
ascoltiamo. In poche parole, la nostra mente, attraverso questo
meccanismo, si forma un’opinione su un argomento o su una
persona, basandosi su convinzioni personali o comunemente
accettate, dopo di che cerca tutte quelle notizie e informazioni che
confermano il suo pre-giudizio, diventando cieca di fronte a tutto ciò
che contraddice la sua idea iniziale. Il bias confirmatorio non ha
conseguenze particolarmente gravi quando ci si chiede se per la
nostra salute mentale sia meglio il mare o la montagna, ma può
portarci a comportamenti pericolosi per noi stessi e per gli altri di
fronte a minacce difficilmente identificabili e non direttamente
osservabili.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :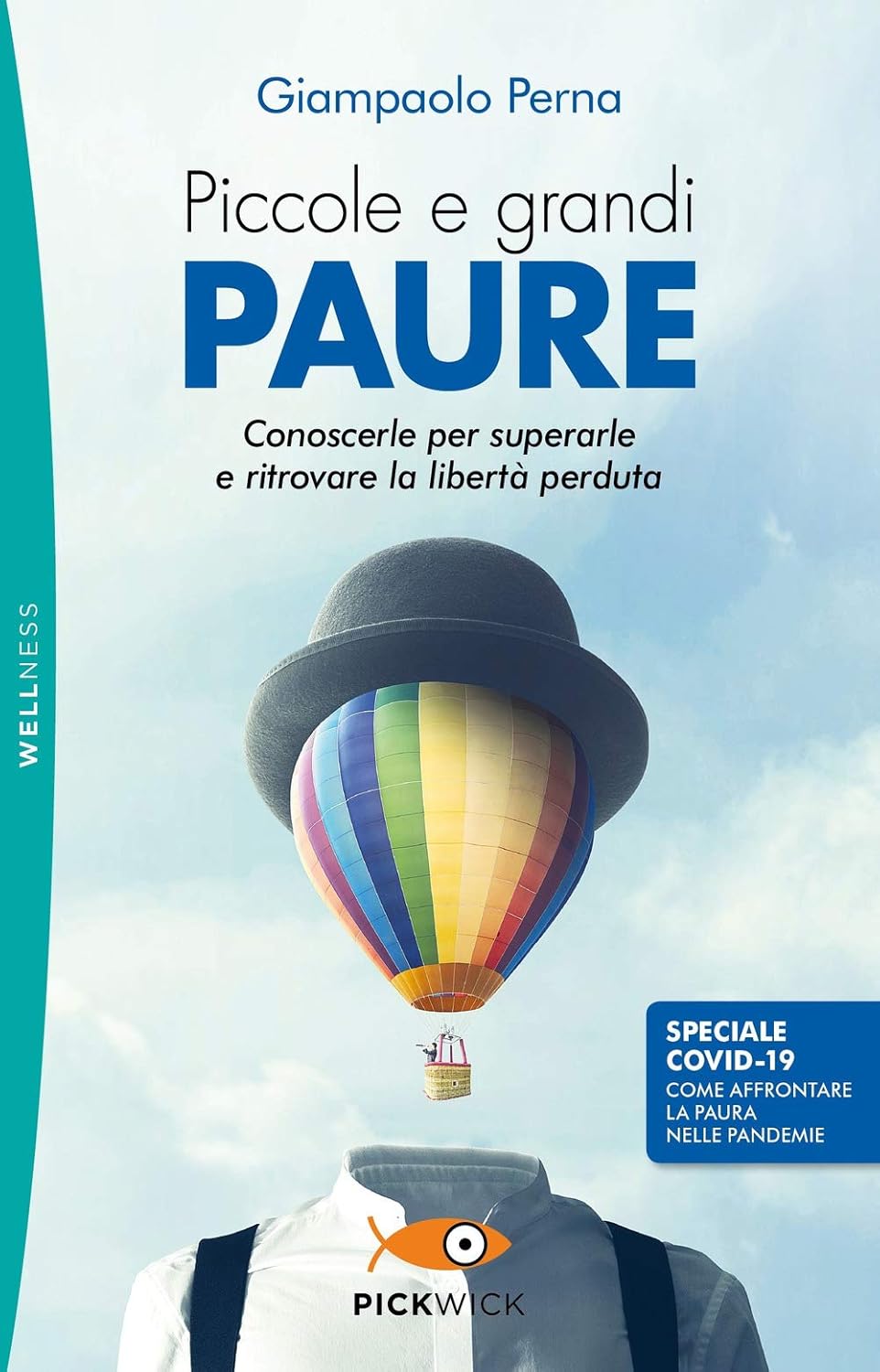






Commento all'articolo