Perché il buddhismo fa bene – La scienza e la filosofia alla base di meditazione e illuminazione – Robert Wright
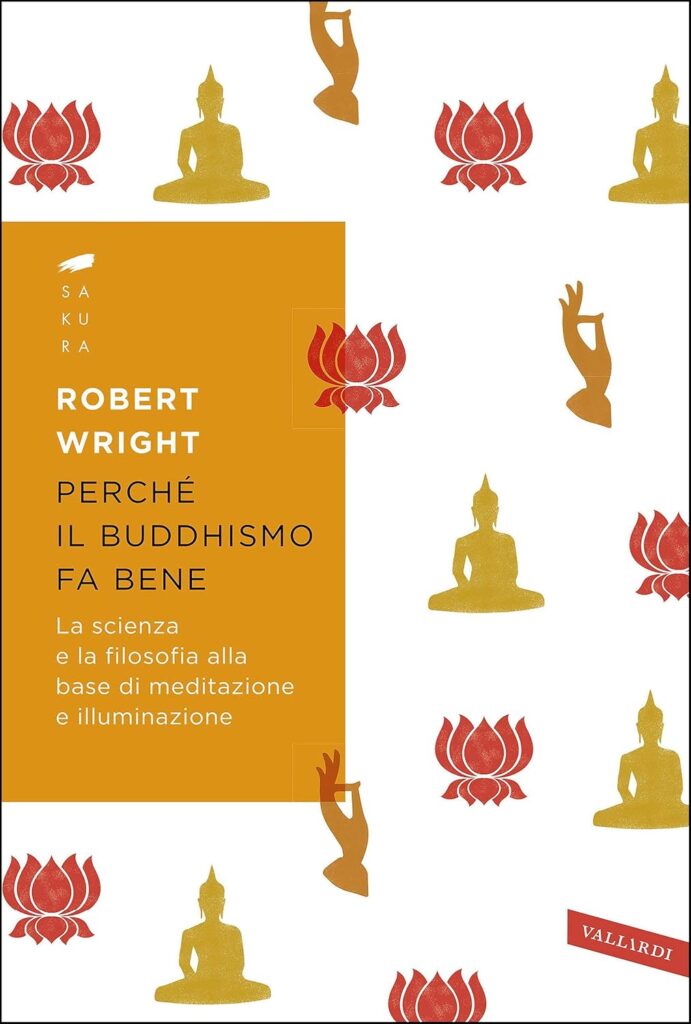
SINTESI DEL LIBRO:
Non vorrei far apparire più drammatica del dovuto la condizione
umana, ma avete presente il film Matrix?
Parla di un ragazzo chiamato Neo (interpretato da Keanu Reeves)
che scopre di aver sempre abitato in un mondo immaginario. La vita
che credeva di avere vissuto era solo un’elaborata allucinazione.
Intanto che lui sogna, il suo corpo fisico si trova avvolto in un
baccello appiccicoso grande quanto una bara, accanto ad altri
baccelli, file e file di baccelli, ciascuno contenente un essere umano
che dorme e sogna. Tutti questi individui sono stati calati nei baccelli
da alcuni robot, che li dominano e li tengono tranquilli facendo loro
sognare vite immaginarie.
La scelta che Neo si trova a fare – se continuare a vivere un’illusione
o svegliarsi e affrontare la realtà – sta tutta nella famosa scena della
«pillola rossa». Neo è stato contattato da alcuni ribelli che sono
entrati nel suo sogno (o, per essere più precisi, i cui avatar sono
entrati nel suo sogno). Il loro capo, Morpheus (interpretato da
Laurence Fishburne), spiega a Neo la situazione: «Sei uno schiavo,
Neo. Come tutti quanti, sei nato in catene, in una prigione che non
puoi toccare né vedere. Una prigione per la mente». La prigione si
chiama Matrix, ma nessuno è in grado di descriverla agli altri. L’unico
modo è «scoprire da sé di cosa si tratta». Morpheus offre a Neo due
pillole, una rossa e una blu. Se Neo prende quella blu, tornerà al suo
mondo dei sogni, se prende quella rossa squarcerà il velo delle
illusioni. Neo sceglie la pillola rossa.
Si tratta di una scelta radicale: una vita di illusione e schiavitù contro
una di illuminazione e libertà. Si tratta di una decisione tanto
drammatica da apparire adatta a un film hollywoodiano, mentre le
scelte poste dalla vita quotidiana di solito sono più banali, meno
radicali. Eppure, quando il film è uscito, molte persone vi hanno
intravisto un riflesso delle proprie scelte personali.
Alludo in particolare a quelli che si potrebbero definire i buddhisti
occidentali, statunitensi o persone di altri Paesi, che non sono nati
buddhisti ma che lo sono diventati a un certo punto della propria vita.
Questi individui hanno adottato una versione del buddhismo epurata
da alcuni degli elementi soprannaturali che sono presenti, invece,
nel buddhismo orientale, come la fede nella reincarnazione e in varie
divinità. Questo buddhismo occidentale è fondato su parte della
pratica buddhista che in Asia è comune a monaci e laici: la
meditazione e l’immersione nella filosofia. (Due delle idee più diffuse
tra gli occidentali a proposito del buddhismo – che sia basato su una
visione ateistica e sulla meditazione – sono errate: quasi tutti i
buddhisti orientali credono nelle divinità, sebbene queste non
somiglino al Dio cristiano, onnipotente creatore del mondo, e non
meditano.)
I buddhisti occidentali avevano capito ancora prima di vedere Matrix
che il mondo da loro conosciuto era una sorta di illusione: non
un’allucinazione vera e propria, ma una versione deformata della
realtà che, a sua volta, deformava il loro approccio alla vita, con
conseguenze negative per loro e per le persone che li circondavano.
Grazie alla meditazione e alla filosofia buddhista, invece, avevano
l’impressione di vedere le cose con più chiarezza. Matrix sembrava
un’allegoria perfetta per il cambio di prospettiva che avevano
attraversato, e divenne ai loro occhi un «film dharma». La parola
dharma ha diversi significati, che comprendono gli insegnamenti del
Buddha e il percorso che i buddhisti dovrebbero seguire per metterli
in atto. Dopo Matrix, invece di «seguo il dharma», si cominciò a dire:
«Ho preso la pillola rossa».
Ho visto Matrix nel 1999, quando è uscito al cinema, e alcuni mesi
dopo ho scoperto di avere un legame con esso. I registi del film, i
fratelli Wachowski, avevano dato a Keanu Reeves tre libri da leggere
per prepararsi a interpretare il ruolo di Neo. Uno di essi era un libro
che avevo scritto alcuni anni prima, The Moral Animal: Evolutionary
Psychology and Everyday Life (L’animale morale: psicologia
evoluzionistica e vita quotidiana).
Non so esattamente che nesso avessero visto i registi tra il mio libro
e Matrix. Ma so che collegamento ci trovo io. La psicologia
evoluzionistica può essere descritta in vari modi, e io nel mio libro
l’avevo definita così: lo studio del modo in cui il cervello umano è
stato programmato – dalla selezione naturale – per ingannarci, o
addirittura per renderci schiavi.
Non fraintendetemi: la selezione naturale ha alcuni pregi, e
preferisco essere stato plasmato da essa piuttosto che non esistere
per nulla, essendo queste le due uniche opzioni che, a quanto ne so,
l’universo mette oggi a disposizione. Essere un prodotto
dell’evoluzione non si riduce esclusivamente a schiavitù e illusione. Il
cervello evoluto ci conferisce diversi mezzi per acquisire una visione
pressoché fedele della realtà.
Tuttavia, la selezione naturale mira a un unico scopo (dovrei mettere
tra virgolette «mira» perché si tratta di un processo cieco, non
dell’azione di una mente consapevole): trasmettere dei geni alla
generazione successiva. I tratti che in passato hanno contribuito alla
proliferazione dei geni tendono ad affermarsi e prosperano, mentre
gli altri tendono a scomparire. E tra le qualità che sono sopravvissute
a questa prova vi sono anche quelle mentali, cioè strutture e
algoritmi integrati nel cervello che influenzano la nostra esperienza
quotidiana. Se vi chiedete: «Che tipo di percezioni, idee ed emozioni
ci guidano ogni giorno?», la risposta non è «le percezioni, idee ed
emozioni che ci forniscono un’immagine accurata della realtà». Al
livello più autentico la risposta è: «Le percezioni, idee ed emozioni
che hanno aiutato i nostri antenati a trasmettere il patrimonio
genetico alla generazione successiva». Che quelle percezioni, idee
ed emozioni ci forniscano un’immagine veritiera della realtà non è
scontato. E infatti, a volte non è così. Il cervello talvolta è progettato
per illuderci.
Non c’è nulla di male in questo. Alcuni dei miei momenti più felici
sono frutto di chimere: credere, per esempio, che il topolino mi
facesse visita quando perdevo un dente. Altre volte, invece,
l’illusione può creare situazioni orribili. Non parlo solo di vissuti che,
a posteriori, attribuiamo facilmente alla fantasia, come degli incubi
spaventosi, ma anche di situazioni in cui è più difficile prendere atto
di una deformazione della realtà, come quando, di notte, restate
svegli per colpa dell’ansia. O quando attraversate periodi di
disperazione, o di depressione. O quando provate accessi di rabbia
verso qualcuno, che sul momento vi fanno sentire bene ma che
piano piano vi corrodono dall’interno. O quando avete desideri
irrefrenabili, come il bisogno irresistibile di comprare, mangiare o
bere oltre il ragionevole.
Anche se queste sensazioni – ansia, disperazione, odio, avidità –
non sono frutto della vostra immaginazione tanto quanto un incubo,
se le esaminate da vicino vedrete che implicano qualche elemento
ingannevole, senza il quale vivreste meglio.
E se voi stareste meglio senza, immaginate quanto starebbe meglio
il mondo intero. Dopotutto, disperazione, odio e avidità producono
guerra e altre atrocità. Se ciò che dico risponde al vero – se queste
fonti di sofferenza e crudeltà umana sono in gran parte il prodotto di
un’illusione – è opportuno smascherarle.
È logico, no? Esiste però un problema che ho cominciato a capire
poco dopo aver scritto il mio libro sulla psicologia evoluzionistica:
l’utilità dello smascherare un’illusione, sbandierandola alla luce del
giorno, dipende dal tipo di luce. A volte capire la sorgente più pura
della vostra sofferenza non è di grande aiuto.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :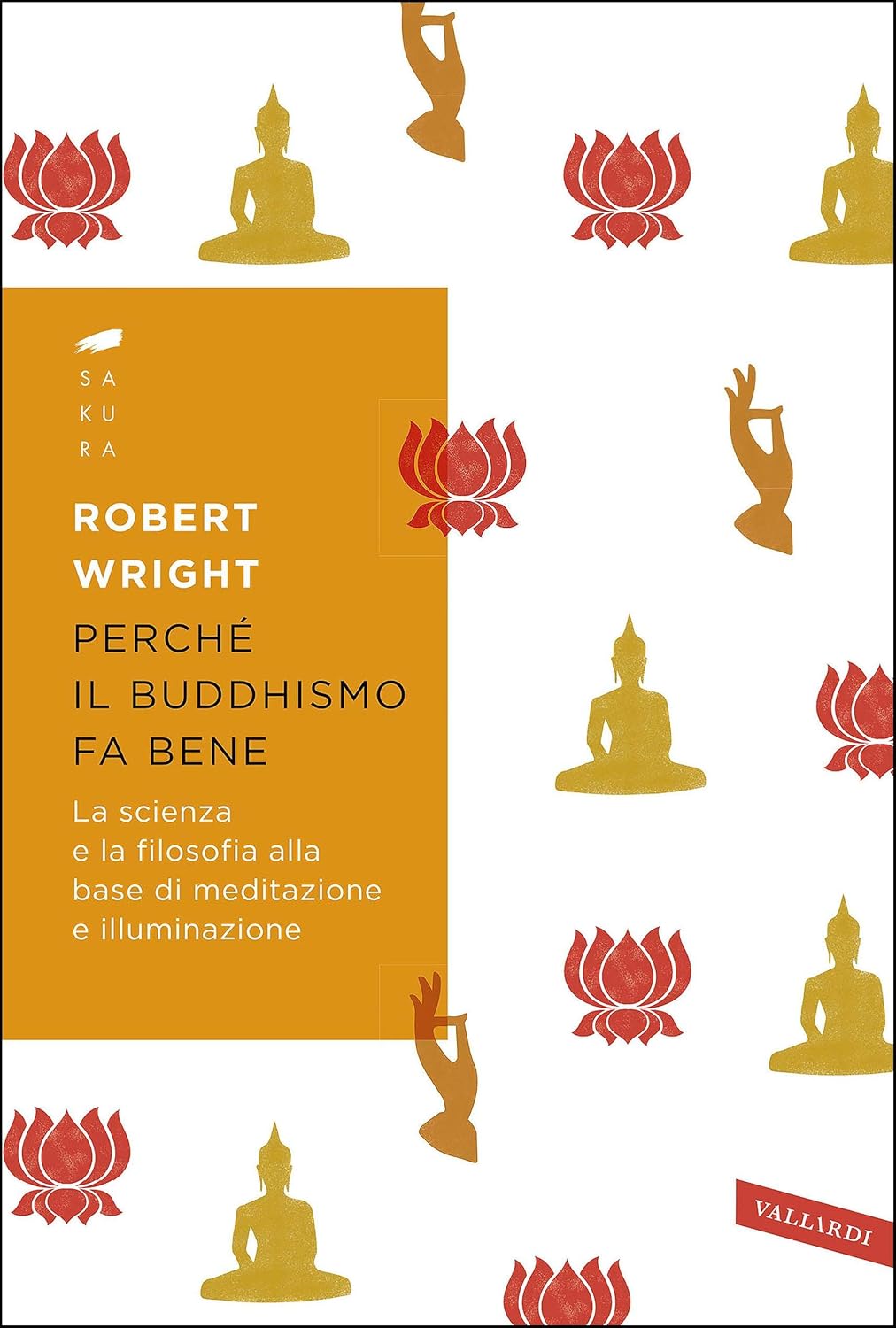






Commento all'articolo