Non guardare nell’abisso – Massimo Polidoro
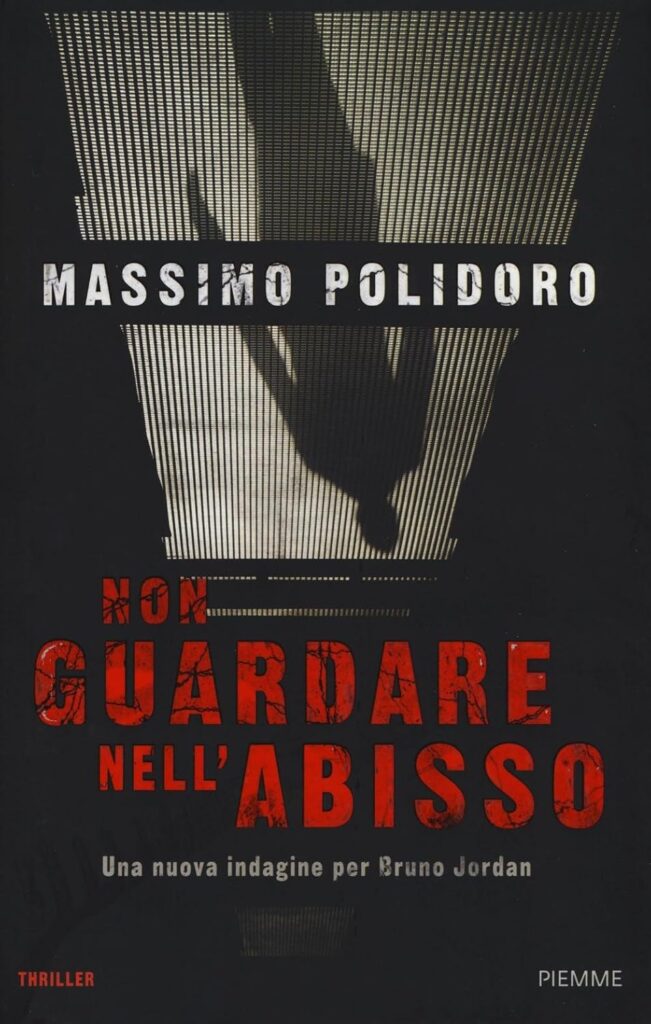
SINTESI DEL LIBRO:
Era stata una bella corsetta, tutto sommato, almeno finché non
erano spuntati i coltelli e i tirapugni.
Avevo messo la sveglia all’alba, come facevo ormai da un mese,
e mi ero preparato per la mia corsa mattutina. Niente di speciale,
una decina di chilometri al Parco Sempione, ma volete mettere la
tranquillità alle 6.30 del mattino?
Era stato Gip a convincermi. Diceva che dopo i fatti dell’anno
prima, quando avevo rischiato la pelle per ritro vare Monica Ferreri, e
soprattutto dopo la morte di Co stanza, avevo bisogno di tirarmi su.
«Se vuoi ti rimetto in sesto io» mi aveva detto. «Se non vuoi, va
bene uguale. Ma scordati la mia faccia.»
Sempre stato uno di poche parole, Gip. Poche, ma buone. Infatti
non aveva tutti i torti. Avevo iniziato a bere qualche bicchiere di
troppo, esageravo con le sigarette, dormivo poco e mangiavo male.
E poi c’erano le pasticche che quel farabutto di Tyson mi procurava
ogni volta che gliele chie devo. Insomma, mi ero infilato dritto dritto
sulla classica brutta china.
Non era una scelta difficile: o sprofondavo nella merda o
afferravo la mano che Gip mi tendeva. E io l’avevo afferrata.
Cazzo, però, se rompeva i coglioni. Avete presente «dai la cera,
togli la cera»? Ecco, a lui il maestro Miyagi faceva un baffo. Mi
aveva messo sotto di brutto. Prima avevo do vuto dire addio a
superalcolici, fumo e pasticche, of course.
Poi era stata la volta della dieta: tanti saluti ad hamburger e
patatine, benvenute frutta fresca e verdure.
Quindi l’esercizio fisico: due volte alla settimana a nuo tare, due a
correre e tre nella palestra di Gip a imparare il Wing Chun, un’antica
forma di Kung Fu di cui il mio amico era diventato maestro alle
Hawaii. Giorni di riposo? Non fatemi ridere.
Per completare il tutto, oltre a dormire le salutari otto ore di sonno
– abitudine inaudita per me – mi aveva pure convinto a curare un
piccolo orto sul terrazzino. Diceva che aiutava la concentrazione.
Ecco, ora non fatevi la bizzarra idea che in quei pochi mesi mi
fossi trasformato in un monaco zen o in un santo. Non lo ero prima e
non lo sarò mai, poco ma sicuro. Ogni tanto, la seratina folle me la
concedevo ancora… Però la “cura” di Gip mi aveva aiutato. E un po’
alla volta stava funzionando.
Avevo ricominciato a lavorare a «Krimen», la rivista da cui me
n’ero andato subito dopo il caso di Monica, deciso a non metterci
mai più piede. Il fatto, però, è che sono un giornalista e non saprei
che altro mestiere fare. E poi avevo bisogno di soldi.
Avevo infatti avuto la generosa ma poco lungimirante idea di
prendermi in casa mio padre, malato di Alzheimer e convinto di
vivere ancora negli anni Sessanta, quando era stato una piccola
stella della musica Beat. Gestirlo si era ri velato un problema più
grosso del previsto e avevo dovuto assumere una badante
ecuadoregna, Pepita, che stava con lui tutto il giorno e le notti in cui
mi dovevo assentare. In altre parole, incassavo lo stipendio e lo
giravo direttamente sul conto corrente di Pepita.
Però le cose iniziavano a girare bene. Avevo superato le pulsioni
autodistruttive, anche se certe notti, quando Co stanza tornava a
visitarmi in sogno, sentivo ancora un do lore atroce incendiarmi il
petto. Ma succedeva sempre più di rado. E, soprattutto, ogni cosa
passava quando mi met tevo a correre.
E così, anche quella mattina, arrivai al parco, puntuale come il
sole che sorge, scambiai un saluto con Rocco, il cu stode che apriva
ogni giorno la cancellata, e iniziai il mio giro. Costeggiavo l’Arena,
passavo dietro all’Acquario e poi mi inoltravo verso il laghetto,
direzione Triennale.
Sempre lo stesso giro, mai una variazione, mai una sor presa.
Tranne quella mattina.
Prima sentii i passi sulla ghiaia. Strano: in genere i corri dori più
mattutini arrivavano solo dopo dieci, quindici mi nuti dal mio ingresso.
Poi il tipo mi superò.
Portava i pantaloni lunghi e una felpa con il cappuccio sulla testa.
Curioso, a quell’ora non c’era ancora il caldo fastidioso che sarebbe
arrivato nel giro di un paio d’ore, ma certo non faceva così freddo da
coprirsi a quel modo.
Lo sconosciuto, un ceppo di quercia con due spalle massicce e
gambe robuste, si piazzò a un paio di metri davanti a me e lì rimase.
Già pensavo di cambiare percorso, quando un secondo runner mi
superò.
Questo era più magro e sembrava fare più fatica. Pure lui aveva
il cappuccio sulla testa. Affiancò il suo collega e continuarono a
correre insieme sempre poco distanti da me.
Non amavo la corsa di gruppo, così al primo sentiero che si aprì
di lato feci per svoltare, ma un terzo tizio con il cappuccio mi si parò
davanti a braccia larghe.
Mi fermai.
«Scusa, ti dispiace? Devo andare da quella parte.»
Il tipo, un grassone con la barba lunga e sporca, s’infilò una
mano in tasca e tirò fuori un coltello a serramanico. Premette il
pulsante e la lama scattò.
Mi voltai per filarmela, ma mi accorsi che anche gli altri due tizi si
erano fermati. Quello più muscoloso indossava sulla mano destra un
tirapugni in acciaio. Lo smilzo, invece, impugnava un coltello come il
socio barbuto.
«No, guardate» sbuffai simulando noia. «Bellissimi i vo stri
aggeggi, ma sono uscito senza soldi e a quest’ora non compro
niente.»
Sono sempre stato un fulmine con le battute, riesco a stendere
chiunque con una frecciata ben piazzata.
«Faccia di merda» disse il panzone con una vocina stri dula. «Va’
là dentro o ti apro la pancia in due.»
Appunto.
Il tizio indicò un boschetto. Gli altri due si avvicinarono agitando
le mani e mi resi conto che non avevo scelta.
«Cos’è, sono finito in un raduno di scaricatori di porto? Guardate
che qui non c’è il mare…»
«Chiudi la bocca, stronzo» disse quello alto con il cappuc cio.
«Non ti è ancora passata la voglia di dire puttanate?»
Eravamo in una radura circondata da faggi nel pieno ri goglio.
Non c’era ancora nessuno al parco, ma anche se ci fosse stato
qualcuno non avrebbe potuto vedere quello che succedeva là
dentro.
Poiché l’ironia non aveva funzionato, cercai di riportare la
discussione su un piano logico.
«Sentite, mi sa che qui c’è un equivoco.»
«Equivoco ’sta minchia!» disse il panzone.
Turpiloquio uno, logica zero.
Il grassone agitava il coltello saltellando da un piede all’al tro, era
tutto sudato e i capelli sporchi gli si appiccicavano alla faccia. Quel
grugno porcino e la vocina chioccia, però, mi erano famigliari.
«Non dirmi che non ti ricordi, cazzone!» esclamò lo spi lungone
alle mie spalle. Si tolse il cappuccio e mise in mo stra un cranio
pelato su cui era tatuato un arzigogolo di di segni scuri alla moda dei
rapper americani.
Anche il terzo soggetto si abbassò il cappuccio e digri gnò i denti
storti e bacati.
Di colpo li riconobbi. «Siete i fessi con l’Hummer!»
Era successo l’anno prima, quando l’indagine che mi ero messo
a condurre sulla scomparsa di Monica mi aveva por tato sulle tracce
di un individuo poco raccomandabile, il Rosso. Lui se n’era accorto e
cinque balordi suoi compari mi avevano teso un agguato. Tre di loro
erano ora davanti a me.
«Dove sono gli altri due coglioni?» domandai. «Se la facevano
sotto all’idea di affrontarmi di nuovo?»
Il cuore aveva iniziato a battermi più forte e l’adrena lina mi
scorreva a fiumi nel sangue. Ero sicuramente più in forma dell’anno
prima, e avevo anche imparato un paio di mosse di Kung Fu, ma
quelli erano pur sempre in tre e pure armati. E questa volta non
sarebbe arrivato Gip a to gliermi dagli impicci.
Dovevo agire d’astuzia. La prima regola era quella di non lasciare
all’avversario la possibilità di prepararsi. Bisognava colpire per primi
e sfruttare l’effetto sorpresa.
Il grassone continuava a saltellare e sembrava pronto a caricare.
Non gli diedi il tempo di fare un passo. Da fermo che ero, scattai di
lato e gli rifilai un calcio alla bocca dello stomaco. Strabuzzò gli occhi
e precipitò a terra senza fiato. Il coltello gli cadde di mano.
Gli altri due si mossero e io fui pronto a raccogliere la lama. Ora
eravamo tutti e tre armati, ma loro erano comun que in vantaggio
numerico.
«Stavolta non andrà come allora» sibilò il tizio tatuato. «E la
pagherai anche per il Rosso.»
Non era finita bene per quel delinquente, ma io non ne avevo
colpa.
«È stato lui a buttarsi di sotto» spiegai mentre spostavo lo
sguardo dall’uno all’altro. «Non l’ho spinto io.»
«Zitto, bastardo!» strillò quello piccolo. Sembrava sotto l’effetto di
eccitanti e probabilmente lo era. «L’hai ucciso tu! E ora tocca a te.»
Mister idrofobia si lanciò su di me tentando di infil zarmi. Si spinse
talmente forte che mi bastò scansarmi di lato per ricevere solo una
gomitata sul mento. Gli intrap polai il braccio con il coltello in una
presa e lo strattonai all’indietro. Non glielo spezzai, ma lo feci finire
in ginoc chio con le lacrime agli occhi.
«E due» dissi col fiato che iniziava a farsi corto.
«Vuoi fare anche tu la stessa fine» dissi al rapper de noan tri, «o
la chiudiamo qui e andiamo ognuno per la sua strada? Non c’entro
niente con la morte del vostro amico, io…»
Non sentii i passi alle mie spalle e non vidi il ramo che si
schiantava sulla mia nuca spezzandosi in due. Qualcosa esplose nel
mio cervello, mi sentii come se la testa fosse tra passata da migliaia
di spilli e la vista mi si oscurò. Finii fac cia a terra in un secondo.
Quel maledetto ciccione era riuscito a rialzarsi e mi aveva preso
di sorpresa.
Cercai di voltarmi, mentre sentivo il terreno ondeggiarmi sotto la
schiena come fossi su una zattera sbatacchiata dal mare mosso.
Quello che sembrava il capo troneggiava sopra di me, mentre il
grassone aiutava l’altro tizio a rialzarsi.
«Vedi, Jordan?» disse. «La fortuna può cambiare in un batter
d’occhio. E la tua si è ormai esaurita.»
Quindi, tese la mano e mi tirò in piedi come fossi una bambola di
pezza. Quel movimento repentino mi fece sa lire qualcosa
dall’esofago, ma riuscii a reprimere il senso di vomito.
«Ok» dissi con la gola secca. «Ditemi che cazzo volete da me.»
Il pelato ridacchiò. «Farti la pelle, non è ancora chiaro?»
Quindi, mi prese per la maglietta e con l’altra mano mi tirò un
pugno allo stomaco che mi alzò da terra di qual che centimetro.
Sembrò che un mattone mi fosse scoppiato nella pancia mentre
miliardi di stelle mi rendevano nuova mente cieco.
Caddi di nuovo in terra, sentendomi come uno straccio fradicio
appena usato per pulire i pavimenti. Il sangue mi pulsava nella testa
e ne sentivo anche il sapore rugginoso in bocca.
«Addio, stronzo» disse il pelato mentre alzava il coltello.
Vidi il braccio sollevarsi e mi rannicchiai stretto, cer cando di
proteggere la testa. Chiusi gli occhi aspettandomi il colpo, ma non
arrivò.
Quando li riaprii vidi che i tre se la davano a gambe uscendo
dalla radura e scomparendo.
«Ma che caz…» iniziai a dire, poi vidi una mano tesa so pra di
me. La presi e mi rialzai in piedi.
La testa mi faceva un male atroce e lo stomaco mi bru ciava.
Deglutii combattendo contro i conati di vomito e poi sollevai lo
sguardo.
Davanti a me c’erano due sconosciuti in abito scuro con le pistole
in pugno.
Sputafuoco vince su trinciapolli, due a zero.
«Grazie, signori, ma non era il caso» dissi con una smor fia che
tentava senza successo di sembrare un sorriso. «An cora un po’ e li
massacravo.»
I due rimasero impassibili e le mani che impugnavano le pistole si
mossero. Ora tenevano me sotto tiro.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :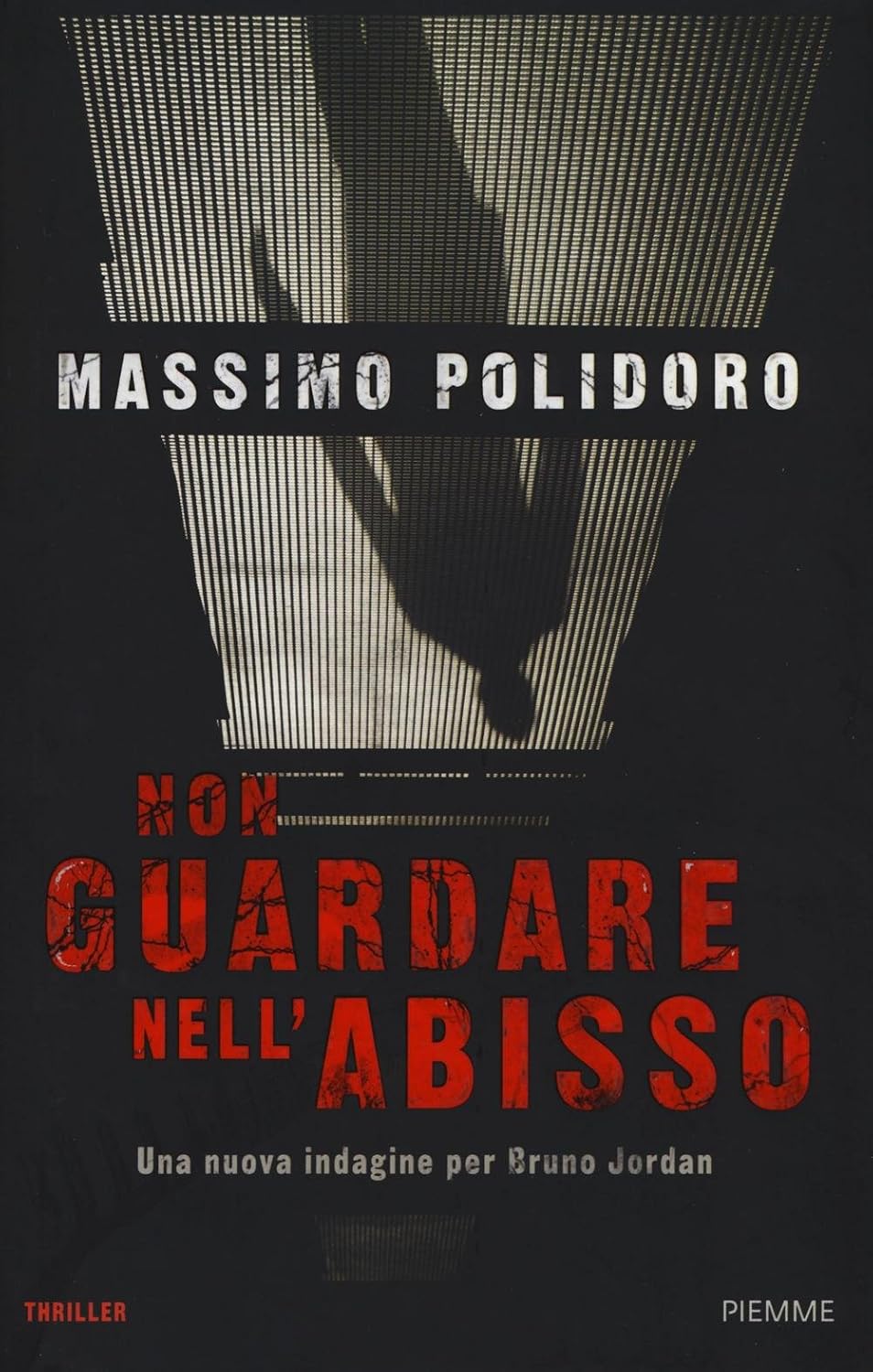






Commento all'articolo