Noi, Partigiani – Memoriale della Resistenza italiana – Gad Lerner
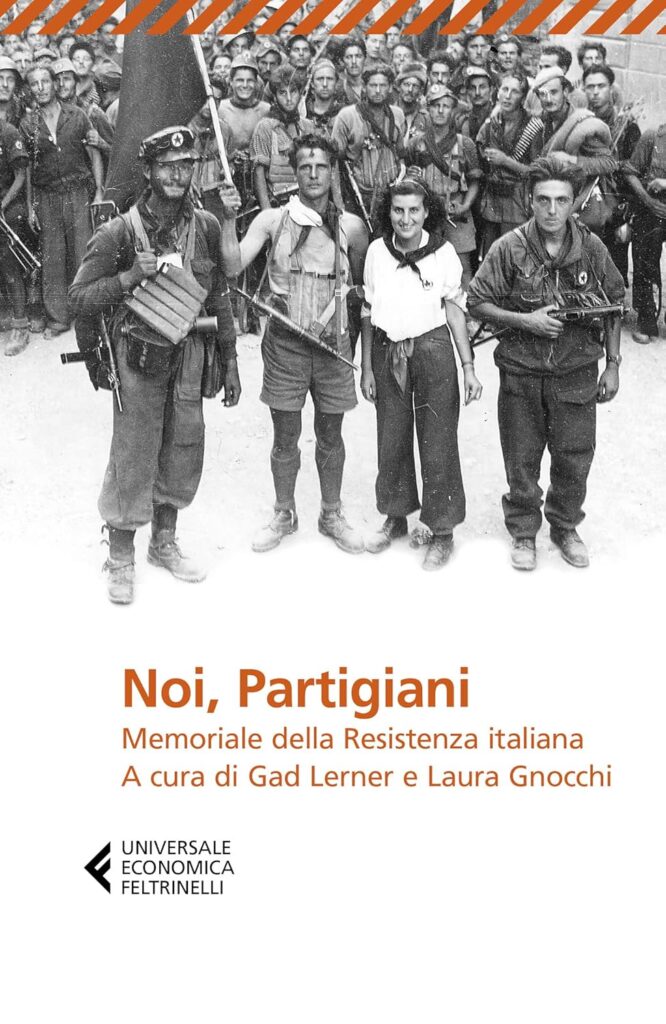
SINTESI DEL LIBRO:
Non dite che siete scoraggiati, che non ne volete più sapere.
Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto
sapere.”
Queste parole le ha scritte un mio amico nell’ultima lettera prima
di essere fucilato dalle brigate nere il 10 novembre 1944 a Modena.
Si chiamava Giacomo Ulivi, studente universitario di medicina, aveva
appena compiuto diciannove anni. Giacomo era un partigiano, come
me. La medaglia d’argento gli è stata conferita alla memoria. Io
invece l’ho ricevuta da vivo, ma nel 1997, cioè più di mezzo secolo
dopo i fatti di cui sono stato protagonista. In mezzo, me ne hanno
fatte passare di tutti i colori. Ogni giorno della mia vita Giacomo
continua a essere con me. Ed è grazie a persone come lui che ho
resistito a testa alta anche quando si è cercato di infangare una
pagina luminosa della nostra storia.
Ora che ho compiuto un secolo, e di nuovo si riaffaccia di fronte a
noi il cupo richiamo dell’autoritarismo, non posso dimenticare il
valore umano delle persone al cui fianco ho combattuto. Mi porto
sempre dentro anche il ricordo di Angiolino Morselli, nome di
battaglia Pippo. Era insieme a me, a Fosdondo di Correggio, il 15
aprile 1945, quando ci imbattemmo in un’autocolonna di fascisti in
ritirata ma ancora bene armati. Noi eravamo duecento partigiani, loro
trecento almeno, forse quattrocento, ma i numeri a quei tempi non
erano così importanti. Si poteva perdere in molti, vincere in pochi.
Quel giorno rimasi ferito e, per questo, non riuscivo a utilizzare il
mitra. Io ero il comandante, ed era giusto che stessi lì in prima linea.
Non potendo sparare, ordinai al mio distaccamento di sganciarsi per
riparare dietro la ferrovia, che costituiva un buon argine. Ci si poteva
difendere, anche se eravamo meno dei nemici. Angiolino, anzi
Pippo, però non si mosse. Si sacrificò per offrirci copertura. Restò al
suo posto fino all’ultima bomba a mano, fino all’ultima pallottola del
suo mitra, prima che i fascisti lo uccidessero.
Qui a Correggio, il comune di cui subito dopo la Liberazione venni
eletto sindaco quando avevo solo venticinque anni, ancora oggi che
ne ho cento, quando vado al mercato, mi salutano: “Ciao Dièvel,
ciao Diavolo”. Non equivocate. Non devo questo nome di battaglia a
chissà quale cattiveria. Al contrario. La mattina del 31 dicembre
1944 ero nascosto a casa di due staffette, le sorelle Morini. Feci una
stupidaggine, probabilmente la più grande imprudenza che io abbia
mai commesso nella mia vita da partigiano. Presi la bici, disarmato,
e andai verso Carpi, per incontrare alcuni amici. Dopo nemmeno
ottocento metri sbucarono dei tedeschi, armati. Ero fottuto. Mi buttai
in un fosso, che costeggiava la strada principale. Mi infilai tra gli
alberi, e cominciai a zigzagare tra gli olmi con la mia vecchia bici a
una velocità che, penso, mai più ho raggiunto nella vita. Riuscii a
seminarli, a salvarmi. Durante la fuga passai da una cascina, alle
finestre erano affacciate due contadine. Dissero: “Ma l’è prôpi un
dièvel!”. È proprio un diavolo. Da quel momento, per tutti, sono stato
il comandante Diavolo.
Dicono che ho contribuito a scrivere un pezzo di storia recente
del nostro paese. Può darsi. Quel che è sicuro, è che ho passato
dieci anni in galera da innocente. Dal 1947 al 1957. Da sindaco, ero
riuscito a convincere i miei compagni partigiani che non serviva
vendicarsi dei fascisti. La democrazia è più importante della
rappresaglia. Chi aveva compiuto dei crimini doveva pagare. Ma non
c’era da commettere il loro stesso errore.
Io avevo scelto di diventare partigiano sulla base degli
insegnamenti ricevuti da mia madre. Che non era né socialista né
comunista, ma cattolica, molto vicina ai poveri e agli ultimi. Perché li
conosceva: aveva trascorso la sua gioventù in una miseria squallida,
di fame e di stenti. Sapeva quanto importante e giusto fosse il saper
aiutare. A casa non avevamo idea di cosa fossero antifascismo e
anticomunismo, eravamo contadini. Mio padre era un piccolo
proprietario, aveva fatto sacrifici per mandarmi a Milano
all’Università Bocconi.
Fui arruolato in guerra da ufficiale carrista dell’esercito italiano.
L’8 settembre 1943 tutta la mia unità venne catturata a Tivoli dai
tedeschi. Circondati da venti carri armati Tigre. Se avessero voluto,
ci avrebbero annientati. “Deponete le armi,” ci disse il loro
comandante, “e vi portiamo subito alla Stazione Tiburtina. Siete
liberi, potete tornare a casa.” Ci arrendemmo, non potevamo fare
altrimenti. Ma io non mi fidavo. Mio padre, che aveva combattuto la
Prima guerra mondiale, mi aveva raccontato dei tedeschi. Anche in
guerra, anche tra chi si batte su fronti opposti, ci può essere pietà.
Loro non ne avevano. Per questo, mentre ci mettevano in fila verso
la Stazione Tiburtina, pensai che in qualche maniera sarei dovuto
scappare. Non era semplice, anche perché ogni quaranta metri c’era
un tedesco con il mitra. Aspettai il momento giusto e al primo tratto
di strada libero scappai, correndo più forte che potevo. Ero
giovanissimo e avevo poche certezze, ma una sola parte con cui
stare: con l’Italia, contro i tedeschi.
Tornai a casa, a Correggio, in Emilia, e diventai il comandante del
3° battaglione della 77a Brigata Sap “Fratelli Manfredi”. Prendeva il
nome da quattro fratelli trucidati insieme al padre dai fascisti che
avevano circondato la loro casa di Villa Sesso, vicino a Reggio
Emilia.
In quei mesi partecipai a tredici azioni armate. Undici furono di
tipo individuale, attaccammo cioè un singolo soldato tedesco, magari
per disarmarlo. E due, invece, furono scontri di gruppo, battaglie.
Come quella in cui morì il mio amico Angiolino, “Pippo”, Morselli.
Non dimenticai nemmeno per un istante l’insegnamento di mia
madre: cercammo di combattere i tedeschi ma anche di proteggere i
contadini che ci ospitavano e ci curavano. Ogni notte, per esempio,
organizzavo squadre di tre persone che giravano per le strade in
cerca dei tedeschi pronti a fare rastrellamenti. Perché, è vero,
morivano i partigiani. Ma venivano ammazzati anche troppi civili.
Arrivò il 25 aprile 1945. La guerra finì. Avrei dovuto essere felice.
E invece è uno dei momenti che ricordo con più malinconia e
tristezza. Dieci giorni prima, in quella dannata battaglia, Pippo era
morto. E noi avevamo incaricato il prete di Mandrio, il paese in cui
viveva, di avvisare la sua famiglia. Ma non lo fece, evidentemente.
Me ne resi conto mentre festeggiavamo la Liberazione. Eravamo per
strada, in campagna, e vidi arrivare sua sorella. Mi sorprese perché
sorrideva. Poi capii: “Dov’è Pippo?” mi chiese. Non sapeva. A
dirglielo mi si strappò un pezzo di cuore che mai più ho potuto
ritrovare.
Con quello stato d’animo, al mattino, entrai a Correggio. Gli
americani, e precisamente il comandante Adam, mi chiesero di
prendere il comando della città per mantenere i rapporti tra
l’amministrazione militare degli Alleati e il Comitato di liberazione
nazionale. Ero giovane e senza una formazione politica, ma mi
conoscevano e sapevano che ero una persona perbene, contraria a
ogni violenza. E che dunque avrei rispettato le leggi: quelle del diritto
e quelle della sacralità della vita. Se si comincia a dire “facciamo
giustizia noi”, come purtroppo a quel tempo accadeva, la violenza
prende il posto della giustizia. Uno dei miei compiti nei giorni
successivi alla Liberazione fu proprio quello: fronteggiare le
tentazioni di giustizia sommaria.
Eravamo a fine aprile, e trovai nell’ufficio che aveva ospitato la
segreteria della Repubblica di Salò un quaderno a righe. In copertina
c’era scritto: “Offerte per le Squadre d’Azio ne Mussolini”. Dentro
c’era l’elenco di tutti i benestanti che avevano dato soldi per
sostenere l’esercito fascista. Chiamai quelle persone a una a una.
Dissi loro: “Ora è arrivato il momento di fare altrettanto nei nostri
confronti. Altrimenti darete polvere da sparo a quei giovani disperati
e affamati che non hanno consegnato le rivoltelle agli americani”. Mi
ascoltarono, e io riuscii a mettere insieme un bel gruzzolo che mi
servì per organizzare la Mensa del reduce e del partigiano: ogni
giorno davamo da mangiare a duecento persone, anche di più.
Partigiani, certo. Ma pure ex fascisti repubblichini che restavano in
libertà perché non avevano commesso alcun reato. Mangiavano
insieme, ogni giorno, alla stessa tavola. Fu l’inizio di quella che fu
chiamata “conciliazione con l’avversario”, nella quale noi partigiani
dimostrammo che era possibile non comportarsi come “loro”,
spargendo odio e terrore. E molti di “loro”, i fascisti, capirono di
avere avuto torto.
In quei giorni salvai anche sei persone dalla fucilazione. Erano
fascisti, quattro uomini e due donne, detenuti nel carcere di
Correggio. Quotidianamente facevo, prima di andare a mangiare,
un’ispezione in prigione. Io ero stato preso, da partigiano. Sapevo
cosa significava vivere in quelle celle. Mentre giravo per il carcere,
entrò un comandante partigiano con un grado superiore al mio.
Aveva ordinato di tirare fuori quelle sei persone, comprese le due
donne, e le aveva messe contro il muro, pronte per essere fucilate.
“Cosa fate?” gli chiesi. “Li portiamo via.” “Ma hai il mandato di
prelevamento con il timbro?” incalzai, per prendere tempo. Mi
guardò con arroganza e prepotenza, circondato dai suoi uomini.
Capii che le cose si stavano mettendo male. Feci l’unica cosa che
era possibile fare. Non gli diedi nemmeno il tempo di rispondere e gli
urlai, puntandogli contro la pistola: “Adesso vai fuori”. Quei sei
uscirono dal carcere vivi e alcuni di loro sarebbero poi venuti a
testimoniare in mio favore al processo nel quale sarei stato
ingiustamente condannato.
Quello che è accaduto dopo è, in qualche modo, storia. Io che
non avevo nemmeno una tessera – presi in seguito quella del Partito
comunista – fui eletto sindaco di Correggio anche con i voti di alcuni
consiglieri democristiani, nonostante che all’epoca i contrasti fra
comunisti e democristiani fossero già accesi. Non mi meravigliai. La
gente pensa che la Resistenza sia stata soltanto un fatto d’armi. Ma
sbaglia. La Resistenza fu soprattutto uno scambio collaborativo con
il popolo. Le persone erano con noi perché noi ci siamo presi cura di
loro. Non abbiamo lasciato mai la nostra gente. E loro non ci hanno
mai abbandonato. Non mi hanno mai abbandonato.
Il 18 giugno 1946 davanti alla parrocchia di San Martino, a
Correggio, fu ammazzato a colpi di pistola il parroco, don Umberto
Pessina. Un delitto assurdo e odioso. I colpevoli, tre partigiani subito
fuggiti in Jugoslavia, quando seppero che per quel delitto ero stato
incriminato io, con Elio Ferretti e Antonio Prodi, si autoaccusarono
sostenendo che si era trattato di un incidente. Ma al vescovo di
Reggio Emilia, Beniamino Socche, non pareva vero di tirare in
mezzo il sindaco di Correggio. Per quel monsignore, acceso
anticomunista che proponeva addirittura la messa fuorilegge del Pci,
io ero il bersaglio ideale: un credente cattolico che si era messo con i
rossi. Sollecitò i carabinieri a costruire delle false testimonianze, fece
spostare il processo da Reggio Emilia a Perugia per legittima
suspicione, e alla fine ottenne la mia condanna. Il Pci reggiano
sapeva che ero innocente, ma non voleva esasperare lo scontro con
la Chiesa. Mi proposero di espatriare in Cecoslovacchia, del che mi
sentii ferito nell’onore. Rifiutai sdegnosamente. Così fui condannato
a ventidue anni di carcere e ne ho trascorsi dieci in cella, prima
dell’indulto. Solo nel 1994 sono stato assolto definitivamente e ho
ricevuto una telefonata di scuse dal presidente della Repubblica,
Francesco Cossiga. Tre anni dopo è arrivata anche la medaglia. Ma
quanta amarezza!
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :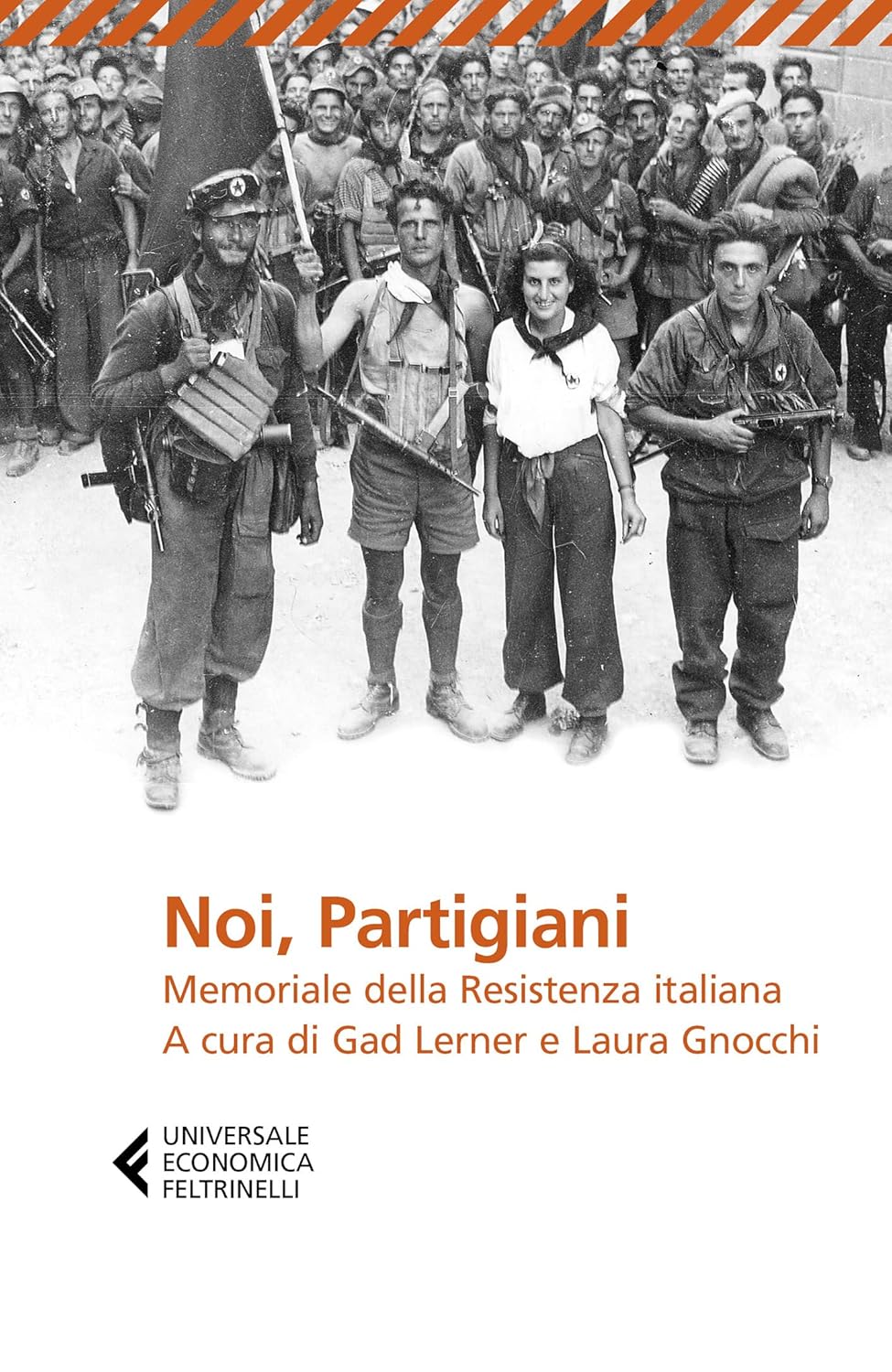






Commento all'articolo