New York 1941- Forse – Luca Giribone
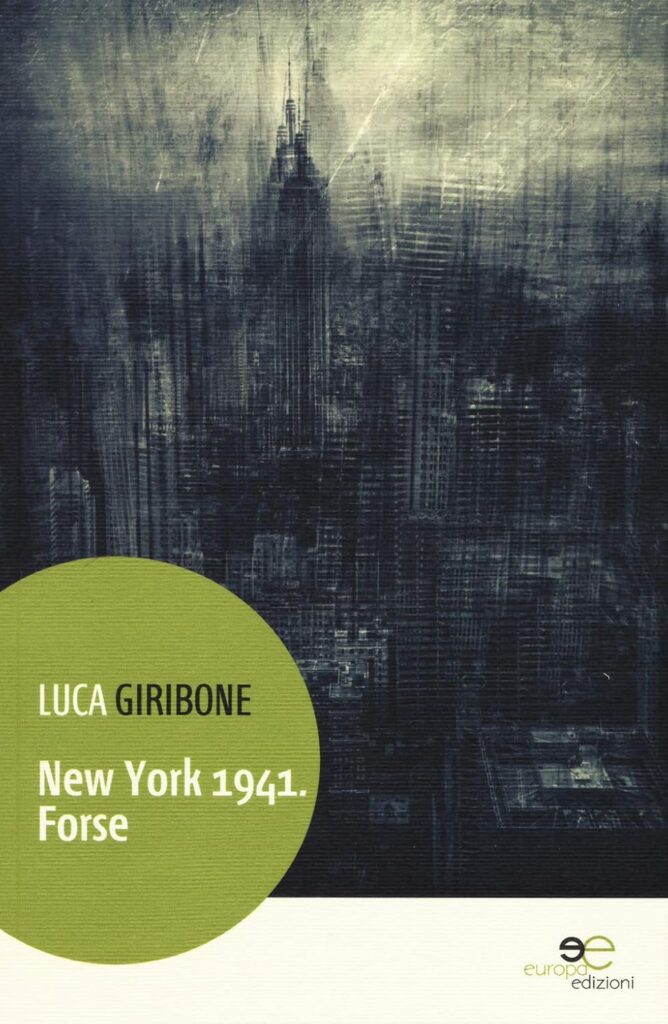
SINTESI DEL LIBRO:
Ma è una di quelle scene che ti scendono nei polmoni e ti
donano una calma indescrivibile, quella che può nascere solo dalle
situazioni in cui tutto dipende da un’altra persona. Una di quelle
poche persone di cui ti puoi davvero fidare.
Mio padre aveva uno sguardo dolcissimo, quando non aveva paura
di morire. Quel pomeriggio d’estate, a casa dei nonni, stava così
bene da monopolizzare i miei ricordi: non vedo altri che lui, il suo
sorriso privo di ombre, da uomo libero che gioca con suo figlio nel
prato dietro casa.
Ci sono individui che ci appaiono talmente familiari da farci rischiare
di dare per scontata la loro presenza, come fossero una legge fisica:
il grande amore, un fratello, una sorella, un genitore, il nostro
migliore amico. Esistono necessariamente.
Poi, senza motivo, un giorno ci fermiamo a pensare che questi
capisaldi del nostro vivere non sono un prolungamento di noi: loro
potevano anche non esistere. Ossia, nell’infinita serie di variabili
dell’esistente sarebbe stato per noi possibile nascere figli unici, o
venire generati da altre persone; non incontrare mai la donna della
nostra vita, crescere in un ambiente differente, frequentare
compagnie diverse.
Tutto questo provoca una sensazione di assoluto straniamento,
quasi di vertigine, come quando pensiamo all’eternità o all’infinito.
Mio padre, quel giorno d’estate a casa dei nonni, fu una scoperta
nuova. Bellissima.
E fu strano sognare di nuovo quell’episodio proprio quella notte,
ventiquattr’ore prima che Dio decidesse di uccidermi.
E COSÌ FRANK DECISE CHE ERA ORA DI ALZARSI…
… e di prepararsi un caffè, perché quella sarebbe stata una
giornata molto lunga. Se lo sentiva. Certe cose si avvertono con un
sesto senso viscerale, per niente scientifico e, a dirla tutta, il più
delle volte piuttosto inaffidabile, ma che protesta con un’energia tale
da non ammettere obiezioni; vuole essere creduto a tutti i costi.
E Frank gli credette.
Non che si aspettasse di trovare la soluzione al caso proprio quel
mattino, né quel giorno, forse nemmeno il giorno successivo: New
York non si scopre mai, mette in giro mille falsi allarmi, una Babele di
premonizioni che poi si rivelano quasi sempre un tradimento; ma non
puoi farci niente, è la città a tessere il filo delle sue tante esistenze. E
se non credi all’unico preavviso che ti bussa alla porta, se ti giri
dall’altra parte, puoi pagarla cara la tua disattenzione. New York sa
essere crudele. Sa colpire alle spalle.
Dopo tre mesi interamente dedicati all’indagine che gli aveva
divorato le ore, la vista, le notti e lo stomaco, Frank avrebbe offerto
alla Grande Mela un fianco totalmente scoperto. Semplicemente,
non ce la faceva più. Quel mattino si era svegliato deciso a mettere
ordine a tutto quanto era successo nell’ultimo periodo, un torrente
selvaggio di informazioni frammentarie, che piano piano si erano
gettate in un lago dalle acque scure, inquietanti, pericolose.
Ora guardava Dorothy abbandonata nel sonno, con quella sua
espressione incosciente di chi non teme nulla, e forse era vero, forse
sarebbe stata più coraggiosa di lui anche conoscendo ogni suo
segreto. Ma adesso sembrava solo così dolcemente infantile, forte
nelle sue certezze e insieme perfettamente inconsapevole.
Doveva dirglielo prima o poi, anzi, doveva dirglielo adesso, e lo
sapeva bene. Ma raccontarle la verità proprio ora gli sembrava
troppo ipocrita: aspettare con tutta quella rabbia dentro per
settimane, tacere per non metterla in pericolo e, infine, porla di fronte
al fatto compiuto solo perché aveva bisogno di lei, del suo aiuto.
Ipocrita. Sì. Tanto Dorothy l’aveva già letto nei suoi occhi, che questa
volta si trattava di qualcosa di grosso, la risposta al dilemma di
sempre: vale la pena di rischiare la vita per un articolo? E la risposta
era sempre la stessa. E lei lo odiava per questo, litigava con lui, lo
scaricava solo per poi riprenderlo il più presto possibile, prima che lui
facesse in tempo a cambiare. Non l’avrebbe mai voluto diverso,
come non sarebbe mai potuto essere, col rischio che cessasse di
essere se stesso. Dorothy amava il Frank Logan che conosceva,
nessun altro.
Il sole fece il suo ingresso nella stanza attraverso le tende sempre
aperte.
A Frank piaceva la luce. Odiava l’oscurità notturna, preferiva
svegliarsi all’alba, con le tapparelle spalancate, vedere la nascita e
l’inizio di tutto negandosi ore di sonno, piuttosto che guardarsi
intorno e sentirsi cieco.
Accese la grossa radio a valvole. Questa stentò un po’ a
risvegliarsi, gracchiò, brontolò, cominciò ad emettere suoni, Benny
Goodman. Ecco l’atmosfera. Il caffè era bollente, Frank attese
qualche minuto guardando fuori, il giallo rugginoso che accarezzava
i grattacieli sporcando la sua luce di quel po’ di vita che lo rendeva
unico.
Il sole di NewYork.
Eravamo agli inizi del millenovecentoquarantuno. Roosevelt era il
presidente. Il New Deal aveva funzionato, la Grande Depressione
era alle spalle, ma la guerra, che a Manhattan non sembrava così
vicina, straziava una parte molto estesa del pianeta. Gli Stati Uniti
cercavano senza risultati di convincere il Giappone ad abbandonare
l’alleanza con Germania e Italia. Nessuno avrebbe ancora potuto
immaginare Pearl Harbour, anche se in terre lontane il cielo era nero
di morte.
La musica era bella, erano gli anni dello swing, del cinema delle
grandi emozioni, drammatiche e romantiche, da Quarto Potere ai
film di Ginger e Fred, gli anni del ritorno della speranza.
Frank sembrava aver dimenticato la guerra, la sua missione non
era minimamente toccata da quanto succedeva nel mondo, il suo
mondo da tre mesi era circoscritto a New York, a una delle sue
abitudini più consolidate: la corruzione.
Per questo motivo, analizzando con cura gli eventi e soprattutto i
vaghi indizi che gli sfilavano intorno come il vapore che sfuggiva
lento dai tombini sconnessi della Quinta, aveva maturato una precisa
serie di convinzioni.
Primo. L’indagine stava colpendo nel segno.
Secondo. Frank si trovava a un passo dal più grande scoop della
sua carriera.
Terzo. I nomi coinvolti erano ingombranti.
Quarto. Come spesso capita in questi casi, qualcuno si stava
preparando a ucciderlo.
NON SUCCEDE A MOLTI DI MORIRE IN DUE MODI
DIFFERENTI
Io avrei scoperto come ci si sente. Non che la consapevolezza di
tutto questo fosse più definita del ricordo infantile che mi aveva
stupefatto la notte. È una vaga coscienza nel dormiveglia a parlare
ora.
Quella che a volte ci infastidisce, quasi ci spaventa, nello svegliarci
di colpo da un sonno profondo, avendo sentore di essere desti,
senza riuscire a trasferire gli impulsi ai muscoli. Una disturbante
manciata di secondi in cui il nostro cervello è vigile ma il corpo è
ancora addormentato, e serve uno sforzo apparentemente superiore
alle nostre possibilità per muoverci. Di fatto si è pensanti ma
paralizzati. Poi la volontà vince, con grande fatica mettiamo in
azione un braccio, e il resto segue.
Ma nella dimensione di questa vaga consapevolezza della mia
doppia morte, quando muovo il braccio sono già altrove.
Scivolo in un passato che la mia quotidianità cerca da anni di
infilare sotto il tappeto come fosse polvere.
Ritorno a casa, una casa distante e quasi dimenticata.
Un bambino di sei o sette anni ha un solo eroe, grande e
insuperabile mito del proprio immaginario.
Suo padre.
Tutto quello che lo circonda diviene una straordinaria avventura
nella sua testa, e qualunque subdolo pericolo entri in gioco, non può
che finire bene, come una partita di carte, come un romanzo di cui si
conosca già il lieto fine.
Io mi immaginavo gli appostamenti, quelle lunghe notti
maleodoranti di cibo stantio, dopo le tante ore trascorse a macerare,
cena e persone, in un’auto scomoda e angusta con i sedili in pelle
scadente, lo sguardo che si offuscava ora dopo ora, nell’attesa che
avvenisse quel qualcosa che avrebbe dato un senso alla serata: “li
abbiamo beccati”.
Certo, dal punto di vista di un adulto sembra una forma di lenta
tortura. Ma per un bambino tutto questo era il brivido dell’imprevisto
e dell’avventura, e mai che temessi, mai che dubitassi, mai che mi
sfiorasse davvero quel tremore sottile che attraversava le labbra di
mia madre ogni volta che lui usciva di casa. Il tremore che diceva
che sarebbe potuta essere l’ultima volta (ogni dannata volta).
Nemmeno condividevo lo sguardo terrorizzato di mia sorella che
ascoltava la radio per avere notizie in anteprima se ve ne fossero
state.
Stupida ragazza, questa è l’età fatta per idealizzare, e questo è il
Proibizionismo, è l’era dei gangster. Goditela!
I miei appostamenti immaginari erano sempre eccitanti ed eroici.
Da quando il Proibizionismo aveva preso piede, la città era
diventata un termitaio all’interno del quale si nascondevano infinite
gallerie che conducevano a insospettabili speakeasy, in cui si
distillava qualunque cosa, veleno allo stato puro; la qualità non
fiorisce mai dal contrabbando, ma che importa, si moriva di
pallottole, di rappresaglie, di paura. Finire i propri giorni avvelenati
da whisky scadente era davvero il meno.
Mia madre da parte sua si spegneva lentamente. Cominciò a farlo
quando intuì la direzione che stavano prendendo le lunghe giornate
e le infinite notti trascorse da mio padre con la divisa di ordinanza
addosso, a fare il suo dovere, a registrare successi e insuccessi
insieme alla squadra, quella stessa che per un certo periodo affiancò
nientemeno che gli uomini di Eliot Ness.
Non so quanto mio padre e Ness parlassero, di sicuro li
accomunavano la ferrea dedizione al lavoro e la fragilità umana.
Ness morì alcolista dopo una serie di fallimenti legati più ai serial
killer che ai gangster: Capone, sì, lo mise al gabbio, e mio padre non
partecipò alla festa, aveva già cominciato a bere e aveva perso di
vista la prima linea. Lo faceva per darsi la forza di affrontare il
nemico che smerciava la morte liquida con la quale lui stesso si
stordiva. Beveva di notte, o la mattina presto, per anestetizzarsi
abbastanza da trovare l’energia per attraver¬sare la giornata, poi si
riempiva di mentine, ma chissà quanti colleghi intuivano...
Avrebbe potuto lavorarci sopra, mordere il freno, si era però in
guerra, e la guerra richiedeva energia, convinzione, furia cieca, e più
mio padre si perdeva nel privato, più diventava sul lavoro un
incrollabile maglio che affondava i suoi colpi potenti, vibranti, nella
muraglia eretta da Capone, da Luciano e dagli altri gangster contro il
mondo del perbenismo americano che stava in superficie (salvo poi
fare qualche capatina nel sottosuolo non appena finito di
pronunciare parole cariche di spirito moralizzatore). Accadeva
mentre il sesso, la droga, l’alcool, la perdizione, l’abbandono
annegavano nei locali fumosi, quelli della parola d’ordine.
Anno dopo anno mio padre divenne un’ombra minacciosa a casa,
picchiava mia madre regolarmente, ignorava mia sorella e me, poi si
rifugiava a letto. Non usciva mai, se non per lavorare e per
procurarsi le bottiglie da qualche contrabbandiere di fiducia che
evitava accuratamente di perseguire (il secondo e ultimo peccato
professionale che commise, dopo la dipendenza dal whisky).
Continuava ad alzarsi presto, nonostante tutto abbastanza lucido,
mentre io cercavo un senso a tutto questo. Avevo gli amici, e con
loro cercavo di capire cosa stesse succedendo nel mondo. Fu
questo a salvarmi, il voler capire, il tarlo che rimase eterno in me e
mi portò per mano fino al giornalismo.
Io sì che uscivo, stavo sempre fuori, sapevo quali compagnie
evitare, ma conoscevo tutti, e tutti conoscevano me, figlio di un
poliziotto che stava nel limbo e che non aveva ancora scelto da che
parte cadere.
La scelta fu più facile per mia sorella. Aveva il guizzo, la fiamma, la
vita, che dal basso ventre le attraversava il corpo, e saliva su, fino
alle espressioni ammiccanti di un viso angelico e demoniaco. Non ci
volle molto prima che tutte le porte dei locali proibiti si spalancassero
davanti a lei, prima che il suo ballo diventasse garanzia di non dover
mai pagare una sola consumazione, prima che cominciasse a
passare di letto in letto fino a quelli dei temuti scagnozzi di lusso,
quelli che stavano appena sotto i grandi capi, e poco mancò che non
finisse anche con questi.
La salvò, se così si può dire, un siciliano che lavorava per Lucky
Luciano e che le chiese di scoprire insieme a lui le meraviglie della
sua terra di origine, dove il grande capo lo stava rimandando per
governare il vivaio che brulicava in madrepatria, quello da cui
spuntavano fuori le nuove promesse destinate a ingrossare le fila
dell’esercito del Nuovo Mondo. Non se ne seppe più nulla.
Scrisse solo lettere.
Scrisse a mia madre.
No, un momento, venne anche a trovarci. Io non ricordo bene. Che
cosa strana, non riesco a ricordarne il volto, la cancellai, uscì di
scena, io la feci sparire dalla mia mente… chissà che fine ha fatto...
lei non è più...
Eppure io sapevo, una volta. Ricordavo se mai tornò in America o
meno. Ora no, ora non ricordo...
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :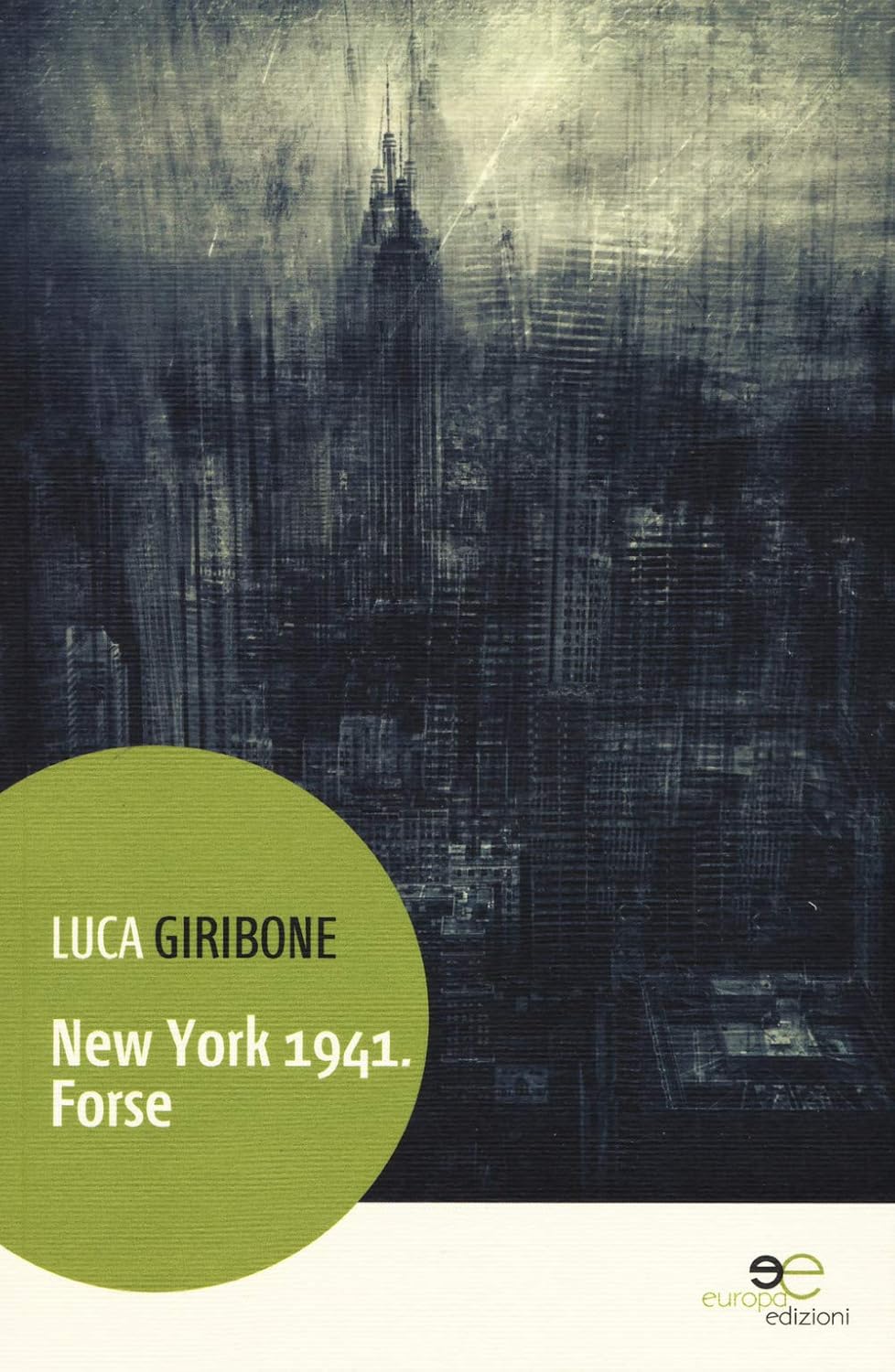






Commento all'articolo