Nexus – Henry Miller
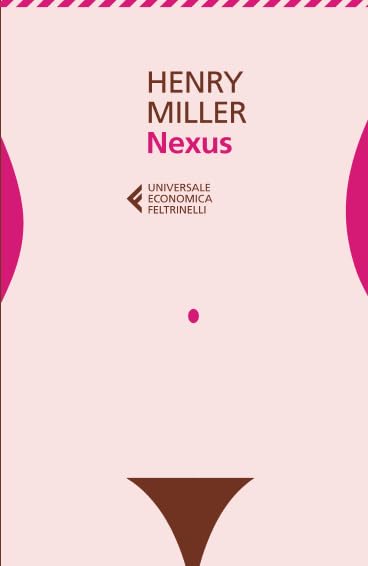
SINTESI DEL LIBRO:
Terzo e conclusivo volume della
trilogia The Rosy Crucifixion (con
Sexus e Plexsus), Nexus (1960) è la
rievocazione in prima persona della
vita dell’autore negli anni tra il 1927
e il 1930: i tentativi di trovarsi
un’occupazione, i difficili rapporti
con la moglie, la decisione di
abbandonare l’America.
Sono pagine piene di straripante
energia, di inalterabile entusiasmo, e
ogni riga è scritta come se il
presente fosse l’ultimo momento di
vita. Nessun indugio, nessun
ripensamento, un fantastico tentativo
di dare alla pagina il tempo di
un’esistenza senza tregua e senza
vuoti.
Henry Miller.
Nexus.
Traduzione di Adriana
Pellegrini, Introduzione di Eraldo
Affinati Arnoldo Mondadori Editore
© 1961 Longanesi & C, Milano
Titolo originale dell’opera
Nexus
© 1983 Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A., Milano
per l’introduzione
I edizione Oscar Scrittori del
Novecento aprile 1993 Edizione su
licenza ISBN 88-04-45435-0
Questo volume è stato stampato
presso Arnoldo Mondadori Editore
S.p.A. Stabilimento Nuova Stampa -
Cles (TN) Stampato in Italia -
Printed in Italy Ristampe:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1999 2000 2001 2002 2003
Il nostro indirizzo internet è:
http://www.mondadori.com/libri
Introduzione
C’è una leggerezza in Henry
Miller - la grazia dopo il pieno
vitale: e sono quelli i suoi momenti
migliori. Egli tende sempre
all’estenuazione. Nexus (1960),
terzo conclusivo tomo della trilogia
The Rosy Crucifixion, è il punto in
cui tale estenuazione si compie.
Quanti ragazzi fino a venti,
trent’anni fa avrebbero voluto essere
come lui? Tanti, in ogni
schieramento, a destra e, noi
crediamo, anche a sinistra. Ma
quanti vorrebbero esserlo oggi?
Quanti adolescenti sarebbero pronti
a scommettere tutto pur di realizzare
se stessi?
Stiamo parlando di un uomo
nato nel 1891, cresciuto insieme al
primo grattacielo di New York. Un
uomo troppo vecchio per combattere
le due grandi guerre del secolo:
aveva già venticinque anni durante
la prima e quarantotto allo scoppio
della seconda. E poi, anche se
avesse avuto l’età giusta, avrebbe
ugualmente strappato mostrine e
stellette. Nel 1936 George Orwell, di
passaggio a Parigi, gli comunicò la
sua decisione di partecipare alla
guerra civile spagnola. Henry Miller
rispose che lo considerava un gesto
idiota, soprattutto se chi ci andava lo
faceva per un senso di
responsabilità. Pacifista anarchico,
vitalista sereno, egli non permetteva
a nessuno di scaraventarlo nella
trottola impazzita della Storia,
eppure non fu un aristocratico, in
nessun senso; amò semmai la
compagnia di uomini semplici; alla
cultura accademica preferì i romanzi
che scopriva da solo e (perché no?)
il ciclismo e il pugilato.
Non dobbiamo dimenticare che
si tratta del padre putativo del
viaggio coast-to-coast e quindi di
Jack Kerouac e dei beats (nella
doppia accezione precisata da Mario
Praz: “beati” e “battuti”), del
Greenwich Village e di una certa
California oceanica infatuata di Zen
e dottrine orientali (un pittore come
Mark Tobey, quasi suo coetaneo,
può costituire l’esempio indicativo).
Assolutamente non degli hippies,
con i quali non voleva avere niente a
che spartire.
Insomma Henry Miller,
seguendo le coordinate istituzionali,
sarebbe uno dei capitani di questo
secolo selvaggio e scapigliato. Tale
fin troppo consolidata affermazione
critica, secondo la nostra opinione,
va presa con le molle. L’immagine
iniziale che si ha di lui è infatti
sempre quella sbagliata. A prima
vista egli sembra un maudit, e lo è
solo in minima parte. Oppure un
deraciné, e non è vero (basta pensare
al peso che hanno le sue radici
teutoniche). Oppure ancora un
immprale, o un amorale, e questo è
proprio falso. Chi lo conosce bene,
coglie d’acchito il senso armonico
che dalla sua opera fortemente
promana. Tutto ciò che sa di origine
e di matrice suscita in Miller un
profondo interesse. Ma attenzione:
in Grecia egli trova la passione, la
generosità. Non vi trova l’antichità,
né la semplice cultura: come tutti i
grandi diari di viaggio, Il colosso di
Maroussi (1941) dimostra che il
luogo visitato ha un’importanza
accidentale, funziona soltanto nel
riscontro interiore, altrimenti è
lettera morta.
Prendiamo il libro che più di
ogni altro ha favorito l’equivoco di
un Miller tutto in nero,
spavaldamente edonista e
spegiudicato: Sexus (1949). E’ una
bomba espressiva che precipita sulle
macerie provocate dai due
precedenti Tropici.
Che senso può avere assaltare
una postazione abbandonata, ridotta
al silenzio? Interpretare questo testo
come una trasgressione sperimentale
significa tradirlo. Sono centinaia di
pagine di pura anamnesi, composte,
tanti anni dopo la crisi, dal paziente
risanato. Gli atti sessuali hanno una
gestualità figurata e vengono
descritti con immagini fisse,
stereotipate. Non assistiamo a
nessuna vera perversione; è una
tecnica, una scultura vivente.
Neppure volendolo con tutte le
forze, Henry Miller avrebbe potuto
assomigliare al marchese di Sade.
Nel successivo Plexus (1952) lo
scrittore effettua una virata di
riflessione e speranza proseguendo
l’autobiografia mitizzata degli anni
americani (una Brooklyn in grigio
ferro di ponti e treni che resta incisa
per sempre nella memoria del
lettore): la desolazione esistenziale
che le copule plastificate di Sexus
appena dissimulavano emerge
adesso come un osso fratturato. Il
protagonista tenta di riorganizzarsi:
legge con avidità, prende appunti, si
licenzia dall’ufficio (nella realtà, la
Western Union Telegraph Co. fu per
Miller, secondo le sue stesse celebri
parole, ciò che rappresentò la
Siberia per Dostoevskij). Ma è
ancora troppo presto, la vita
continua a reclamare spazio. Il libro
termina con un’invocazione a
Nietzsche e Goethe, agli scrittori
russi.
Nexus (l’arte di fare dei nodi, a
detta dell’autore), ricomincia con un
grido bibliografico, una citazione
urlata dei libri che più hanno
contato, come se lo scrittore volesse
incendiare e far suo il corpo mistico
della letteratura. La trilogia,
tematicamente, si riassume in pochi
personaggi-chiave: il protagonista
autobiografico, l’amante Mona e la
moglie Maude. In Nexus compare
Stasia, uscita di manicomio. Viene
narrata una specie di squallida
bohème. Tutto qui. E allora, direte
voi, dov’è la grandezza di Henry
Miller?
Il ritmo. Il ritmo di battuta
continuo e spezzettato, insieme, che
nasconde il suo stesso effetto
sincopato; non lo esibisce (come
avviene nei Sotterranei di Kerouac,
ad esempio); lo assorbe
conservandone la pulsione di fondo.
Tutta la scarica elettrica vitale si
neutralizza in un’estrema fluidità
stilistica. Eppure Miller non è affatto
uno scrittore da un colpo solo,
distillato, scientifico: come un
presbite, esercita piuttosto
un’attenzione strutturale e, nella
propria opera, vede meglio gli
oggetti posti a grande distanza che
quelli più vicini. Mette
l’individualismo anarchico (esistono
libri archetipo: L’unico e la sua
proprietà di Max Stirner fu il suo) al
servizio del benessere, della
prosperità fisica e psicologica
ch’egli persegue. È uno scrittore
organico. Ecco perché sull’America
ha detto le parole più giuste: «
L’America è piena di posti. Posti
vuoti. E tutti questi posti vuoti sono
affollati. Gremiti d’anime vuote »
leggiamo, ad esempio, nella
straordinaria prefazione a Ricordati
di ricordare del 1947, e sembra quasi
che ci stiano passando sotto gli
occhi i quadri di Edward Hopper.
L’America è come lui era: una
malata di sanità.
Henry Miller ha uno sguardo
totale. Sa parlare di tutto,
conservando nello scrigno la sua
consapevolezza del niente. Quanti
scrittori avrebbero voluto comporre
un libro di saggi come Max e i
fagociti bianchi (1938)? Egli ha
dimostrato che si può attraversare la
letteratura soltanto con il corpo. E,
sia detto per inciso, non c’è nessuno
meno naif di lui. Si schiera contro
Joyce e contro Proust (il gesto
antinovecentesco per eccellenza), in
quanto gli appaiono troppo mentali:
« La mente agisce come un
macchinario e non come forza
generatrice ».
Lo scrittore speculare di Henry
Miller, quello che può aiutarci a
capirlo, è Paul Léautaud. Entrambi
sono tesi a fare della letteratura un
sismografo della vita, ma il francese
si attacca alla pelle come un tafano
per succhiarla, è lui il vero vizioso;
l’americano la rielabora mìticamente
e, con tutta la vicinanza al
quotidiano ch’egli pretende di avere,
sentenzia sempre, liricamente, una
distanza stilistica dalla sua materia:
risultato davvero paradossale in un
secolo di profittatori e bari
dell’esperienza come è stato il
nostro.
Chi ritiene che Henry Miller ci
abbia lasciato, insieme a libri buoni,
anche tante cose inutili, dice la
verità, ma nel complesso sbaglia.
Dice la verità perché non si può
negare la natura predicatoria e
ripetitiva dello scrittore, ma sbaglia
in quanto i suoi libri, belli o brutti,
necessari o ininfluenti, ci
trasmettono, più che una qualità
estetica, un’energia. «Il messaggio
del clown » scrisse in II sorriso ai
piedi della scala (1948) «è quello
che dobbiamo confonderci nel
fiume, nello scorrere della vita,
fluire in acqua. » Queste sono anche
le quattro frasi che Henry Miller ha
idealmente rinchiuso dentro la
bottiglia prima di gettarla a mare.
Tale orientamento eracliteo, che
spiega il senso profondo della
fluidità stilistica a cui prima
abbiamo avuto modo di accennare,
fu magnificamente siglato da
Norman Mailer quando paragonò
Hemingway a un accampamento che
ogni sera si alza di fronte alle rapide
e Miller al fiume sottostante.
«Tutta questa maledetta fatica di
continuare a scrivere libri su libri,
righe su righe, a cosa si riduce poi?
», domanda lo scrittore in La mia
vita come un’eco (1961), «A una
passeggiata per il parco, a qualche
scappellata, a un “Buondì, Tom,
come la va?”, “Bene, e tu?”. Ma non
fa né più saggio, né più triste, né più
felice nessuno. C’est un travail du
chapeau, voilà tout!” Detto da uno
dei più prolifici autori della nostra
epoca, è una dichiarazione che
produce un certo effetto. Ma
leggiamo ancora: «Le parole, come
tutti gli altri rifiuti, finiranno per
essere trascinate via nell’acqua del
rigagnolo. Gli atti, invece, restano.
Gli Atti degli Apostoli, bien
entendu, non quell’attivismo da
formiche che oggi passa per azione
».
E nel Tempo degli Assassini
(1956), il libro su Rimbaud: «
Soffocate o deformate i sogni della
giovinezza e distruggerete il
creatore». Henry Miller, da vero
scrittore senile quale a tutti gli effetti
fu, non ha fatto altro che insegnare
la Giovinezza. Nella sua materia, è
l’insegnante più imprevedibile che
abbiamo mai avuto. Non ci dice mai
di no: ci lascia completamente liberi,
ci consente di fare tutto. Ma qualche
anno dopo, uscendo dalla sua scuola,
comprendiamo che il sì da lui
indicato era più difficile da
realizzare, più rigido, imperioso ed
esigente di ogni possibile no.
Il Miller che troviamo in Nexus
è nel fondo del pozzo, ma, a
differenza del Celine al quale la
critica lo ha frettolosamente
paragonato, non ci sta bene, si
prepara invece alla risalita.
Abbandonato da Mona (« la sola,
l’unica, Uno, monogamia » dichiarò
a Christian de Bartillat per illustrare
questo nome) che se n’è andata a
Parigi con la sua amica, egli torna
nella vecchia casa dei genitori a
scribacchiare. Cerca lavoro. Viene
assunto come becchino e apprende
così «un nuovo punto di vista sulla
morte»
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo