La morte della verità – Michiko Kakutani

SINTESI DEL LIBRO:
Nel discorso che tenne al suo liceo nel 1838, il giovane Abraham Lincoln
espresse la preoccupazione che, man mano che i ricordi della Rivoluzione si
allontanavano nel tempo, la libertà della nazione fosse minacciata dal
disprezzo per le istituzioni che difendono le libertà civili e religiose ereditate
dai fondatori. Per preservare lo stato di diritto e prevenire l’ascesa di un
aspirante tiranno che poteva «spuntare fra di noi», era necessaria la sobria
ragione: «la fredda, calcolatrice, impassibile ragione». Per rimanere «liberi
fino in fondo», esortava Lincoln, il popolo americano doveva abbracciare la
ragione, insieme a «una solida moralità e in particolare a una reverenza nei
confronti della costituzione e delle leggi».
2
Come Lincoln sapeva bene, i padri fondatori dell’America basarono la
giovane repubblica sui valori illuministici di ragione, libertà, progresso e
tolleranza religiosa. E l’architettura costituzionale che elaborarono poggiava
su un sistema razionale di pesi e contrappesi per evitare la possibilità, come
disse Alexander Hamilton, che un giorno sorgesse «un uomo senza principi
nella vita privata» e «di temperamento ardito», capace di «cavalcare la
popolarità» e «lusingare e cedere a tutte le assurdità dei fanatici del
momento» per mettere in imbarazzo il governo e «confondere le cose per
poter “cavalcare la tempesta e dirigere il turbine”».
3
Il sistema era tutt’altro che perfetto, ma dura da più di due secoli grazie
alla sua capacità di resistere e di accettare cambiamenti essenziali. Leader
come Lincoln, Martin Luther King e Barack Obama consideravano l’America
un work in progress, un paese in corso di autoperfezionamento. E hanno
tentato di accelerare questo processo, consapevoli, come diceva il dottor
King, che «il progresso non è né automatico né inevitabile»,
4 ma esige
impegno continuo e lotta. I risultati raggiunti dopo la Guerra Civile e il
movimento per i diritti civili ci ricordano quanto c’è ancora da fare, ma
giustificano anche la fiducia del presidente Obama nel fatto che «noi
americani possiamo continuamente reinventarci per adeguarci ai nostri sogni
più grandi»
5 e la fede illuministica in quello che George Washington
chiamava il grande «esperimento affidato alle mani del popolo americano».
6
Accanto a questa visione ottimistica dell’America come di una nazione
che poteva diventare una scintillante «città in cima a una collina», c’è stato
nella storia USA anche un controcanto oscuro, irrazionale, che oggi si è
riaffermato in modo vendicativo, al punto che la ragione non solo viene
minata, ma sembra essere stata buttata fuori dalla finestra, insieme ai fatti,
alla discussione informata e ai processi decisionali della politica. La scienza è
sotto attacco, e così ogni forma di competenza, nella politica estera, nella
sicurezza nazionale, nell’economia o nell’istruzione.
Philip Roth ha chiamato questa contronarrazione «l’innata rabbia cieca
dell’America»
7 e lo storico Richard Hofstadter l’ha notoriamente descritta
come «lo stile paranoico»: un atteggiamento animato da «accesa
esagerazione, sospetto e fantasia complottistica»
8 e concentrato sulle minacce
percepite a «una nazione, una cultura, uno stile di vita».
9
Il saggio di
Hofstadter, del 1964, fu provocato dalla campagna di Barry Goldwater e dal
movimento di destra che l’accompagnò, così come il suo libro del 1963,
Società e intellettuali in America, venne concepito in risposta alla famigerata
caccia alle streghe del senatore Joseph McCarthy e più in generale al contesto
politico e sociale degli anni Cinquanta.
Goldwater perse la sua corsa alla presidenza e il maccartismo si esaurì
quando un avvocato dell’esercito, Joseph Welch, ebbe il coraggio di
affrontare McCarthy: «Non ha alcun senso della decenza, signore,
insomma?» gli chiese. «Non le è rimasto nessun senso della decenza?»
10
Il perfido McCarthy, che lanciava accuse di slealtà a tutta Washington
(«Il dipartimento di Stato è un nido di comunisti e di simpatizzanti del
comunismo» riferì al presidente Truman nel 1950),
11
fu censurato dal Senato
nel 1954; e con il lancio dello Sputnik sovietico nel 1957 il minaccioso
antirazionalismo dell’epoca cominciò a recedere, lasciando il posto alla corsa
allo spazio e a uno sforzo concertato per migliorare i programmi scientifici
del paese.
I VARI FORMATI :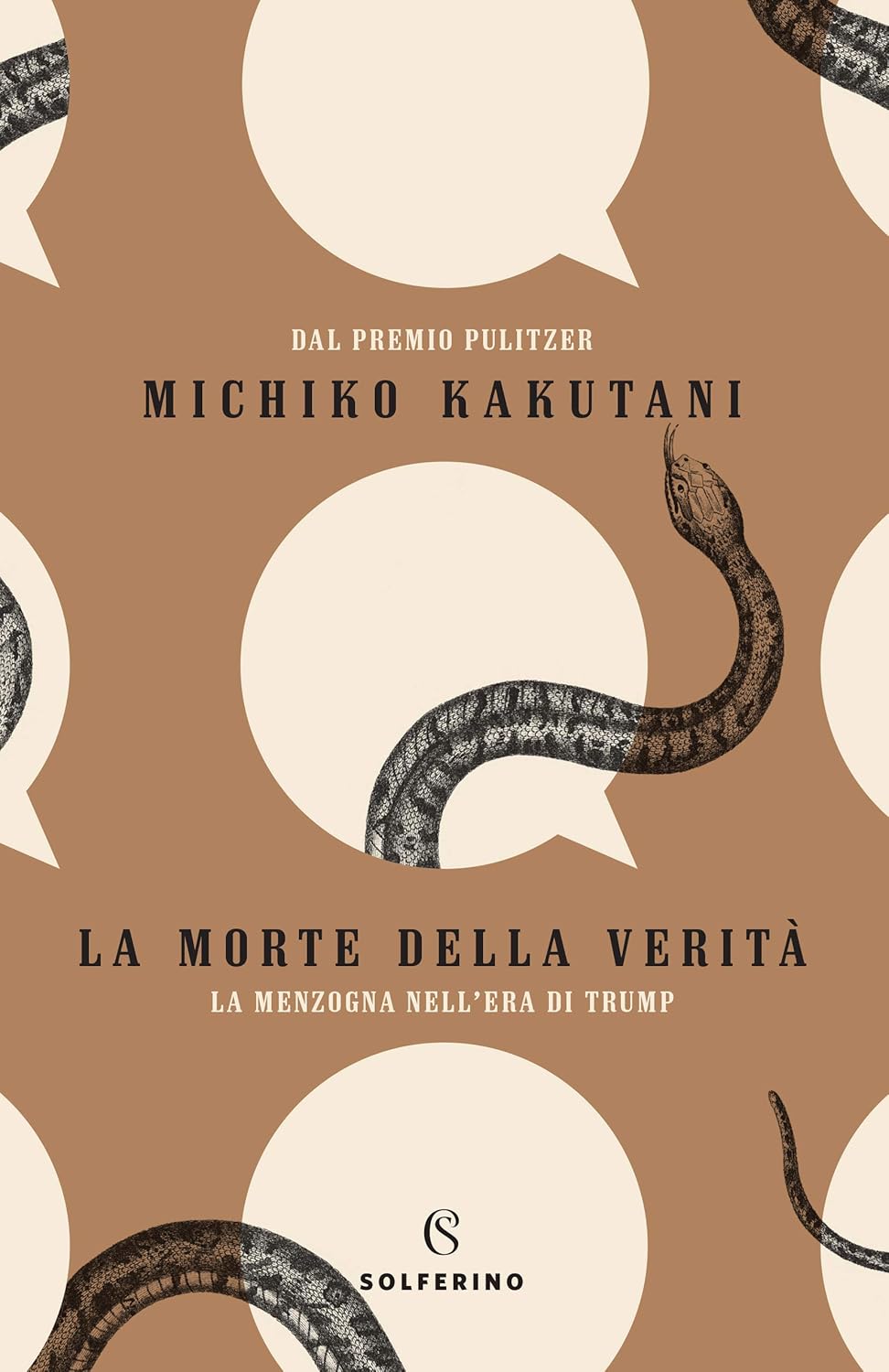






Commento all'articolo