Minima politica – Sei lezioni di democrazia – Gianfranco Pasquino
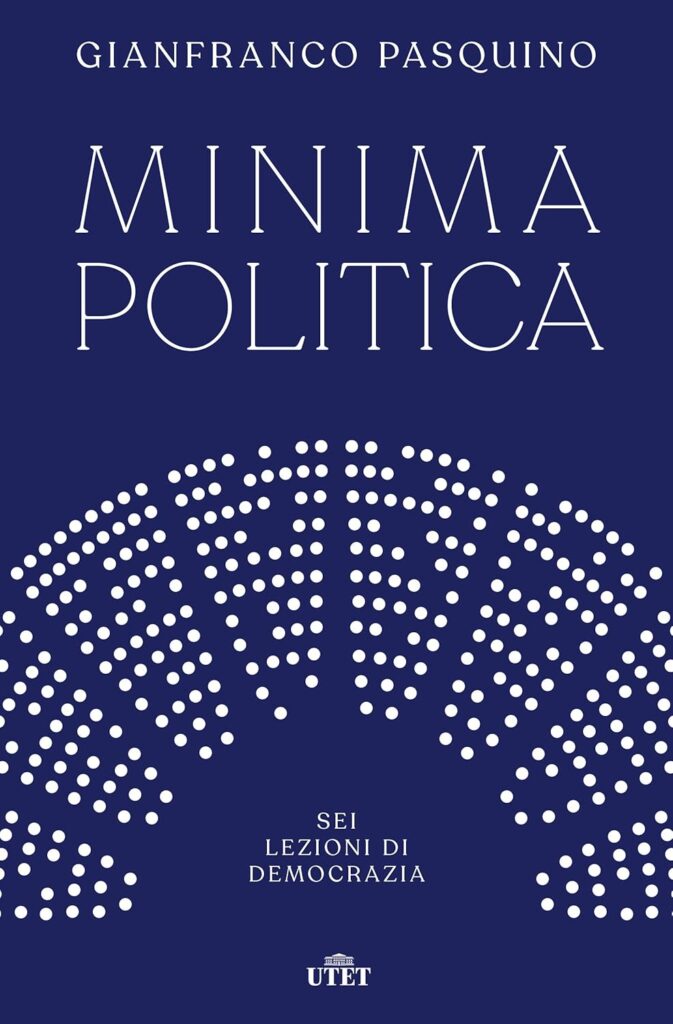
SINTESI DEL LIBRO:
Più di trent’anni fa proposi di classificare le riforme istituzionali in
“partigiane” e “sistemiche” (Pasquino 1982). Le prime perseguono
obiettivi particolaristici di vantaggi voluti da leader, partiti, coalizioni.
Le seconde riguardano il funzionamento del sistema politico. Mi pare
che questa distinzione sia utilizzabile anche, forse persino di più,
nell’ambito delle riforme elettorali (per un’ampia panoramica si veda
Regalia 2015). Non ci sono dubbi che la legge Acerbo (1923) fu
congegnata deliberatamente ed esclusivamente per favorire il Partito
nazionale fascista e i suoi possibili alleati consegnando loro una
maggioranza cospicua gonfiata dal premio in seggi alla Camera dei
deputati. Aggiungo subito che qualsiasi paragone di leggi elettorali
successive con la legge Acerbo deve essere effettuato con grande
cautela tenendo conto che l’Italia di allora si trovava già in una
situazione autoritaria e che le elezioni del 1924 non furono
certamente né libere né competitive. In nessun modo, la legge
elettorale del 1953 nota come “legge truffa” può essere
legittimamente paragonata alla legge Acerbo (Piretti 2003;
Quagliariello 2003). Approvata da un parlamento democraticamente
eletto, quella legge attribuiva un premio in seggi a quell’insieme di
partiti che, avendo dichiarato di essere una coalizione, ottenessero
la maggioranza assoluta dei voti. Come ho avuto variamente modo
di evidenziare, quella legge era “truffa” per le sue eventuali
conseguenze. In una fase in cui la Democrazia cristiana praticava,
come scrisse opportunamente Piero Calamandrei, «l’ostruzionismo
di maggioranza», per non attuare la Costituzione (per esempio, per
non istituire la Corte costituzionale e non dare vita all’ordinamento
regionale), con i due terzi dei seggi in parlamento avrebbe potuto
insieme ai suoi alleati riformare la Costituzione rendendo impossibile
il ricorso al referendum oppositivo. La legge truffa non scattò perché
mancarono circa 54 000 voti ai partiti centristi per conseguire la
maggioranza assoluta. Non fu affatto, come Piretti intitola il suo libro,
«un fallimento dell’ingegneria politica». Fu la sconfitta di una
discutibilissima proposta elettorale e di una improvvisata strategia
politica.
Senza sottovalutare l’esistenza di una motivazione particolaristica,
ovvero, al tempo stesso, rafforzare i partiti centristi e rendere
irrilevanti i voti del crescente Movimento sociale italiano, nella legge
truffa è innegabile che vi fosse anche una motivazione sistemica di
importanza superiore: dare al paese un governo (centrista) stabile,
legittimato dal voto popolare. Non seguo coloro che hanno
variamente affermato che quest’obiettivo avrebbe avuto anche
un’importante conseguenza, vale a dire, incoraggiare/obbligare
socialisti e comunisti a formare un polo alternativo incanalando la
competizione politica in direzione bipolare. Il bipolarismo elettorale si
era già avuto nel 1948. Dopodiché, i socialisti stavano staccandosi
dai comunisti e non avrebbero voluto ripetere quell’esperienza
frontista e i comunisti erano tutto meno che pronti a traghettarsi in
un’alleanza “occidentale”, ma, soprattutto, il sistema partitico italiano
non stava affatto evolvendo in una direzione bipolare.
L’interpretazione di grande successo che ne diede Giorgio Galli, Il
bipartitismo imperfetto (1967) era, come avrebbe dimostrato
Giovanni Sartori (anzi, addirittura precedendo Galli, già nel 1966, poi
nel 1982), sbagliata. La dinamica del sistema partitico italiano era
multipolare e dava vita a un molto complesso caso di pluralismo
polarizzato. La sconfitta della legge truffa pose in stallo per quasi
trent’anni qualsiasi inclinazione e qualsiasi tentazione di riforma
elettorale.
Il tema riemerse quando, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta
del secolo scorso, Bettino Craxi, segretario del Partito socialista,
accusò il “bipolarismo” DC/PCI di essere il principale responsabile
dello stallo dell’intero sistema politico e fece intendere che una legge
elettorale diversa dalla proporzionale, probabilmente il doppio turno
francese che tanto aveva giovato ai socialisti di François Mitterrand,
sarebbe stato auspicabile anche in Italia. La motivazione di Craxi fu,
quindi, in parte derivante dal suo (legittimo) desiderio di acquisire
vantaggi per il Partito socialista italiano, ma in parte anche
dall’obiettivo di sbloccare il sistema politico migliorandone il
funzionamento. In una certa, largamente imprevista, misura, la
discussione sulla riforma elettorale approdò nella Commissione
bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dal deputato liberale
Aldo Bozzi (30 novembre 1983-1º febbraio 1985). Coerentemente
con tutta la storia della DC e con le sue convinzioni personali e
politiche, il capogruppo democristiano, mio caro collega universitario,
senatore Roberto Ruffilli, perorò senza scendere in particolari tecnici
soprattutto la causa di una legge elettorale che, accompagnata da
una “cultura della coalizione”, incoraggiasse la formazione e la
competizione tra coalizioni alternative e che attribuisse la carica di
presidente del Consiglio al leader del partito più votato della
coalizione vittoriosa.
Sono costretto, ma, ovviamente, lo faccio con grande piacere e
compiacimento personale e professionale, a ricordare qui la
proposta di legge elettorale che presentai in quella commissione il 4
luglio 1984, poi apparsa in un articolo sulla rivista “il Mulino” e,
ovviamente, pubblicata nella successiva Relazione di Minoranza
firmata dal senatore Eliseo Milani della Sinistra indipendente e da
me (ora in Pasquino 2014). Non intendo entrare nei particolari, ma
evidenziarne i punti salienti: sistema a doppio turno, per partiti o
coalizioni, con premio in seggi per chi vincesse al ballottaggio tra i
due contendenti più votati e premio di opposizione per il perdente.
L’obiettivo era totalmente e doppiamente sistemico: incoraggiare la
formazione di coalizioni preelettorali che consentissero all’elettore di
scegliere a ragion veduta tra le alternative che si fossero costruite;
attribuire all’elettore il voto decisivo al ballottaggio, da me ritenuto
essenziale; spingere verso una competizione bipolare che
contenesse in sé la possibilità di alternanza. Per la piccola, ma non
del tutto insignificante, storia delle proposte di riforma delle leggi
elettorali credo sia opportuno aggiungere che l’onorevole Stefano
Rodotà corse a Botteghe Oscure a denunciare che qualcuno
attentava alla proporzionale e che il neoeletto segretario del PCI
Alessandro Natta mi disse: «Sono proporzionalista, ma tu vai avanti
con la tua proposta».
La commissione Bozzi chiuse le sue attività il 1º febbraio 1985 con
l’approvazione di un ordine del giorno nel quale indicava il sistema
elettorale tedesco come il miglior punto d’approdo di un’eventuale
riforma. L’ordine del giorno fu firmato da Roberto Ruffilli (DC),
Augusto Barbera (PCI), Gino Giugni (PSI), dai democristiani Nino
Andreatta, Mario Segni, Pietro Scoppola. Su pressione amichevole
di Ruffilli e Barbera, lo firmai anch’io facendo mettere a verbale che
consideravo il sistema tedesco il second best dopo la mia articolata
proposta.1 Chiunque avrà interesse a leggerla troverà in quanto
scrissi nel 1984 molte anticipazioni di proposte successive comparse
nel dibattito pubblico in occasione della formulazione del testo
divenuto noto come Italicum. Posso soltanto ipotizzare che l’assenza
di riferimenti, a opera di colleghi che si sono buttati a capofitto
nell’argomento in tempi recenti, a quanto da me scritto che, a suo
tempo, fu discusso su tutta la stampa comunista: da “l’Unità” a
“Rinascita”, da “Democrazia e diritto” a “Critica marxista”, ma anche
sulla stampa “borghese” a cominciare da “la Repubblica”, sia
prevalentemente dovuta, non soltanto a invidia professionale, ma a
semplice, seppur grave e a ogni buon conto assolutamente non
giustificabile per chi si occupa del tema, ignoranza.
Non posso esimermi dal ricordare come le tematiche sia della
rappresentanza sia della governabilità fossero dibattute anche nella
commissione Bozzi. Quanto alla rappresentanza, nessuno dei
componenti della commissione pensò che la si dovesse sacrificare
alla governabilità. Anzi, la difesa da parte di molti di una legge
elettorale di “rappresentanza” proporzionale, non necessariamente
quella allora vigente (che, indubbiamente, poteva essere migliorata
in alcune clausole), si spiega proprio con la preoccupazione di non
ridimensionare la rappresentanza politico-parlamentare di una
società che si stava mobilitando e diversificando. Il dibattito sulla
governabilità, che nessuno neanche per un momento ritenne che
fosse migliorabile più o meno automaticamente restringendo la
rappresentanza, fu, però, fortemente distorto dall’impostazione
formulata dai socialisti in commissione (e fuori) per i quali
governabilità significava quasi essenzialmente attribuire al governo e
al suo capo (in quella fase il segretario del Partito socialista, Bettino
Craxi, che cumulava i due ruoli e le due cariche) maggiore potere
decisionale (Pasquino 1985).
La convulsa fase successiva culminò in due referendum elettorali,
quello sulla preferenza unica (9 giugno 1991) e quello sul sistema
elettorale del Senato (18 aprile 1993). Sembrano molto lontani, ma
furono cruciali anche e soprattutto perché le loro motivazioni di fondo
erano chiaramente e fortemente sistemiche. Infatti, la richiesta di
riformare la vigente legge elettorale proporzionale nasceva non da
un partito e non da uno schieramento che si ponessero come
obiettivo quello di puntellare o di aumentare il loro potere politico/di
governo, ma da una diversificata aggregazione di parlamentari e di
esponenti della società civile che sentivano che in Italia la
proporzionale era diventata un ostacolo al recepimento di
cambiamenti sociopolitici necessari che il pentapartito osteggiava e
bloccava. In sostanza, seppure declinandole con modalità diverse, i
fautori di una riforma della proporzionale volevano creare le
condizioni elettorali per conseguire – userò la terminologia di Aldo
Moro alla quale Ruffilli era particolarmente affezionato – una
democrazia compiuta. Quella democrazia, variamente interpretata,
avrebbe dovuto incoraggiare e garantire maggiore competitività tra
partiti e schieramenti, avrebbe prodotto competizione bipolare e
avrebbe reso possibile l’alternanza al governo.2 Non c’è nessun
dubbio che tutti questi obiettivi sono effettivamente sistemici, vale a
dire che riguardano la possibilità di dare vita a un sistema politico
che, invece di essere bloccato al centro – esito, peraltro, non
attribuibile unicamente alla ripartizione proporzionale dei seggi –
offra la possibilità di alternanza.
Troppo affannati a criticare la sentenza sull’Italicum del gennaio
2017, i giuristi italiani e alcuni politologi non si sono curati di
rintracciare le premesse delle non poche precedenti sentenze in
materia elettorale della Corte costituzionale, in modo speciale quella
del 2011 sulla reviviscenza o meno della legge Mattarella in seguito
all’eventuale abrogazione totale della legge Calderoli (si veda,
invece, l’accurata ricostruzione di Fernández Esquer 2019). Fatto sta
che nel 1991 la Corte ammise il quesito che appariva meno
dirompente, ovvero quello relativo alla riduzione del numero di
preferenze nella disponibilità degli elettori da tre/quattro a una
soltanto con l’obbligo di scrivere almeno il cognome del candidato/a.
L’intenzione esplicita dei promotori del referendum era duplice: (I)
una sola preferenza avrebbe spezzato e reso impossibili le cordate
tra candidati, prodromi e conseguenze della formazione di correnti
nei partiti; (II) la scrittura del cognome del candidato/a prescelto/a
rendeva più difficili, se non molto improbabili, i brogli derivanti dalla
possibilità di scrivere (aggiungere e manipolare) il numero di lista dei
candidati, soprattutto a opera di scrutatori conniventi e impuniti,
come era successo clamorosamente nella circoscrizione NapoliCaserta nelle elezioni legislative del 1987. Tuttavia, con un facile e
voluto slittamento propagandistico, la campagna elettorale fu
impostata dai referendari suggerendo che, finalmente, l’elettorato
avrebbe davvero potuto scegliere, contro il volere/strapotere dei capi
dei partiti, il suo rappresentante parlamentare come avviene laddove
si utilizza un sistema elettorale maggioritario in collegi uninominali.
A fronte dei molti difensori delle liste bloccate, mi pare opportuno
ricordare che, primo, in una certa misura il voto di preferenza,
tutt’altro che una anomalia italiana (si veda la tabella 1), si configura
come una briciola di potere nelle mani dell’elettore; secondo, le
uniche elezioni svoltesi con la preferenza unica non furono
caratterizzate da speciali fenomeni di voto di scambio e di
corruzione; terzo, l’affluenza a quel referendum segnalò che milioni
di italiani ritenevano opportuno avere il potere di scegliere tra le
diverse candidature.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :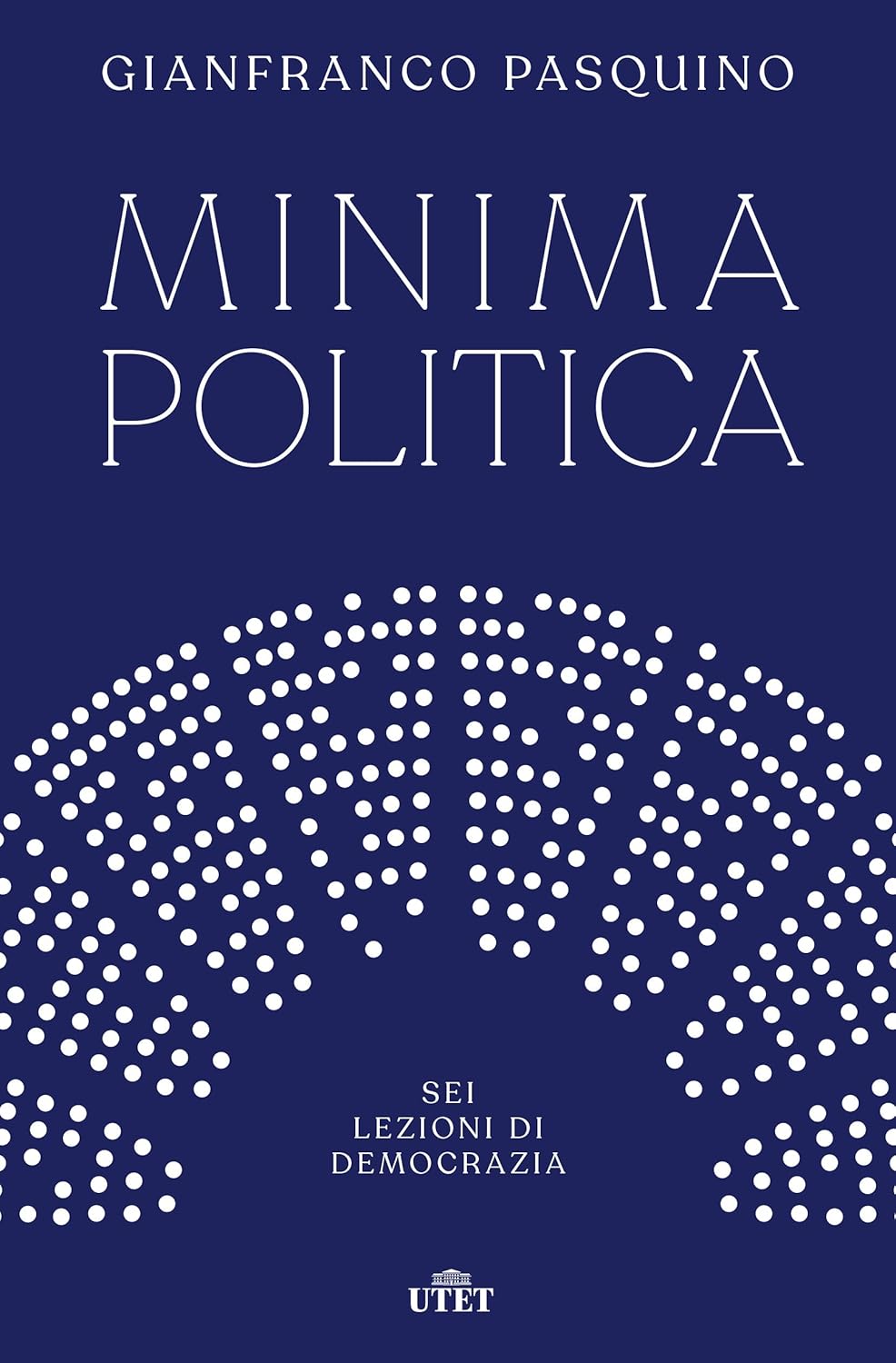






Commento all'articolo