La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio – Enzo Ciconte

SINTESI DEL LIBRO:
Il pendolo
Sono tanti e di natura diversa i banditi d’ancien régime. Non si trovano solo
al Sud, ma anche al Nord dove sono diffusi su un territorio molto ampio.
La parola ‘bandito’, già lo abbiamo accennato, cela realtà diverse:
comprende i fuorusciti, cioè nobili o cittadini eminenti espulsi senza tanti
riguardi in seguito alle lotte fra le fazioni municipali che sembrano non
spegnersi mai; tra di loro c’è anche una quota di soldati disoccupati che
sanno fare un solo mestiere: maneggiare le armi. Il contingente più
numeroso è composto da ladroni, banditi di strada, masnadieri, delinquenti
comuni colpiti dal bando per crimini gravi, per aver ucciso o rubato o
rapinato, e che di conseguenza sono privati dei beni, se ne posseggono, e in
ogni caso espulsi per un periodo di tempo limitato o, nei casi più gravi, per
sempre. È questa, ad una prima approssimazione, la realtà che si presenta
nell’Italia del Cinquecento.
È un banditismo dalle molte facce. Una di queste rivolge l’attacco contro
le proprietà baronali, e la violenza è esercitata esclusivamente contro i
ricchi. E forse qui trova origine il mito del brigante che combatte il ricco a
favore del povero. È un mito, non una realtà diffusa, ma i miti, si sa, non
sempre hanno aderenza alla vita d’ogni giorno.
È una realtà molto complessa, quella del banditismo, e bisogna avere
l’accortezza di distinguere. C’è una varietà infinita: c’è il banditismo come
fenomeno di delinquenza comune, c’è quello che è frutto di ribellismo
popolare e infine quello che acquista un’enorme rilevanza e dimensione fra
Cinquecento e Seicento, quando incrocia e coinvolge in maniera
trasversale diversi ceti sociali, s’incunea nei legami fra signori e banditi,
avviluppa realtà urbane e rurali.
Bisogna saper distinguere: il banditismo di fine Cinquecento, la cui radice
è legata alla crisi sociale ed economica di vasta portata, è diverso da quello
della prima metà del Seicento quando ad emergere sono masnade che si
mettono al servizio dei signori locali o degli eserciti privati dei baroni
diventando strumento della reazione feudale. Ancora diverso sarà quello di
fine Settecento, quando l’arrivo dei francesi in Italia sconvolgerà gli
equilibri politici, creerà nuovi assetti di potere e darà fiato alla nascente
borghesia determinando situazioni di aspre conflittualità e diffusa violenza
al Nord ma ancora di più al Sud.
I banditi creano allarmi, ma i governanti non sempre sanno cosa fare e se
ne interessano solo quando arrivano fin dentro le mura delle città.
La fame occupa per un lungo periodo il primo posto fra le ragioni che
spingono al banditismo. Un nugolo d’affamati, poveri, disperati, storpi,
sciancati, cenciosi – uomini, donne e tanti bambini – affollano le vie delle
città, si arrangiano come possono e quando possono, aggrediscono,
rubano, si danno all’accattonaggio, chiedono l’elemosina davanti a chiese e
conventi, turbano la quiete, o almeno così dicono i benpensanti e tutti
coloro che non hanno voglia di vederseli girare tra i piedi.
Sono in molti, non c’è dubbio; c’è persino il sospetto che non tutti siano
davvero così poveri da essere costretti a stendere la mano. Qualcuno forse
porge la mano perché è un modo come un altro per tirare a campare. Chi
sono i poveri che hanno diritto di chiedere davvero l’elemosina? Non si
può stabilirlo a colpo d’occhio guardando superficialmente quelle
moltitudini. Ma poi, che importa? Non lavorano, e non fanno niente per
guadagnarsi da vivere; tanto basta per metterli al bando, per scacciarli, per
allontanarli dalla vista.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
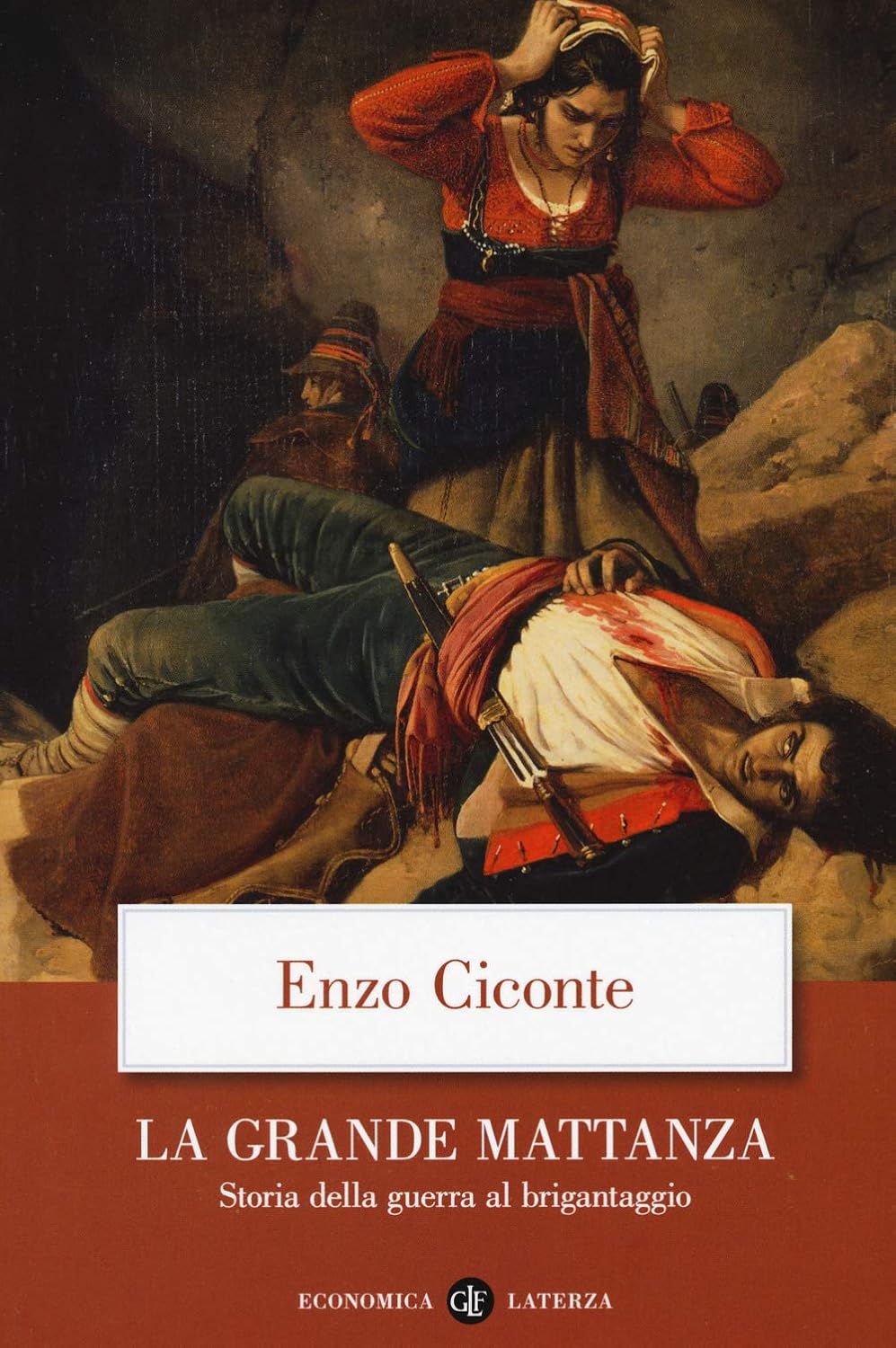






Commento all'articolo