Liquidi – Le sostanze che scorrono nella nostra vita – Mark Miodownik
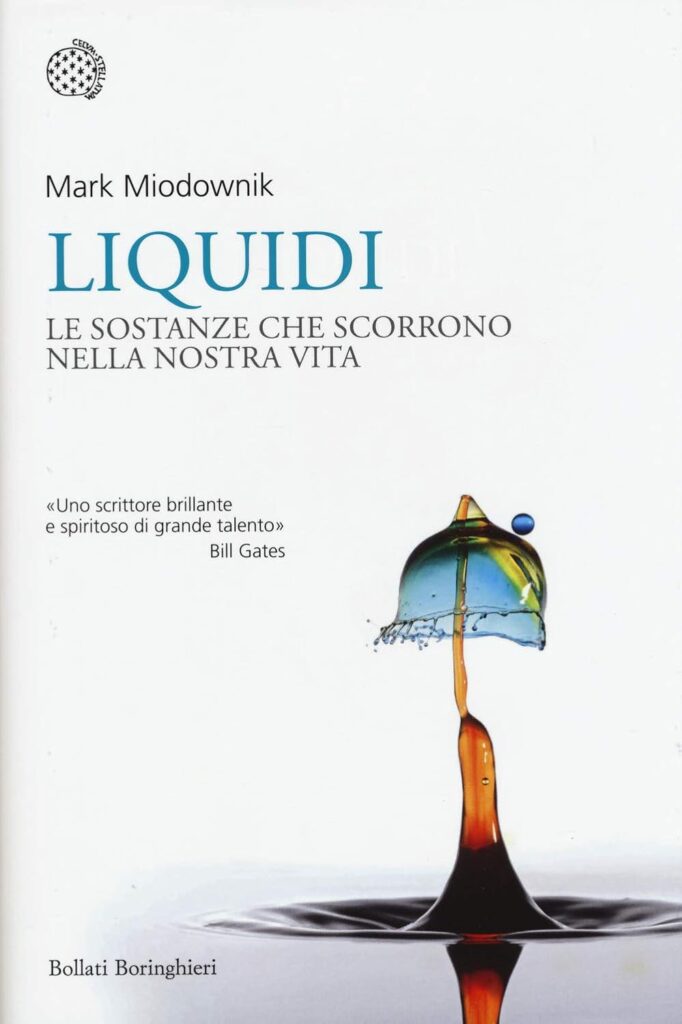
SINTESI DEL LIBRO:
Non appena si chiusero le porte dell’aereo, e ci allontanammo dal
gate dell’aeroporto di Heathrow, una voce annunciò l’inizio delle
istruzioni pre-volo relative alla sicurezza.
«Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti a bordo del volo
British Airways diretto a San Francisco. Prima della partenza, vi
chiediamo di prestare gentilmente attenzione al personale di bordo,
che vi indicherà le dotazioni di sicurezza di questo aereo».
Trovo sempre sconcertante questo modo di iniziare un volo. Sono
convinto che si tratti di una falsità bella e buona: che le istruzioni di
sicurezza, cioè, non riguardino affatto la sicurezza. Tanto per
cominciare, non accennano minimamente alle decine di migliaia di
litri di carburante avio a bordo. A farci volare è, in primo luogo,
l’enorme quantità di energia racchiusa in questo liquido; la sua
natura focosa è ciò che alimenta i motori a reazione, capaci, nel
nostro caso, di portare 400 passeggeri a bordo di un velivolo che
pesa 250 tonnellate dall’immobilità sulla pista di decollo a una
velocità di crociera di 800 chilometri orari, e a un’altezza di 12000
metri, in una manciata di minuti. La formidabile potenza di questo
liquido accende i nostri sogni più sfrenati. Ci permette di alzarci al di
sopra delle nuvole e di viaggiare in qualsiasi parte del mondo nel
giro di poche ore. È la stessa sostanza che, a bordo della sua
navicella, portò sullo spazio il primo astronauta, Jurij Gagarin, e che
oggi alimenta l’ultima generazione dei razzi SpaceX, che lanciano
satelliti nell’atmosfera. Si chiama cherosene.
Il cherosene è un fluido trasparente e incolore che, avendo lo
stesso identico aspetto, può essere confuso con l’acqua. E allora
dov’è immagazzinata tutta questa energia nascosta, questa potenza
invisibile? Perché l’immagazzinamento di tutta questa energia
grezza all’interno del liquido non lo fa apparire, be’, più sciropposo e
pericoloso? E perché non viene menzionato nelle istruzioni di
sicurezza pre-volo?
Struttura di una molecola idrocarburica del cherosene.
Se puntaste un microscopio sul cherosene e lo ingrandiste fino al
livello atomico, vedreste che la sua struttura assomiglia a degli
spaghetti. La spina dorsale di ogni filo è composta da atomi di
carbonio, ciascuno dei quali collegato in successione a un altro.
Ogni carbonio è unito a due atomi di idrogeno, tranne che alle
estremità della molecola, dove sono presenti tre atomi di idrogeno. A
quest’ordine di grandezza la differenza tra cherosene e acqua è
facilmente riconoscibile. Nell’acqua non incontriamo una struttura a
spaghetti, bensì una caotica accozzaglia di piccole molecole a forma
di V (un atomo di ossigeno attaccato a due di idrogeno, H2O). No, a
quest’ordine di grandezza il cherosene assomiglia più all’olio d’oliva,
anch’esso costituito da molecole a base di carbonio tutte mescolate
alla rinfusa. Ma se nel cherosene i fili ricordano più degli spaghetti,
nell’olio d’oliva sono più ramificati e attorcigliati.
Nell’olio d’oliva le molecole hanno una forma più complessa che
nel cherosene, quindi per loro è più difficile muoversi una accanto
all’altra, e il liquido fluisce con maggior difficoltà – in parole povere,
l’olio d’oliva è più viscoso del cherosene. Entrambi sono oli, e a
livello atomico sono relativamente simili, ma, per via delle loro
differenze strutturali, l’olio d’oliva è viscido, mentre il cherosene,
quando si spande, sembra acqua. Questa differenza non determina
solo il grado di viscosità degli oli, ma anche la loro infiammabilità.
Il medico e alchimista persiano al-Rāzi (noto anche col nome
latino Rhazes) parla della sua scoperta del cherosene nel Libro dei
segreti (Kitab al-Asrār), scritto intorno al IX secolo. Al-Rāzi sviluppò
un interesse per le sorgenti naturali della regione, da cui sgorgava
non acqua, ma un liquido denso, nero, sulfureo. All’epoca, questo
materiale bituminoso veniva estratto e utilizzato per pavimentare le
strade, essenzialmente come una sorta di antico antenato
dell’asfalto. Al-Rāzi mise a punto speciali procedure chimiche, che
oggi vanno sotto il nome di distillazione, per analizzare l’olio nero. Lo
riscaldò e ne raccolse i gas espulsi. Poi provvide a raffreddare
nuovamente i gas, che ritornarono allo stato liquido. I primi liquidi
che estrasse erano giallognoli e oleosi, ma attraverso ripetute
distillazioni si trasformarono in una sostanza chiara, trasparente e
fluida – al-Rāzi aveva scoperto il cherosene.
A quei tempi al-Rāzi non poteva sapere che il liquido che stava
maneggiando avrebbe contribuito in maniera così decisiva alla storia
mondiale, ma sapeva benissimo che era infiammabile e che
produceva una fiamma priva di fumo. Al giorno d’oggi potrà anche
sembrare una scoperta risibile, ma l’illuminazione domestica fu un
grosso problema per tutte le civiltà antiche. Le lampade a olio
rappresentavano la più sofisticata tecnologia di illuminazione
dell’epoca, ma fino ad allora l’olio, bruciando, produceva tanta
fuliggine quanta luce. Le lampade a olio che non emettevano fumo
furono un’innovazione straordinaria, al punto che la loro importanza
fu immortalata nella storia di Aladino delle Mille e una notte. Nel
racconto, Aladino trova una lampada a olio: una lanterna magica.
Strofinandola, libera un genio dai poteri magici. I geni compaiono di
frequente nelle leggende del periodo, dove vengono descritti come
creature sovrannaturali fatte di fumo; questo, nello specifico, ha il
potere, immenso, di esaudire i desideri della persona che possiede
la lampada. L’utilità del nuovo liquido e la sua capacità di creare una
fiamma senza fumo non potevano sfuggire all’alchimista al-Rāzi.
Allora perché i persiani non hanno iniziato a usare questo nuovo
spirito? La risposta risiede, in parte, nell’importanza che gli olivi
avevano nella loro economia e cultura.
Nel IX secolo l’olio d’oliva era il principale combustibile per le
lampade a olio in Persia. Nella regione, gli olivi crescevano
rigogliosi, sopportavano la siccità e davano olive dalla cui frangitura
si otteneva l’olio. Ci volevano circa venti olive per ricavare un
cucchiaino di olio d’oliva, che con una normale lampada a olio
forniva un’ora di luce. Per cui, se un nucleo familiare avesse avuto
bisogno di cinque ore di luce per sera, avrebbe dovuto spremere 100
olive al giorno, ossia, approssimativamente, 36000 olive all’anno per
una sola lampada. Per produrre una quantità di olio sufficiente a
illuminare il loro impero, i persiani necessitavano di un’abbondanza
di terre e di tempo, perché in genere gli olivi non fruttificano se non
dopo vent’anni. I persiani dovevano poi proteggere i loro terreni da
chiunque volesse rubare questa preziosa risorsa, e perciò avevano
bisogno di città ben organizzate, il che presupponeva una presenza
ancor più abbondante di olive, affinché ogni abitante disponesse di
abbastanza olio per cuocere e insieme illuminare la casa. Per
mantenere un esercito dovevano pagare le tasse, e in Persia il
pagamento delle tasse spesso comportava la cessione al governo di
una percentuale della propria produzione di olio d’oliva. Quindi,
come si può vedere, l’olio d’oliva ricopriva un ruolo centrale nella
società e nella cultura dei persiani, come del resto in tutte le civiltà
mediorientali, finché non trovarono una fonte alternativa di energia e
di gettito fiscale. Gli esperimenti di al-Rāzi dimostravano che stava
proprio sotto i loro piedi: ma lì sarebbe rimasta per un altro migliaio
di anni.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :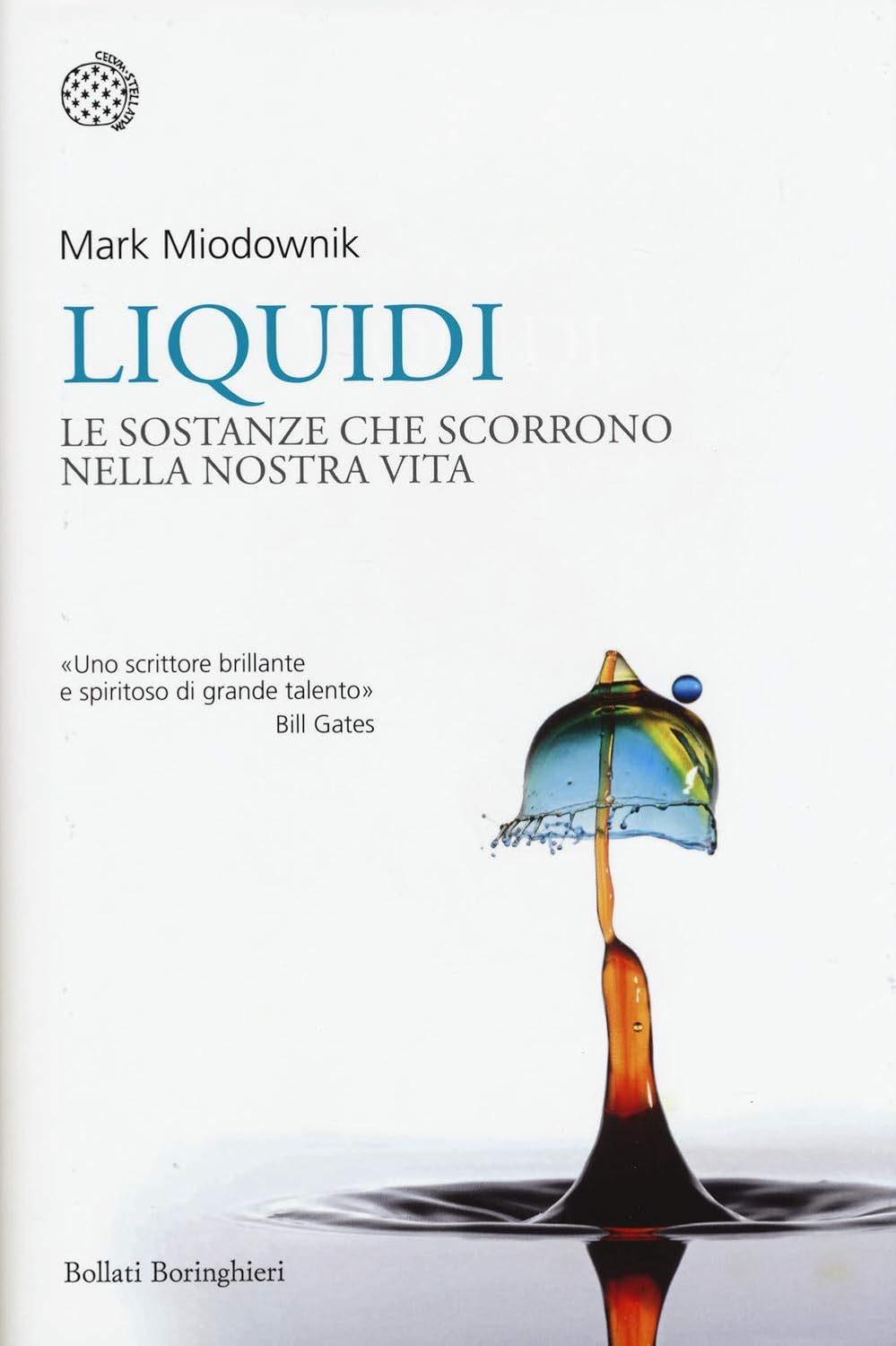






Commento all'articolo