La scuola dopo il coronavirus – Raffaele Mantegazza
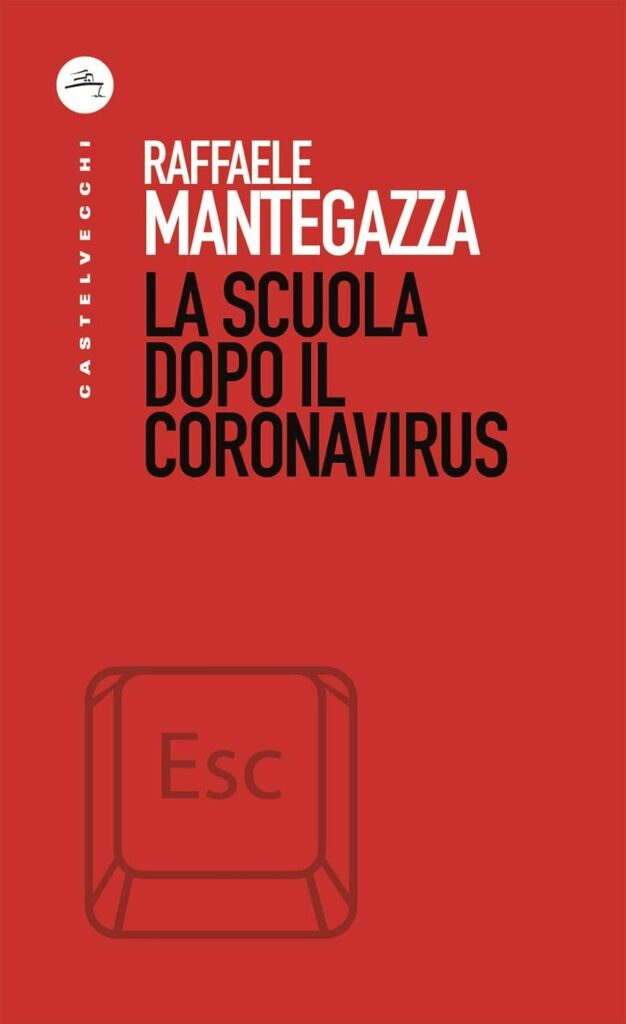
SINTESI DEL LIBRO:
Le scuole sono chiuse. Non c’è più nessuno. I banchi si
impolverano, il silenzio prende il posto delle parole, dello scricchiolio
delle sedie, del rumore delle carte delle merende. Quante volte
l’abbiamo chiesto ai ragazzi, il silenzio; ma era il silenzio del tacere,
del fare spazio alla parola, del fuoco che cova sotto la cenere. Ora è
solo silenzio. Niente cellulari messi sotto il banco anche se sono
vietati, niente bigliettini con i risultati delle verifiche passati in
segreto, niente entusiasmi, sbadigli, divertenti lavori di gruppo o
sguardi distratti all’orologio. Tutto è fermo, tutto tace e non c’è
nemmeno la consolazione delle spiagge estive piene di gioia a fare
da contraltare. Una delle immagini più emblematiche della
desolazione di questi giorni è un’aula vuota, abbandonata dopo un
fine settimana di febbraio, e che, come la scuola del fumetto
Peanuts sente la mancanza dei ragazzi, anche di Sally Brown che la
prendeva a calci.
Ma sappiamo anche che questa non sarà l’immagine definitiva.
Ricominceremo, sconfiggeremo il virus, le scuole riapriranno, forse a
settembre. Ma cosa ce ne faremo di tutta questa malinconia quando
tutto questo sarà finito? Che suono avrà la campanella il primo
giorno di scuola del dopovirus? Come siederanno nei banchi i nostri
ragazzi? Torneranno a mettersi in bocca la penna del compagno, a
rubargli i calzini negli spogliatoi, a sputare i pezzettini di carta
usando la Bic senza refil come cerbottana?
E soprattutto: ci sarà qualcuno a osservare e a commentare tutto
questo? O a contare saranno soltanto i contenuti, non da assimilare
e metabolizzare, ma da rincorrere, rimettere in pari, recuperare,
esattamente come fanno le agenzie di recupero crediti (visto che
ormai la parola “credito” è stata del tutto sdoganata all’interno dei
contesti scolastici)?
La scuola saprà cambiare, e riempire queste aule vuote di una
ricchezza nuova? Saprà trovare nuove parole al posto di questo
insostenibile silenzio?
La scuola e la paura
La scuola dopo il coronavirus non potrà più fingere che non esista la
paura. Non solo: non potrà più ignorare il fatto che la paura ha due
aspetti, uno distruttivo e paralizzante, l’altro evolutivo e
indispensabile per la sopravvivenza. In questi giorni, i ragazzi, come
tutti noi, hanno dovuto convivere con due messaggi paradossali: da
un lato il tentativo di gestire la paura, l’«andrà tutto bene», la voglia
di non lasciarsi paralizzare dal panico, dall’altro la stupidità di chi
voleva dimostrare di non avere paura, mettendo a rischio la propria e
l’altrui incolumità. La paura come nemico e la paura come alleato:
una contraddizione che è da sempre nel nostro Dna ma che stiamo
riscoprendo solo oggi in tutta la sua tragicità. Non sono i messaggi
delle autorità («niente panico», «state in casa») ad essere
contraddittori, ma è la condizione umana che non ha imparato
l’equilibrio tra il coraggio e l’incoscienza. Se davvero l’umanità dovrà
cambiare dopo questa inattesa esperienza sarà nel segno della
gestione dei paradossi che la paura le mette di fronte.
La scuola raramente ha parlato di paura; erano i film di Halloween, le
storie di Dylan Dog, la musica dark e i videogame splatter a regalare
ai ragazzi una pedagogia della paura. Anche Lovecraft, Poe,
Maupassant erano considerati poco degni di essere proposti ai
ragazzi nelle scuole, figuriamoci Stephen King o Roald Dahl. Si
aveva un po’ paura della verifica, parecchia del bullo di turno; la
scuola non è mai stata depurata dalla paura, ma raramente è stata
oggetto di studio e di elaborazione culturale. Quando si parlava di
emozioni a scuola spesso si commetteva la leggerezza di chiedere
ai ragazzi di raccontare le loro emozioni: con il risultato di avere
scialbe narrazioni che giustamente mantenevano nel segreto le vere
dimensioni emotive dei giovani. Se vogliamo parlare di paura ai
giovani non chiediamo loro di raccontare «quella volta in cui hai
avuto paura» (ma perché dovrebbero raccontarla proprio a noi? E
proprio a scuola?) ma facciamo studiare la composizione pittorica
dell’Urlo di Munch; la cultura elabora la paura e ci permette di
occuparci delle nostre emozioni senza esporci eccessivamente, e
mantenendo quel sano schermo che è il senso del pudore.
A scuola sarebbe così importante considerare la paura come fattore
evolutivo da spiegare nell’ora di scienze, ascoltare la paura di
sbagliare un calcio di rigore della canzone di De Gregori come
sottofondo alla lezione di educazione fisica, studiare la paura del
filosofo davanti al cielo stellato e alla legge morale; sarebbe così
bello spiegare la scienza parlando della paura di Christian Barnard
davanti al nuovo cuore di Louis Walshanski o di Albert Einstein
davanti alla bomba atomica: al posto di tutto ciò abbiamo insegnato
per anni una scienza insopportabilmente arrogante che fa quello che
vuole solo perché può farlo e che crede di poter trovare tutte le
risposte quando dovrebbe imparare a porre le domande, una
filologia che faceva a pezzi ogni testo e ogni emozione che in esso
era depositata, una storia non fatta da uomini che tremavano nudi
nei campi di sterminio o che impazzivano sotto i bombardamenti ma
da improbabili eroi, masse, eserciti fatti di opliti meno che umani.
E adesso? Quale scienza trasmetteremo ai nostri ragazzi? Quale
cultura? Quale filosofia della scienza? L’abbiamo spacchettata, la
cultura, l’abbiamo divisa in unità di consumo come le mono-razioni
che acquistiamo al supermercato, l’abbiamo accreditata, e valutata
grammo per grammo, siamo arrivati a calcolare a quante ore di
lavoro e a quante pagine (di Hegel? di Topolino?) corrisponde un
credito formativo; in questi giorni forse l’abbiamo anche costretta
nelle gabbie di mini-video da venti minuti, magari con diciannove
minuti di slide. Ma la cultura che abbiamo trasmesso a scuola fino ai
primi di marzo ha retto all’urto del Covid? I ragazzi hanno trovato
forza e supporto morale e spirituale in Leopardi, nei limiti di funzione,
nell’assonometria isometrica? Hanno avuto voglia di aprire un libro
per combattere l’angoscia, la solitudine, la depressione dello stare
chiusi in casa per mesi? Siamo mancati loro non solo come
riferimenti umani ma come coloro che sapevano schiudergli davanti i
misteri della chimica, della lingua spagnola, della storia dell’arte?
Liberare l’uomo dalla paura: questo voleva l’Illuminismo. Insegnarci
a convivere con la paura liberandoci dalla paralisi dell’orrore: questo
avrebbe dovuto fare la scuola. Può ancora farlo; ma la prossima
volta, potrebbe non esserci un’altra possibilità.
La scuola e la morte
«Nel mezzo del cammin di nostra vita»: il verso più famoso della
poesia mondiale è anche il più sottovalutato. Si ha fretta di entrare
nella selva oscura e si dice che il significato del verso è che Dante
aveva trentacinque anni. Eppure sarebbe così interessante riflettere
su cosa significa, nella nostra esperienza quotidiana, essere «nel
mezzo del cammin». Quando siamo a metà strada per il mare,
quando abbiamo sostenuto il decimo dei venti esami universitari,
quando passa la notte del mercoledì, i nostri occhi iniziano a
concentrarsi sulla meta e non più sul punto di partenza. Non
pensiamo più alla città ma al mare, non ricordiamo più la scuola
superiore ma immaginiamo la laurea, ci proiettiamo verso la
domenica o, leopardianamente, verso il sabato. Così per Dante: nel
mezzo del cammin capì che doveva morire, ma non lo capì come
chiusura del sillogismo («il sillogismo elementare che aveva studiato
nel manuale del Kizevetter: Caio è un uomo, gli uomini sono mortali,
Caio è mortale, per tutta la via gli era sempre sembrato giusto, ma
solo in relazione a Caio, non in relazione a se stesso. Un conto era
l’uomo-Caio, l’uomo in generale, e allora quel sillogismo era
perfettamente giusto; un conto era lui che non era né Caio né l’uomo
in generale, ma un essere particolarissimo, completamente diverso
da tutti gli altri esseri. Aveva mai sentito Caio l’odore del pallone di
cuoio che il piccolo Vanja amava tanto? Aveva mai baciato la mano
della mamma, Caio, e aveva mai sentito frusciare le pieghe della
seta del vestito della mamma, Caio? E Caio aveva mai strepitato
tanto per avere i pasticcini quando andava a scuola?»1
) ma come
brivido esistenziale. In questo senso si può essere «nel mezzo del
cammin» anche a sedici anni se si coglie la morte come destino e
come compito; in questo senso siamo stati «nel mezzo del cammin»
in questo sciagurato anno del doppio 20. Abbiamo capito che
dovremo morire; non di coronavirus, ma un giorno, domani, qui.
Il numero dei morti, il confronto tra i morti in Italia e in Cina, in
Lombardia e in Puglia, la mortalità del virus. La morte ha fatto il suo
ingresso nella nostra quotidianità con una forza che non
sospettavamo. Non era accaduto in modo così invasivo per il Vajont,
per Seveso, per i terremoti in Belice, in Friuli, in Irpinia, a L’Aquila,
nel centro Italia. Forse solo Via Caetani e Vermicino ci avevano
portato in casa la morte in modo così brutale; ma era la morte di una
persona, inumanamente chiusa in un bagagliaio o sprofondata nelle
viscere della terra, era la morte della bambina con il cappottino
rosso, noi dei sei milioni di sommersi. Forse Dallas e l’11 settembre
ci avevano fatto assaggiare il ghigno della morte; ma era comunque
una morte lontana, una morte oltre oceano. Piazza Fontana, Piazza
Loggia, l’Italicus, Ustica, Bologna avevano punteggiato una stagione
di morte e follia. Ma erano ormai anni che la morte ci stava lontana,
riproposta semmai dagli attentati islamici e dalla loro perturbante,
incomprensibile disumanità; trasmessa mille volte dagli schermi e
ormai depotenziata, disinfettata, resa indolore.
Ma la morte in questi giorni è ripetuta, ribadita, moltiplicata, ed è
morte vicina, prossima. L’immagine delle camionette dell’esercito
che trasportano i resti delle persone decedute in uscita da una
grande città del Nord è per ora una delle icone più terribili della
tragedia. Ed è una morte che tecnicamente non ha colpevoli a meno
di tornare a cacciare gli untori, come qualcuno ha anche fatto.
Stavolta non ci sono nazisti o terroristi da incolpare, non c’è
l’assassino ma ci sono gli assassinati. Non c’è colpa ma solo pena.
È il nuovo terremoto di Lisbona, e allora occorre un Voltaire che lo
racconti; magari meno pessimista del filosofo ma altrettanto radicale
e coraggioso.
Non possiamo pensare che l’isolamento delle nostre scuole, la loro
chiusura ermetica, abbia tenuto la morte all’esterno delle aule.
Perché lei è sempre stata lì; solo che facevamo finta di non vederla.
Abbiamo cercato vanamente di tenerla lontana da noi, ma la morte
non ne ha voluto sapere. Leggere Tucidide, Manzoni o Camus ci
dava un senso di superiorità; in fin dei conti le pestilenze e le
epidemie erano abbastanza lontane da noi nel tempo (il passato
della storia o il futuro della fantascienza) o nello spazio (paesi dei
quali non conosciamo nemmeno il nome della capitale) da
permetterci di tirare un sospiro di sollievo. L’Aids, l’Ebola, la Sars, la
cosiddetta Mucca Pazza ci avevano spaventati ma ci siamo ben
guardati dal parlarne a scuola (ma come abbiamo fatto a rimuovere
così in fretta una sindrome che ha cambiato i costumi sessuali di
milioni di persone?).
Parleremo di morte nelle nostre classi quando riapriranno? Lo
sciocco alibi del fatto che parlare di morte impressiona e spaventa i
ragazzi ci ha smascherati come i pavidi che finora siamo stati: a
spaventare è la morte insensata, la morte non narrata, a terrorizzare
è il silenzio della e sulla morte. Che altro è la cultura se non un modo
di esorcizzare la morte, di guardare in faccia il negativo? Che altro è
una passeggiata nei boschi autunnali se non un godere della morte
stagionale della natura, che altro è il rosso delle foglie se non il
segno della morte imminente? Che altro ha dipinto Monet, che altro
ha composto Vivaldi, di che altro ha parlato Hegel? Potrebbe mai un
essere immortale pronunciare l’«Addio ai monti» o puntare telescopi
verso lo spazio profondo? Ci siamo fatti convincere che i dati messi
online resteranno “per sempre”, che il web ha realizzato l’eternità del
tempo circolare; e intanto la vecchiaia ci stava accanto e ogni giorno
nascevano esseri umani che in quanto nascenti erano morenti.
E la scuola, che come il cielo stellato anch’essa finirà, ha mai
riflettuto seriamente sulla propria finitudine, sulla propria precarietà,
sulla propria morte?
Corpi feriti, anime da curare
Abbiamo parlato della fragilità, forse; ma ne abbiamo appunto
parlato, l’abbiamo resa oggetto di un logos (meglio che niente, per
carità) quando invece essa nasce da eros, dalla disperata tenacia
dell’amore che accumula unità di vita sapendo che la morte le
disperderà. Adesso il virus ci sbatte in faccia il fatto che
l’invulnerabilità non è solo un concetto filosofico da studiare tra il
passero di Leopardi e il tallone di Achille (tutto sommato una cosa
rassicurante: sono Giacomo e il Pelide ad essere vulnerabili, non noi
che li studiamo), ma una realtà ineludibile, la caratteristica propria di
un essere umano che nell’ansia di mettere le mani sulla generatività
e sul fine vita, adesso le mani non se le sa più neanche lavare. Il
“chiuso morbo” ha portato via tante Silvie, tante Teti hanno dovuto
riflettere sul fatto che se una persona è vulnerabile anche solo in un
punto del nostro corpo lo è ovunque. È il corpo a uscire
ridimensionato da questa vicenda: o meglio, ad essere restituito alla
sua giusta dimensione, lontano dai deliri nei quali una specie di neocartesianesimo tecnologico lo aveva scagliato; corpi virtuali, corpi
bionici, corpi indistruttibili. Poi la febbre, la tosse, il mal di gola, e può
essere la fine.
Perché probabilmente è questo che la scuola dovrà tornare a
insegnare: che la cultura è uno degli aspetti della cura di sé, e che la
cura di sé è prima di tutto corporea. Che c’è una postura corporea
per la matematica, la lingua inglese, la filosofia (basta pensare alla
scuola peripatetica) e non è detto che sia sempre risolvibile in un
corpo seduto. Ma i bisogni corporei dei ragazzi a scuola sono ancora
più radicali. Continueremo a far cambiare i ragazzini sulle scale
perché gli spogliatoi sono inagibili, a non permettere agli adolescenti
di fare la doccia dopo due ore di educazione fisica, a pensare che a
qualsiasi età si possa davvero imparare qualcosa stando per tre ore
seduti in un banco, il più delle volte anche scomodo? Accetteremo di
abitare scuole letteralmente invivibili dal punto di vista fisico?
Tollereremo ancora di avere 250 bambini che mangiano insieme cibi
precotti avendo anche la sfacciataggine di definire tutto questo
“educazione alimentare”? Continueremo, come scriveva Mario Lodi
quaranta anni fa, a educare i ragazzi dal collo in su, oppure
capiremo che l’educazione è una avventura corporea, e senza il
corpo non esiste, letteralmente?
Il virus ha colpito la vicinanza, l’abbraccio, il corpo-a-corpo; proprio le
caratteristiche tipiche del rapporto tra bambini e tra adolescenti, e
forse del rapporto tra due esseri umani in generale. L’uomo è un
essere aperto, rende visibili le sue vulnerabilità, la posizione eretta
l’ha portato a esibire le parti più fragili. L’abbraccio restituisce
all’uomo una difesa, la schiena dell’altro è il mio carapace, e
viceversa; i questo ci mancano gli altri, e questo non è sostituibile da
Skype. Nelle nostre scuole i bambini scoprono il corpo dell’altro
come limitazione, come confine, come barriera e come novità da
esplorare; gli adolescenti trovano un equilibrio tra la privacy e il
desiderio di toccare e di essere toccati, tra il corpo dell’altro come
oggetto di desiderio e come minaccia alla propria intimità; i giovani
all’università imparano a gestire il corpo come richiedono le diverse
discipline e future professioni: il corpo che cura, che calcola, che
interroga, che progetta, che si pone le domande esistenziali, che si
china su un testo per carpirne i segreti. Quanto di tutto ciò sarà
possibile, dopo? Organizzeremo i lavori di gruppo: siamo certi che
questa abitudine a tenere un metro di distanza dalle persone, che ci
costringe in questi giorni a strani passi di tango le poche volte che
usciamo, non sia penetrata nei corpi e nelle menti? Accarezzeremo
ancora i capelli di un ragazzino che ha preso un brutto voto per
consolarlo senza essere abitati dalla paura? E forse questo metro di
distanza, che è poi lo spazio dell’intimità studiato dalla prossemica di
Edward Hall, non ci aiuterà invece proprio a capire qual è il confine
del corpo dell’altro, nei confronti del quale sia la freddezza che
l’invasività sono da evitare? Forse la bolla che stiamo costruendo
attorno al nostro corpo per paura del contagio può aiutarci a capire
che l’intimità è sacra e che può accedervi solamente chi non ci
minaccia, e che siamo solo noi a decidere chi può toccarci. Ma in
questo recupero metaforico di una bolla che ora è reale, la scuola
sarà essenziale. Il virus potrebbe darci una nuova consapevolezza
del nostro corpo. Quando si sta a meno di un metro dall’altro si
rischia di trasmettere o contrarre il virus: ma in seguito, quando
entreremo in questa sfera che ha come centro il baricentro dell’altro,
potremo capire meglio che stiamo facendo un gesto importante ma
delicato di intromissione nella sua privacy. Ci toccheremo dopo il
virus, ma forse lo faremo con più consapevolezza; con più umana e
attenta tenerezza.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :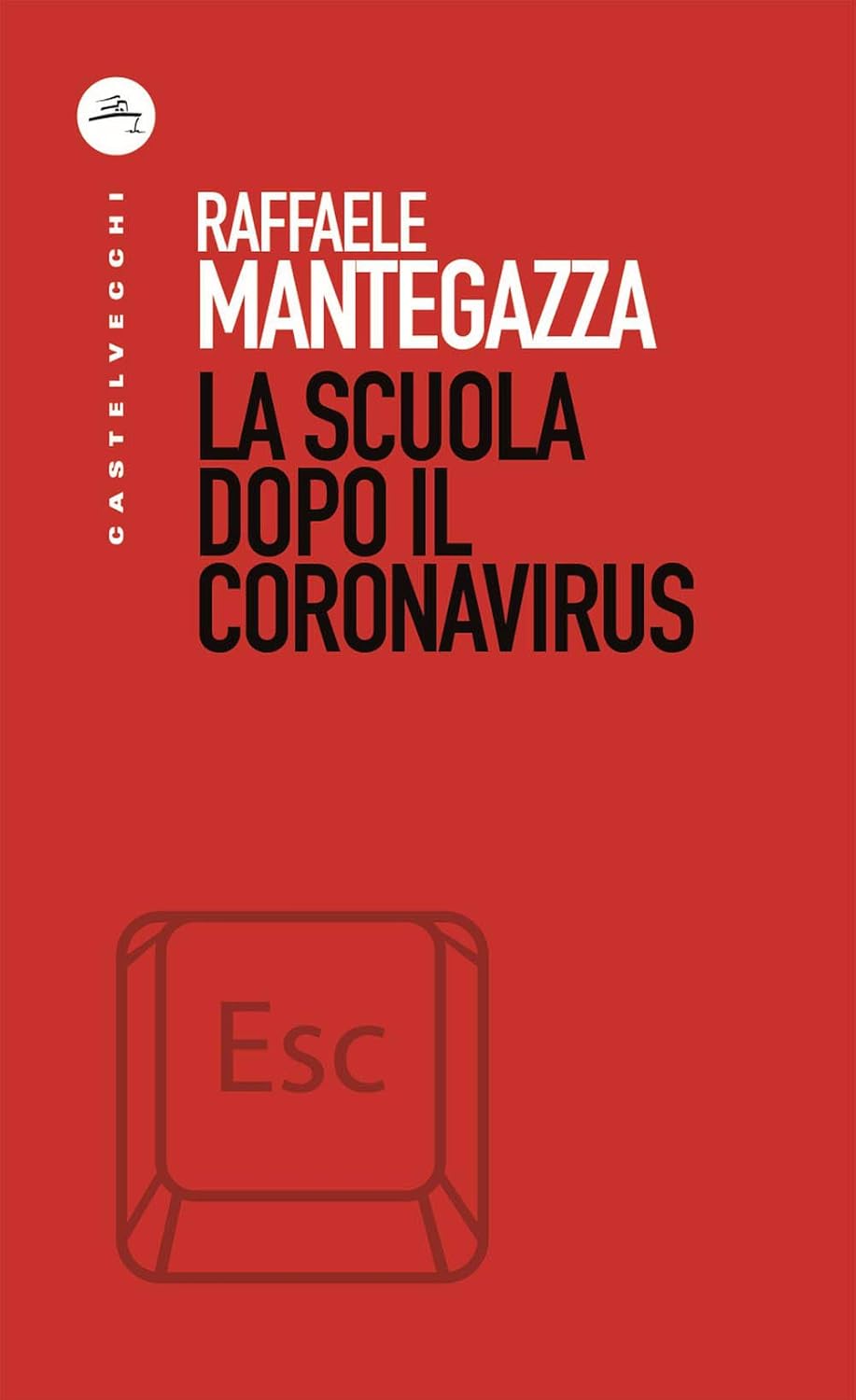






Commento all'articolo