La battaglia di Canne – Massimo Bocchiola

SINTESI DEL LIBRO:
I
Cartagine
Per più di metà della sua storia Cartagine fu simile a una nave all'ancora
davanti alla costa africana.
Gilbert e Colette Charles-Picard, I Cartaginesi al tempo di Annibale
I Greci erano bene informati delle vicende antiche di Cartagine e di Roma,
e nei loro giudizi istituivano profonde connessioni tra le due città. Il motivo è
molto semplice: essi ritenevano che Romani e Cartaginesi fossero tra i popoli
“barbari” quelli che più si avvicinavano al modello di civiltà greco.
Già nel IV secolo a.C., per esempio, Aristotele aveva dedicato alcune
pagine della sua Politica al confronto tra le costituzioni di città celebri per la
loro saggezza e tra queste, a fianco di un vero e proprio mito come la
costituzione di Sparta, si trovava anche la costituzione di Cartagine. Secondo
un criterio di analisi proprio del pensiero politico antico, che attribuisce un
ruolo preminente alle forme di governo e alla loro durata, nel giudizio del
filosofo Cartagine aveva una buona costituzione perché «non sorgono né
ribellioni né tirannidi», e godeva della stabilità garantita dalla presenza
temperata di monarchia, aristocrazia e democrazia.
E qualche decennio dopo - intorno al 240 a.C. - il dotto Eratostene,
direttore della Biblioteca di Alessandria, aveva introdotto Cartagine e Roma
in un elenco di popoli, tra i quali i Persiani e gli Indiani, che più di ogni altro
si avvicinavano alla civiltà greca; e tra costoro proprio i Cartaginesi e i
Romani potevano vantare un'organizzazione politica ammirevole.
C'è infine uno storico greco di Sicilia, Timeo di Tauromenio (Taormina),
che ci ha lasciato un singolare sincronismo (814 a.C.) tra la fondazione di
Roma (data errata e non accolta da storici antichi e moderni), e quella più
verosimile di Cartagine, confermata dai dati archeologici che rivelano un
abitato esteso e organizzato già nell'VIII secolo. Evidentemente questo
sincronismo è la maniera con cui lo storico, che per luogo di nascita dovette
per forza interessarsi di Cartagine, certifica ben prima di Polibio l'importanza
nella storia del Mediterraneo delle due potenze barbare e il ruolo che sono
destinate a ricoprire.
Da colonia a madrepatria
Nei giudizi - a volte pregiudizi - che i Greci esprimevano sulle popolazioni
del Mediterraneo, ci riguarda più da vicino il fatto che essi fossero portati a
vedere nelle altre realtà urbane lo specchio della loro idea di città, o di
colonia, vale a dire una fondazione caratterizzata da un centro urbano, un
territorio circostante che le appartiene (chora) e che la rende autosufficiente, e
infine un'organizzazione politica che si palesava in spazi pubblici ben
riconoscibili.
I Fenici però erano soprattutto dei commercianti, e le loro città erano
diverse. Come suggerisce la topografia dei loro insediamenti, i Fenici si
stanziavano sempre fra terra e mare - per esempio Cadice sull'Atlantico, o
Mozia in Sicilia - e creavano scali ed empori con i loro santuari e magazzini
su promontori ai margini del continente europeo o africano, su lingue di terra
circondate dal mare, oppure alla foce dei fiumi o su isole dirimpetto alla
costa; manifestavano in questo loro modo di insediarsi non violento o
intrusivo una volontà di allacciare rapporti pacifici con le comunità locali
dell'interno che non venivano disturbate nelle loro varie forme di
occupazione del territorio.
Qart Hadasht (la “città nuova”), che i coloni di Tiro fondarono nel IX
secolo sulla rotta per le colonne d'Ercole, non ebbe inizi molto diversi dagli
altri fondaci fenici. Situata sulla costa dell'attuale Tunisia, su un promontorio
ora interrato sul golfo di Tunisi, essa sfruttava rientranze della costa e laghi
costieri e si estendeva inizialmente lungo il litorale marino ai piedi di una
collina chiamata Byrsa (probabilmente dal fenicio bosra, “scarpata”) la quale,
ma solo in un secondo tempo e forse per influsso del mondo greco, sarebbe
diventata una sorta di acropoli con i templi e la sede di quegli spazi politici
che mancavano nelle fondazioni fenicie.
Successivo alla fondazione della città è il suo sviluppo come potenza
commerciale nel Mediterraneo occidentale a partire dal VII secolo. Esso
viene generalmente collegato con la crisi della madrepatria Tiro, crisi che
continua e giunge al suo culmine nel 573/572 a.C. quando la città viene
conquistata dagli Assiri. Cartagine dunque si sarebbe sostituita a Tiro nel
controllo della rete di colonie nel Mediterraneo occidentale obbligate a fare
riferimento a un centro egemone per reggere all'aggressiva concorrenza della
colonizzazione agricola greca e alle ricorrenti minacce delle popolazioni
locali.
A questo progressivo declino della madrepatria dovette corrispondere in
qualche misura un cambiamento anche nella situazione interna che si
manifestò nella formazione di una nuova unità etnica composta da Fenici e
Libi. Unità che a partire dal VII secolo si può chiamare punica, come è
attestato dal carattere relativamente aperto delle relazioni (anche
matrimoniali) tra i ceti sociali elevati di Cartagine e quelli delle tribù libiche:
la terza delle figlie di Amilcare, delle quali il generale si serviva
disinvoltamente come pedine in scambi di natura politica, sposò Narava, capo
di una tribù di Numidi, che aveva offerto il suo aiuto durante la rivolta dei
mercenari, e con il nome fittizio di Salambó sarebbe diventata nella violenta
fantasia di Flaubert l'eroina del romanzo omonimo.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
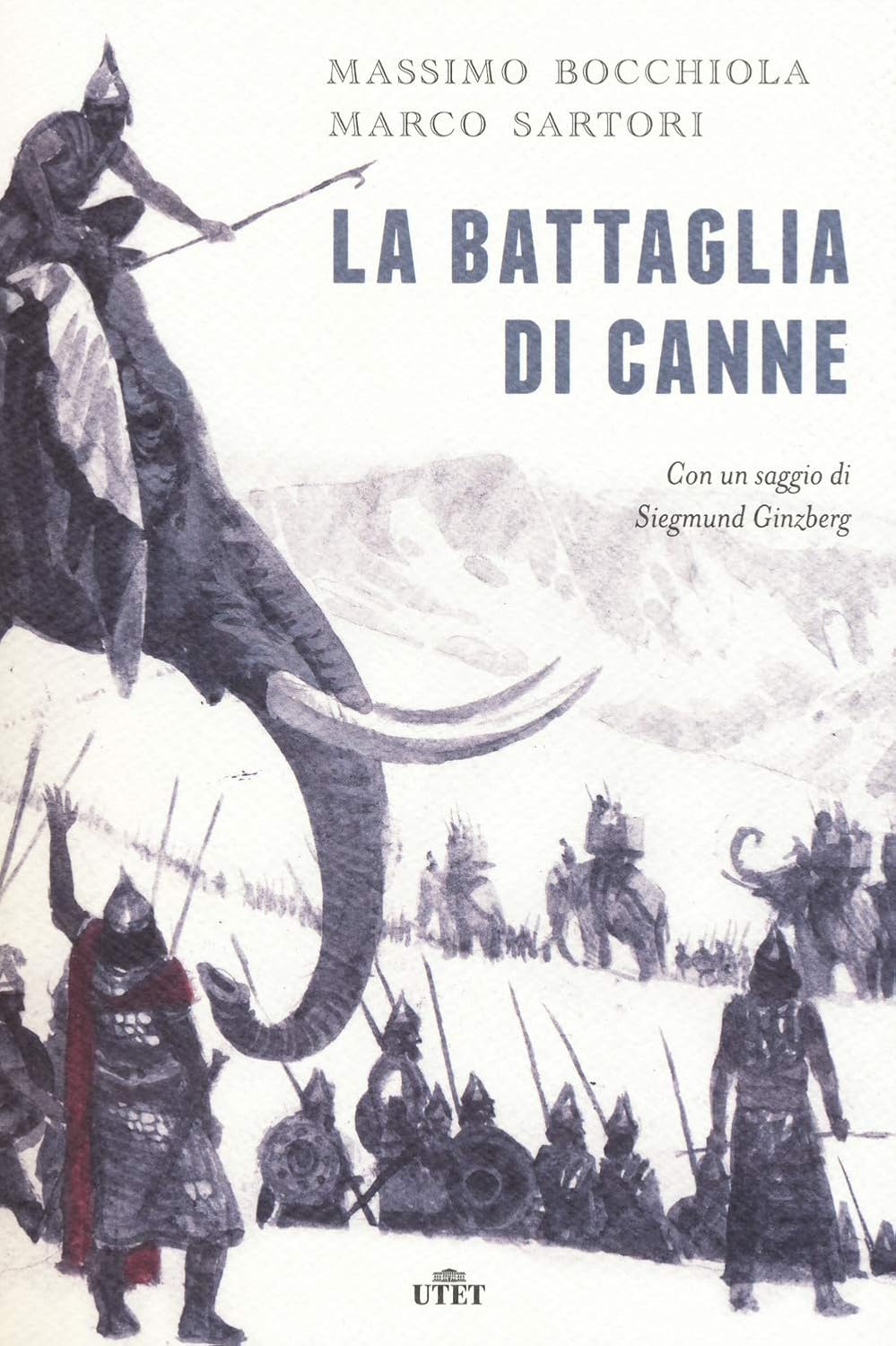






Commento all'articolo