La cultura si mangia! – Bruno Arpaia
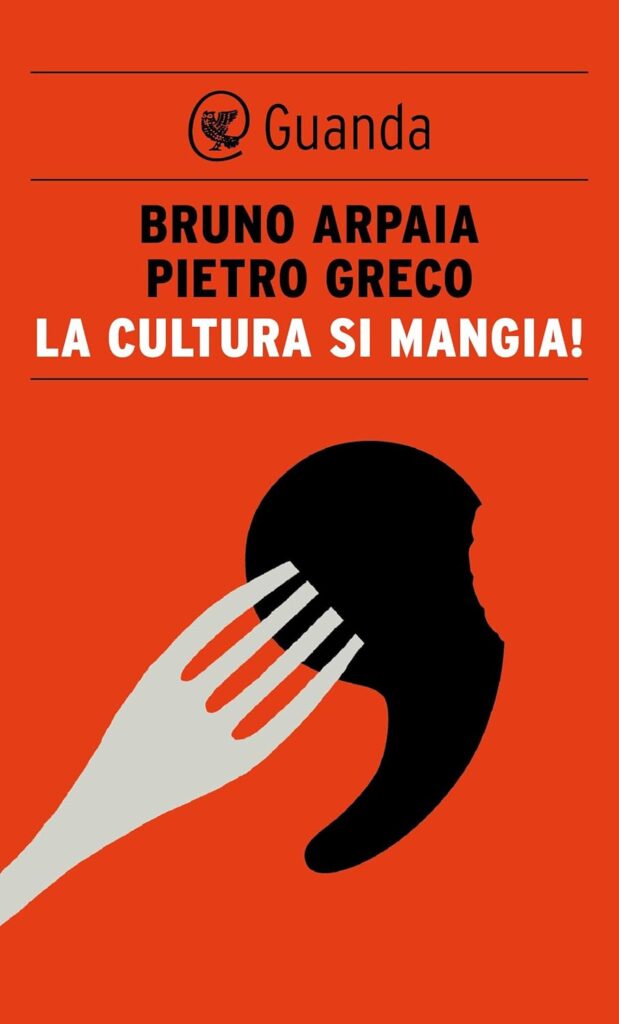
SINTESI DEL LIBRO:
D’accordo, ne siamo consapevoli: è fin troppo facile iniziare con le
ormai celebri dichiarazioni di Giulio Tremonti. Ma non è colpa nostra
se, quando era ministro dell’Economia, il commercialista di Sondrio
ha riassunto in una sola battuta i pregiudizi e le arretratezze di buona
parte del Paese rispetto a tutto ciò che sa di pensiero, di riflessione,
di elaborazione culturale, di sguardo lungo sui nostri destini. «Con la
cultura non si mangia» ha dichiarato infatti Tremonti il 14 ottobre
2010. Poi, non contento, ha aggiunto: «Di cultura non si vive, vado
alla buvette a farmi un panino alla cultura, e comincio dalla Divina
Commedia». Che umorista. Che statista. Meno male che c’è gente
come lui, che pensa ai sacrosanti danè. E infatti, con assoluta
coerenza, Tremonti ha tagliato un miliardo e mezzo di euro alle
università e otto miliardi alla scuola di primo e secondo livello, per
non parlare del Fus, il Fondo unico per lo spettacolo e altre inutili
istituzioni consimili. Meno male. Sennò, signora mia, dove saremmo
andati a finire?
In questi ultimi anni, però, l’ex socialista Tremonti non è stato il solo
uomo politico a pronunciarsi sui rapporti tra cultura ed economia. Per
esempio, l’ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maurizio
Sacconi, ha sostenuto che per i laureati non c’è mercato e che la
colpa della disoccupazione giovanile è dei genitori che vogliono i figli
dottori invece che artigiani. Sapesse, contessa... E il filosofo estetico
Stefano Zecchi, in servizio permanente effettivo nel centrodestra, ha
chiuso in bellezza, come del resto gli compete per questioni
professionali: ha detto che in Italia i laureati sono troppi. Insomma,
non c’è dubbio che la destra italiana abbia sposato la cultura della
non cultura e (chissà?) magari già immagina un ritorno al tempo
dell’imperatore Costantino, quando la mobilità sociale fu bloccata per
legge e ai figli era concesso fare solo il lavoro dei padri. (Non lo
sapeva, professor Sacconi? Potrebbe essere un’idea...)
E la sinistra o come diavolo si chiama adesso? Parole, parole,
parole. Non c’è uno dei suoi esponenti che, dal governo o
dall’opposizione, non abbia fatto intensi e pomposi proclami
sull’importanza della cultura, dell’innovazione, dell’istruzione, della
formazione, della ricerca e via di questo passo, ma poi, stringi stringi,
non ce n’è stato uno (be’, non esageriamo: magari qualcuno c’è
stato...) che non abbia tagliato i fondi alla cultura, all’innovazione,
all’istruzione, alla formazione, alla ricerca e via di questo passo. Per
esempio, nel programma di governo dell’Unione per il 2006 si diceva:
«Il nostro Paese possiede un’inestimabile ricchezza culturale che in
una società postindustriale può diventare la fonte primaria di una
crescita sociale ed economica diffusa. La cultura è un fattore
fondamentale di coesione e di integrazione sociale. Le attività
culturali stimolano l’economia e le attività produttive: il loro indotto
aumenta gli scambi, il reddito, l’occupazione. Un indotto che, per
qualità e dimensioni, non è conseguibile con altre attività: la cultura è
una fonte unica e irripetibile di sviluppo economico».
Magnifico, no? Poi l’Unione (o come diavolo si chiamava allora)
vinse le elezioni e andò al governo. La prima legge finanziaria, quella
per il 2007, tagliò di trecento milioni i fondi per le università. Bel
colpo. Ci furono minacce di dimissioni del ministro per l’Università e
la Ricerca, Fabio Mussi. Ma le minacce non servirono. Tant’è che,
nella successiva legge di bilancio, furono sottratti altri trenta milioni
dal capitolo università a favore... degli autotrasportatori. E inoltre,
come scrivono Francesco Sylos Labini e Stefano Zapperi, nel 2006
con il governo Prodi «c’è stato un calo del trenta per cento circa dei
finanziamenti, cosicché il già non generoso sostegno alla ricerca di
base è diminuito, da circa centotrenta a poco più di ottanta milioni di
euro, proprio nel periodo in cui al governo si è insediato lo
schieramento politico che, almeno a parole, ha sempre manifestato
un grande interesse per la ricerca».
Certo, dopo quanto avevano scritto nel programma, non sarebbe
stato chic e «progressista» avere la faccia tosta di dire che bisognava
sottrarre risorse alla scuola e all’università, e allora non l’hanno detto.
Però l’hanno fatto, eccome. Del resto, per apprezzare il grado di
interesse verso la cultura dei rappresentanti del popolo schierati (per
così dire) a sinistra, basta rivedere la puntata di Le Iene del 6 aprile
2012, nella quale la conduttrice Sabrina Nobile ha rivolto qualche
domandina di cultura generale a deputati e senatori.
La prima intervista è all’onorevole Amalia Schirru, del Partito
Democratico, componente della XI Commissione della Camera
(Lavoro Pubblico e Privato), laureata in Pedagogia. «Che cos’è una
sinagoga?» le chiede Sabrina Nobile. «È il luogo di culto che le
donne musulmane... frequentano per pregare il loro Dio.» «E che Dio
si prega in sinagoga?» incalza la conduttrice. «Maometto oppure
Allah...» «E dove si trova Gerusalemme? È capitale di quale Stato?»
«Palestina...» afferma la dottissima deputata. Seconda intervista, con
l’onorevole Marialuisa Gnecchi, sempre del Partito Democratico,
anche lei componente della XI Commissione, maturità classica. «Chi è
Netanyahu?» le chiede Sabrina Nobile. «Rappresenta l’Iran e quindi
tutto quello che...» Già, l’Iran. Se, per quanto riguarda l’attualità,
l’onorevole non è troppo ferrata, magari con la storia se la cava
meglio, deve aver pensato la conduttrice. E allora le domanda: «Chi
era Mao?» La sa, la sa... «Mao è stato il presidente della Cina e
quindi ha avuto un ruolo in termini significativi nella storia del
mondo.» Visto che la sapeva? Ma la Nobile insiste, accidenti: «In che
periodo è stato presidente Mao?» Questa è difficile, e infatti la
Gnecchi vacilla, esita, si butta, fingendo insofferenza per una
domanda fin troppo ovvia: «Ormai due secoli fa...» Infine, terza
intervista, con l’onorevole Marco Beltrandi, radicale eletto nelle liste
del Partito Democratico, attivissimo componente della Commissione
di vigilanza sulla Rai, laureato in Scienze politiche. Lui, almeno... La
conduttrice inizia con una domandina facile facile, quasi a piacere:
«Chi era Shakespeare?» E Beltrandi: «Era un celeberrimo scrittore e
drammaturgo inglese...» Oh, bravo. Ma poi Beltrandi aggiunge, non
richiesto: «Dell’Ottocento circa». Ahi, ahi, ahi, signora Longari... La
Nobile, allora, non si lascia sfuggire la preda: «Prima o seconda metà
dell’Ottocento?» E qui l’onorevole radicale sceglie la linea dell’onestà:
«Già questo mi mette qualche difficoltà [sic] perché non ho studiato
letteratura inglese...» Poverino, se non l’ha studiata... «Citiamo
qualche opera famosa di Shakespeare?» «Boh.» Magari con un
aiutino: «’Essere o non essere’» insinua la conduttrice. Così è facile,
dài... «Vabbe’, Amleto.» «Chi l’ha scritto?» «L’ha scritto
Shakespeare?» si meraviglia l’onorevole. «Sì» ammette sconsolata
Sabrina Nobile.
E con questo, per citare Totò e Peppino, abbiamo detto tutto. (O
forse no. Forse vale ancora la pena sottolineare che nel Parlamento
della scorsa legislatura c’erano meno laureati che in quello postunitario e del primo Novecento. All’Assemblea Costituente,
nonostante la guerra avesse ostacolato la frequenza all’università,
era laureato il novantadue per cento dei parlamentari: fino allo scorso
febbraio la quota si era inabissata al sessantaquattro per cento.
Almeno tra deputati e senatori, dunque, è già passata la linea
Sacconi: meno laureati. Insomma, sono finiti i tempi in cui, negli anni
Sessanta dell’Ottocento, il più grande fisico teorico inglese, James
Clerk Maxwell, lo scopritore del campo elettromagnetico, imparava
apposta l’italiano per venire a parlare, di fisica, con il ministro italiano
della Pubblica Istruzione, Carlo Matteucci. È come se oggi Stephen
Hawking inseguisse Mariastella Gelmini lungo il tunnel Ginevra-Gran
Sasso per farsi spiegare qualcosa sulle bizzarre proprietà dei
neutrini.)
Restano i «tecnici» montiani. Loro magari sanno che Shakespeare
ha scritto l’Amleto, però, a quanto pare, il problema se aumentare o
meno gli investimenti in cultura non se lo sono nemmeno posto:
hanno tagliato e basta (e non solo in ambito culturale). A volte,
crediamo, perfino con goduria e presunzione. Salvo poi accorgersi di
qualche erroruccio «tecnico» che era così grave da costringere la
lingua italiana a inventare ad hoc (latino) un nome nuovo, tipo
l’orribile «esodati».
Una prova? Prendiamo l’università. Per i «tecnici», spesso
paradossalmente insigni accademici, l’università e la ricerca non
sono una priorità del Paese, figurarsi se possono, come dovrebbero,
essere il primo punto dell’agenda politica ed economica. Infatti, la
legge di stabilità del governo Monti prevedeva solo cento milioni di
incremento per il Fondo di finanziamento ordinario delle università,
contro i quattrocento milioni necessari per il loro normale
funzionamento (da notare che questi tagli si aggiungono ai 561
milioni dei quattro anni precedenti, perciò il totale dei trasferimenti
dello Stato all’università si è ridotto in cinque anni del 12 per cento). Il
che significa – come ha detto il presidente della Conferenza dei
rettori, Marco Mancini – che molti atenei italiani non avranno nel 2013
i soldi necessari per pagare gli stipendi ai loro dipendenti e/o le
bollette ai loro fornitori e/o le borse di studio agli studenti che hanno il
torto di essere meritevoli senza essere ricchi.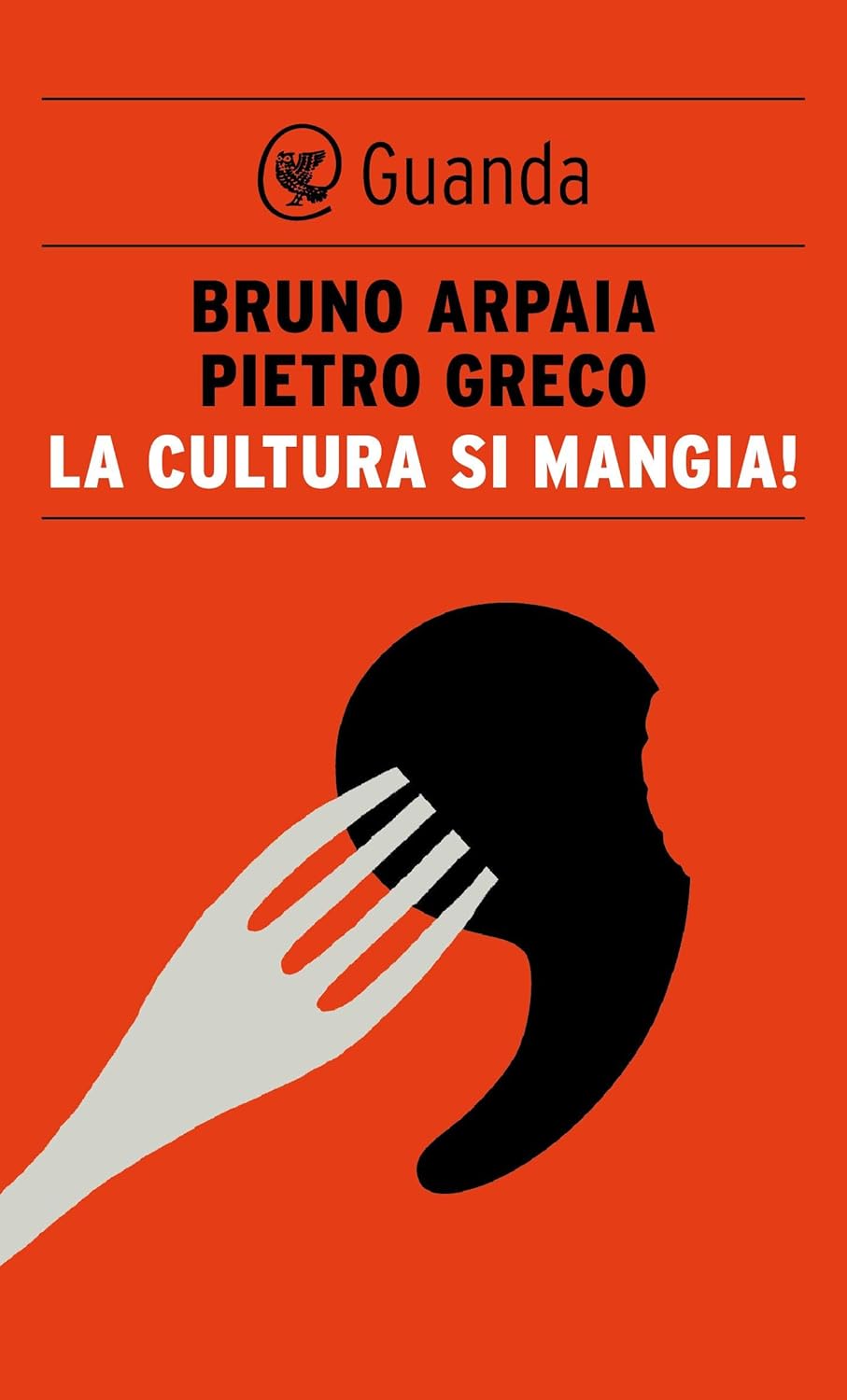






Commento all'articolo