La cultura contro il fascismo – B.Brecht & A.Breton
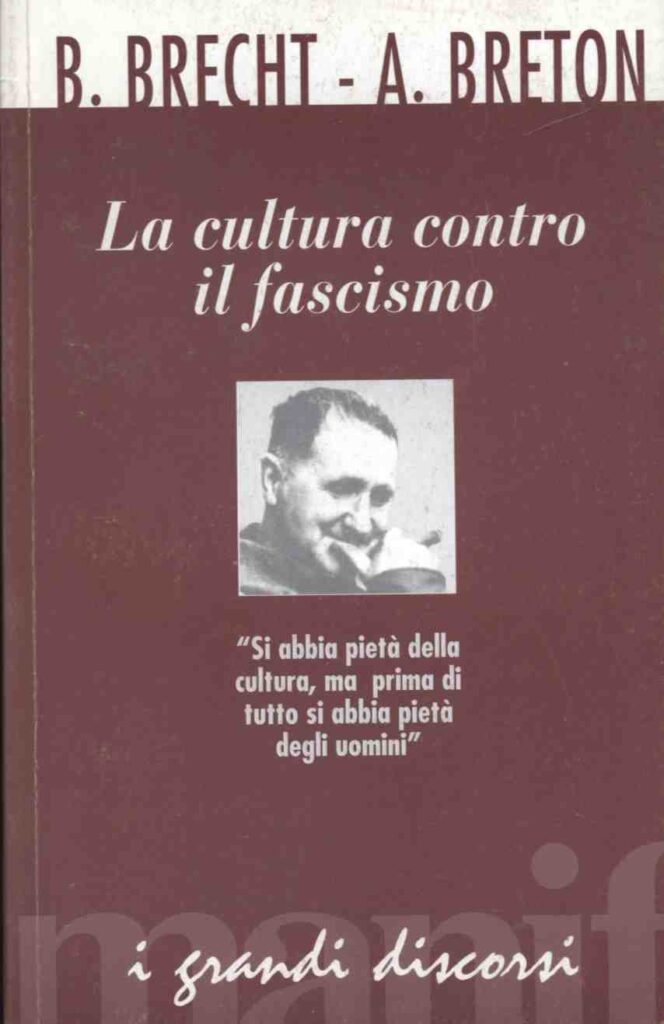
SINTESI DEL LIBRO:
Il congresso internazionale degli scrittori per la difesa della cultura,
svoltosi a Parigi nel giugno del 1935, fu un momento assai importante della
politica del nascente Fronte Popolare, mirante a raggruppare una larga
coalizione democratica contro l’avanzata del fascismo in Europa.
Contrariamente alla linea di scontro frontale, classe contro classe, che aveva
caratterizzato l’inizio degli anni ’30, la svolta impressa dal gruppo dirigente
staliniano con il VII congresso del Komintern promuoveva un’intesa
strategica fra movimento operaio e borghesia democratica contro la
minaccia hitleriana, con pesanti concessioni di ordine sociale e ideologico e
senza minimamente applicare criteri democratici all’interno delle strutture
comuniste (siamo anzi alla vigilia dei processi di Mosca e del grande
terrore, e alla testa dell’Internazionale vengono significativamente messi
anche uomini dei servizi segreti). Per uscire dall’isolamento si cercava di
attenuare il programma rivoluzionario e di staccare, per converso, il
fascismo con i suoi tratti più ripugnanti dal grembo capitalistico in cui era
nato, così da separare i «buoni» borghesi da quelli «barbari». Potremmo
parlare di un «buonismo» d’epoca, se non fosse che le vicende odierne
corrispondono a quelle di allora come la commedia alla tragedia e Veltroni e
Berlusconi sono appena una parodia di Stalin e Hitler. La strategia del
Fronte Popolare, comunque, sul piano culturale diede i risultati più
discutibili, perché lo strumentalismo emergeva smaccatamente e per di più
il perbenismo piccolo borghese dei suoi fautori più zelanti rivelava
nitidamente i vizi tanto degli alleati borghesi di Stalin quanto delle nuove
classi emergenti nel socialismo reale.
Nel coro volenteroso, prefabbricato ma anche in buona fede del
Congresso stridono dissonanti due voci, abbastanza diverse fra loro: quelle
di Bertolt Brecht e di André Breton. Un oppositore interno dello stalinismo
con profonda e quasi patologica vocazione alla dissimulazione onesta, il
primo, un «provocatore» abituale il secondo, allora e ancor più negli anni
seguenti impegnato a flirtare con l’opposizione trotskista (fino al Manifesto
per un’arte rivoluzionaria indipendente del 1938, redatto in Messico con
Trotsky esule e Diego Rivera). Due «cattivi» maestri che hanno lasciato
un’impronta decisiva (il primo come autore, il secondo forse più come
inventore e organizzatore) nella cultura contemporanea, assai di più dello
scolorito corteo di intellettuali sfilati ossequiosi a quel Congresso.
Brecht prende il toro per le corna: non c’è una «barbarie» contro cui
proclamare una crociata dei «civilizzati», ci sono interessi di classe che a
volte vengono difesi con inconsueta brutalità. Occorre allora «parlare dei
rapporti di proprietà», che sono alla base delle pratiche fasciste, senza
illudersi che l’atrocità dei metodi susciti automaticamente indignazione e
ribellione. I delitti che si moltiplicano diventano anzi invisibili (nello stesso
senso della burocratizzazione del crimine che sarà poi ampiamente
tematizzato da H. Arendt). Il nazismo lo confermerà ad abbondanza. Ma
anche la cronaca contemporanea. Dopo alcuni anni di guerra civile nella exJugoslavia sappiamo fin troppo bene che molte violenze, stupri e
ammazzamenti producono soltanto assuefazione e noia di massa, al di là dei
proclami scandalizzati e a volte autopromozionali degli intellettuali. Ma su
scala meno tragica sappiamo anche l’inutilità della difesa di uno stile
argomentativo e razionale contro la «volgarità» della demagogia magari
televisiva. Esattamente come profetizzava Brecht, la risposta sarà l’apologia
della volgarità, l’irrisione dei visi pallidi bravi solo a macerarsi e disquisire.
La comprensione dei bisogni, degli interessi, delle forme di vita concrete è
sempre la strada più valida per contrastare i valori barbari, non la
contrapposizione astratta della cultura alla barbarie. «Si abbia pietà per la
cultura ma prima di tutto si abbia pietà degli uomini! La cultura è salva
quando gli uomini sono salvi». Aggiungiamo che, altrimenti, la vendetta
arriverà immancabile sotto forme dell’esaltazione della «gente», gli uomini
separati dalla cultura e a essa restituiti come nemici sbracati e ammiccanti.
La volgarità post-fascista, come la crudeltà fascista, non è mai innecessaria.
Fascisti e post-tali sono a loro modo veraci. Stupido e ingannevole è chi
accarezza l’albero e non gradisce i frutti. Resterebbe forse da domandarsi se
il contagio e la mistificazione lasci aree indenni, bisogni legittimi. Nella sua
costitutiva ambiguità Brecht sapeva bene, d’altronde, in cosa consisteva la
vendita di inganni: a L.A., Hollywood come a Berlin, Mitte. Nel primo caso
lo ha confessato spudoratamente, nel secondo si è affidato al fragoroso
silenzio degli inediti.
Più lineare e politicamente didattico è invece l’intervento scritto da
Breton e pronunciato materialmente da P. Eluard per ragioni di opportunità,
dopo un aspro scontro fra lo stesso Breton e I. Ehrenburg. Lo sfondo
immediato della polemica è dato dall’accordo Laval-Stalin e dal patto di
assistenza franco-sovietico che, ispirato da motivi classicamente geopolitica
di accerchiamento della Germania, aveva comportato
un appeasement ideologico nei confronti dell’imperialismo democratico
(come in senso inverso avverrà quattro anni più tardi con il patto HitlerStalin nei confronti di quello nazista, scatenando le reazioni di un Nizan o
di un Terracina). Ne era derivata anche una ricaduta nazional-culturale in
particolare rispetto alla letteratura francese contro cui si accende
l’indignazione dei surrealisti, che proclamano «non amiamo la nostra
patria» e mantengono l’idea di combattere il nemico in primo luogo
all’interno del proprio paese, scartando qualsiasi rigurgito antiboches. L’atteggiamento verso il «patrimonio culturale» è già
benjaminiano; vi si aggiunge che, come Benjamin rifiutava la boria
culturale tedesca e dichiarava il suo amore alla Francia di Proust e Valéry,
così Breton respinge lo sciovinismo piccolo-borghese e rivendica
provocatoriamente il valore della filosofia tedesca (Marx e Freud). Della
tradizione francese si difende e si pretende di tramandare alla cultura
proletaria e rivoluzionaria la parte «cattiva» (brechtianamente diremmo il
cattivo che è il nuovo): Sade, Baudelaire, Lautréamont e Rimbaud. Di
quest’ultimo si rifiuta un’annessione biografica (la partecipazione
occasionale alla Comune di Parigi), ma si esige un riconoscimento in nome
dell’ampliamento rivoluzionario della coscienza che la sua poesia
comporta. Diventa allora emblematico non questo e quel riferimento
testuale agli oppressi (soggetto del resto a rinnegamenti e oblio
nell’avventurosa vita successiva del poeta), ma piuttosto il fatto che la
celebre «lettera del veggente», dove si proclama lo «sregolamento di tutti i
sensi» sia scritta al culmine della resistenza comunarda.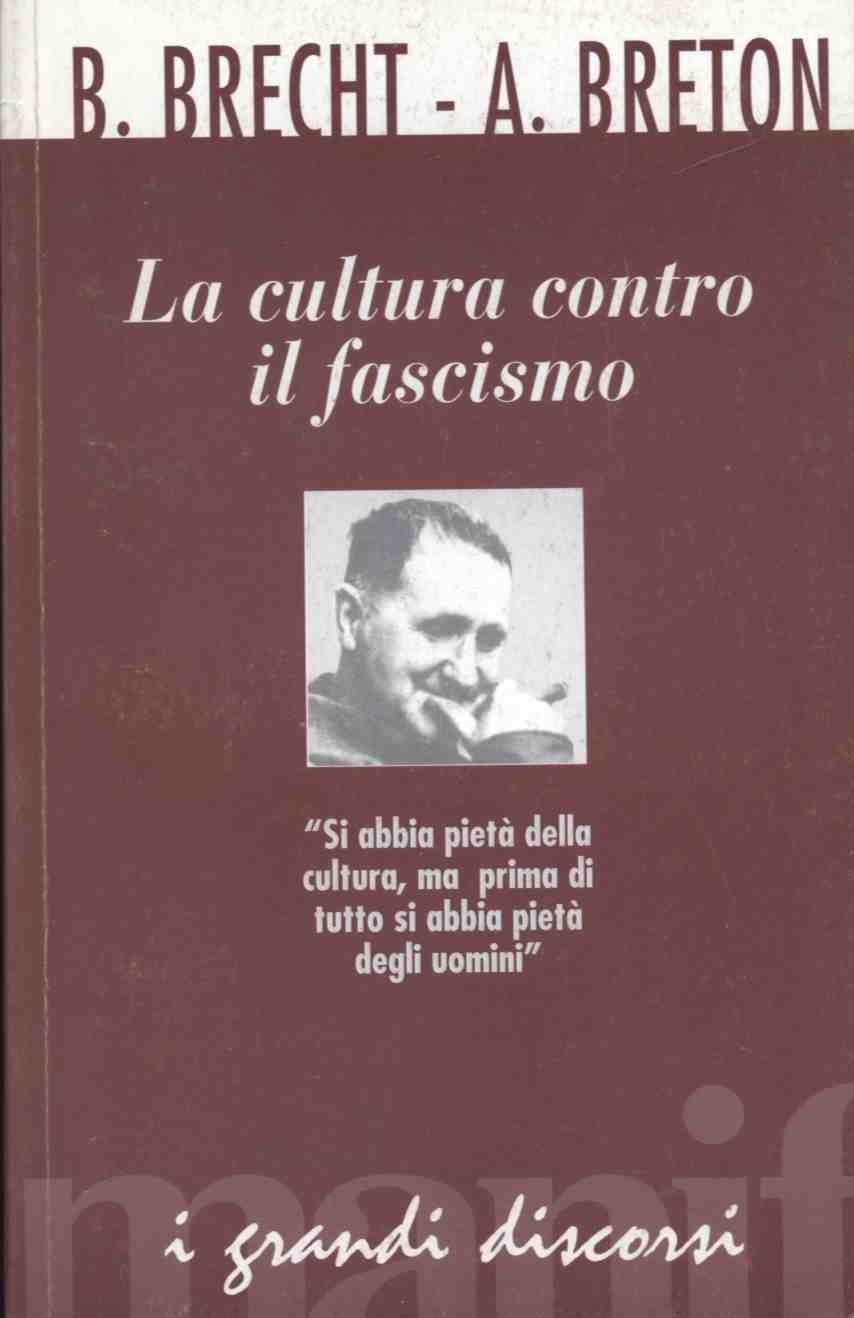






Commento all'articolo