Io e Kostas Charitos – Petros Markaris
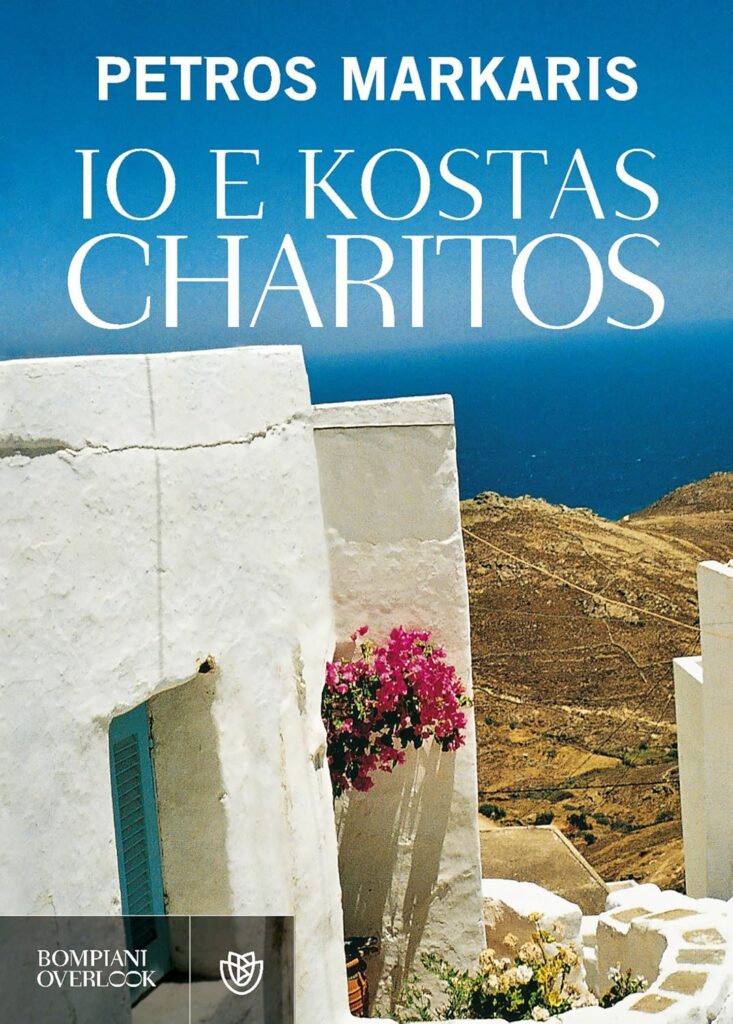
SINTESI DEL LIBRO:
Non ho messo i versi di Brecht all’inizio di questo libro solo perché mi
piacciono, ma perché in un certo senso ricalcano la mia vita di narratore. Ho
cominciato a scrivere romanzi a cinquantotto anni, non esattamente con il
mio ultimo respiro, ma di sicuro dopo essermi avviato in quella direzione;
però credo (perché mi piace e perché mi fa comodo) anche nella frase di
Marx secondo cui la distanza più breve tra due punti può essere, talvolta, una
linea curva. D’altro canto, so molto bene che “l’acqua che ho versato nel
vino” non posso recuperarla. Convivo abbastanza tranquillamente con questa
verità, senza compatirmi e senza sospiri e lacrime del tipo: “Ah, quell’errore
di allora, l’ho pagato assai caro!”
Non sarei mai arrivato al romanzo se non mi si fosse presentato dinnanzi il
commissario Kostas Charitos. Quale che sia il mio successo come
romanziere, lo devo innanzi tutto a lui. Ci sono personaggi che ti balzano
davanti all’improvviso quando non ne avevi neanche mai sospettato
l’esistenza. Assomigliano a quei parenti che un bel giorno sbucano dal nulla e
ti dicono: “Io sono quel cugino di tuo padre che era partito a vent’anni per il
Canada”, oppure: “Io sono tua sorella da parte di padre e sono cresciuta con
mia madre in Crimea.” Di solito, questi parenti fino a quel momento
sconosciuti si affrontano come un ulteriore peso piombatoci sulle spalle senza
preavviso. Non bastava la famiglia, a cui già ci lega una serie di obblighi e
qualche divergenza: ora dobbiamo anche sobbarcarci questo parente
sconosciuto venuto da chissà dove. Come dice Brecht nella sua Santa
Giovanna dei Macelli: “È come chiedere ad Atlante, che ha già il mondo
sulle spalle, di caricarsi anche una seggiola.” Il parente venuto dal nulla è la
seggiola. Ma non voglio essere meschino. Ci sono sempre eccezioni. Con
alcuni di questi parenti, ospiti non invitati, ti senti subito a tuo agio e ti spiace
di non averli conosciuti prima. E non è né la relazione di parentela, né
tantomeno quella del sangue a fare da collante, quanto piuttosto l’alchimia
del primo sguardo.
Con Charitos non è successo niente del genere. Mi è sbucato davanti
nell’autunno del 1993. Era il terzo anno della serie televisiva Anatomia di un
delitto, di cui, svogliatamente, scrivevo la sceneggiatura, braccato dalle
scadenze. All’improvviso, si è materializzata nel mio studio una famiglia
formata da tre persone: padre, madre e figlio. Una tipica famiglia greca, di
quelle che si possono incontrare in qualunque quartiere piccoloborghese di
Atene – Kypseli, Ambelokipi, Turkovounia, Viron. Il mio primo pensiero è
stato quello di mandarli tutti al diavolo e buonanotte. La classica reazione di
fronte al parente ignoto e inatteso: lo vorresti mandar via, anche per evitare
qualche sgradita sorpresa. E più o meno così mi sono sentito con Charitos.
Avrei voluto liberarmi di lui perché temevo le sue origini piccoloborghesi. La
letteratura, il teatro, il cinema e la televisione sono pieni di piccoloborghesi e
di famiglie piccoloborghesi: che cosa avrei potuto aggiungere io? E, a parte
questo, gli scrittori e gli artisti si sentono, di solito, a disagio con i parenti
piccoloborghesi e preferiscono tenerli a distanza. Si può fare qualche
eccezione per le feste, ma anche in questi casi esistono i telefoni, i fiori e,
ultimamente, gli sms.
Quell’uomo, però, apparteneva alla categoria dei parenti assillanti: quelli
che ogni giorno lasciano un messaggio sulla segreteria telefonica per chiedere
quando ci si vede. E alla fine ho detto anch’io quel che diceva il mio povero
papà: “È solo un’anima che deve andarsene: che se ne vada e non ne
parliamo più.”
Ecco come è andato il mio primo contatto con Charitos. Entravo nello
studio e lo trovavo lì, pronto a martellarmi il cervello. In capo a un mese la
sua presenza si era trasformata in una tortura quotidiana. Non riuscivo a
concentrarmi sulla sceneggiatura, che in ogni caso scrivevo di malavoglia, e
ogni sforzo per farlo sloggiare – con le buone o con le cattive – falliva
miseramente. Una mattina, durante uno dei miei disperati tentativi di
mandarlo al diavolo ebbi un’illuminazione: per tormentarmi così, questo tale
non poteva che essere un dentista o uno sbirro.
Fu la prima volta che pensai che Charitos potesse essere un poliziotto. Fino
a quel momento avevo visto davanti a me un pater familias senza altre
particolari caratteristiche. Ma non appena mi resi conto che l’uomo che mi
tormentava era un poliziotto, tutti gli altri elementi che lo avrebbero
caratterizzato cominciarono ad andare a posto da soli. Subito scoprii che lui si
chiamava Kostas Charitos e sua moglie Adriana. E con la stessa
immediatezza scoprii che i due avevano una figlia, Caterina, che faceva il
dottorato di ricerca all’Università Aristoteleion di Salonicco.
L’unica cosa che ho dovuto scoprire, in effetti, è stato dove abitava.
Mentre all’inizio avevo disdegnato i quartieri della piccola borghesia, ora che
conoscevo meglio lui e la sua famiglia, capivo di dover andare a cercare
proprio da quelle parti. La mia decisione aveva anche a che fare con la mia
famiglia – ma di questo parleremo più tardi. Ho scelto quindi via
Aristokleous, ai confini del quartiere PangratiViron, e lì ho collocato
l’appartamento della famiglia Charitos. È una stradina stretta e corta, senza
nessuna caratteristica particolare, come del resto non ne hanno i Charitos. Se
li incontraste casualmente per strada, passereste oltre, indifferenti.
La mia esperienza, tuttavia – un’esperienza che in gran parte ho acquisito
studiando, da traduttore, i lavori degli altri scrittori – mi aveva insegnato che
nessun personaggio troppo compatto è perfettamente convincente. I caratteri
tutti d’un pezzo sono spesso noiosi e poco interessanti. In altre parole, anche
l’eroe più incolore e inodore ha bisogno di un’incrinatura, di qualcosa di
diverso che gli permetta di distinguersi. Charitos, di incrinature, ne ha due:
innanzi tutto la sua automobile, la famosa Fiat 131 Mirafiori.
Gran parte delle domande che mi vengono fatte quando parlo in pubblico
di lui verte proprio sulla sua Mirafiori. Una Hyundai, una Nissan o una Opel
sarebbero state perfettamente adeguate al carattere e alla condizione sociale
di Charitos. Ma la Mirafiori? I più giovani non sanno neanche di che
macchina si tratta. I più anziani la conoscono, ma si chiedono da dove l’ho
tirata fuori. Una mia amica italiana una volta mi ha detto: “Può darsi che ce
ne sia qualche esemplare al museo degli Agnelli a Torino, ma in Italia
neanche i clandestini vanno più in giro in Mirafiori.”
In Grecia, poi, la Mirafiori non ha mai avuto un gran successo. Di
conseguenza, accetto la domanda che trovo giustificata: ma come ti è venuta
in mente? Sembrerà incredibile, ma l’idea proviene in parte dal mio
soggiorno in Libia, e mi spiego subito. Dalla metà degli anni sessanta fino
alla metà degli anni settanta ho lavorato nel settore esportazioni del
cementificio Titan. In quel periodo, la Grecia vendeva molto cemento alla
Libia e io, di tanto in tanto, dovevo recarmi a Tripoli o a Bengasi. In
entrambe le città circolavano quasi esclusivamente Fiat, e tra le Fiat,
soprattutto le Mirafiori: non era possibile attraversare la strada senza
imbattersi in una Mirafiori parcheggiata o in movimento. Per cui, quando mi
sono chiesto quale auto potesse accordarsi con Charitos, davanti ai miei occhi
è tornata in vita la Mirafiori.
Questa è la spiegazione che per un certo periodo ho dato a chi mi chiedeva:
“Ma perché proprio la Mirafiori?” Dentro di me, però, non ne ero del tutto
soddisfatto. Sentivo che si trattava della “mia” spiegazione, non di quella di
Charitos. Alla fine è stato proprio Charitos a fornirmi la sua versione nel
quarto romanzo di cui è protagonista, La lunga estate calda del commissario
Charitos,
1 dove spiega al suo assistente, Vlasopoulos, in una conversazione
al campo di canottaggio olimpico di Spata, nei dintorni di Atene, perché non
si separa mai dalla Mirafiori.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :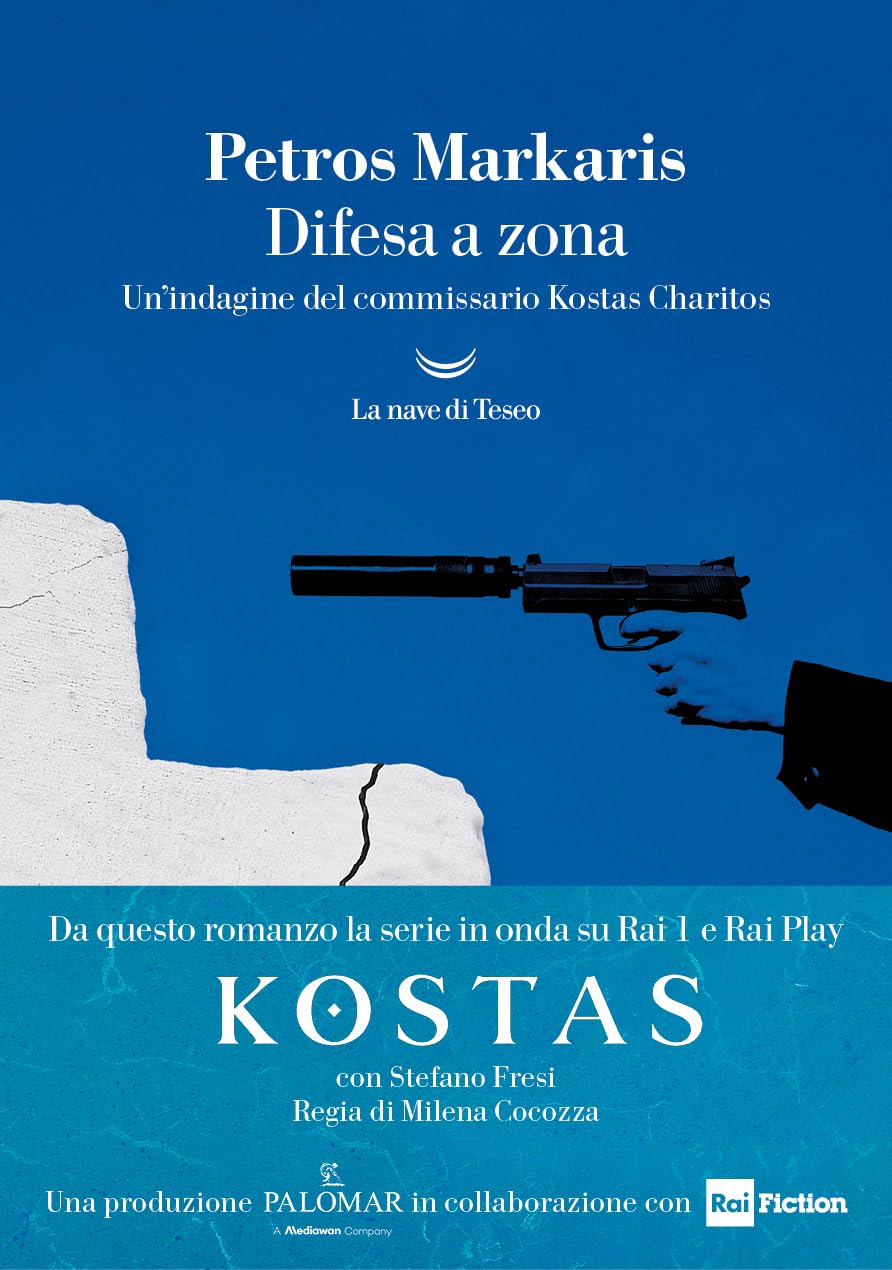






Commento all'articolo