Il sognatore – Laini Taylor
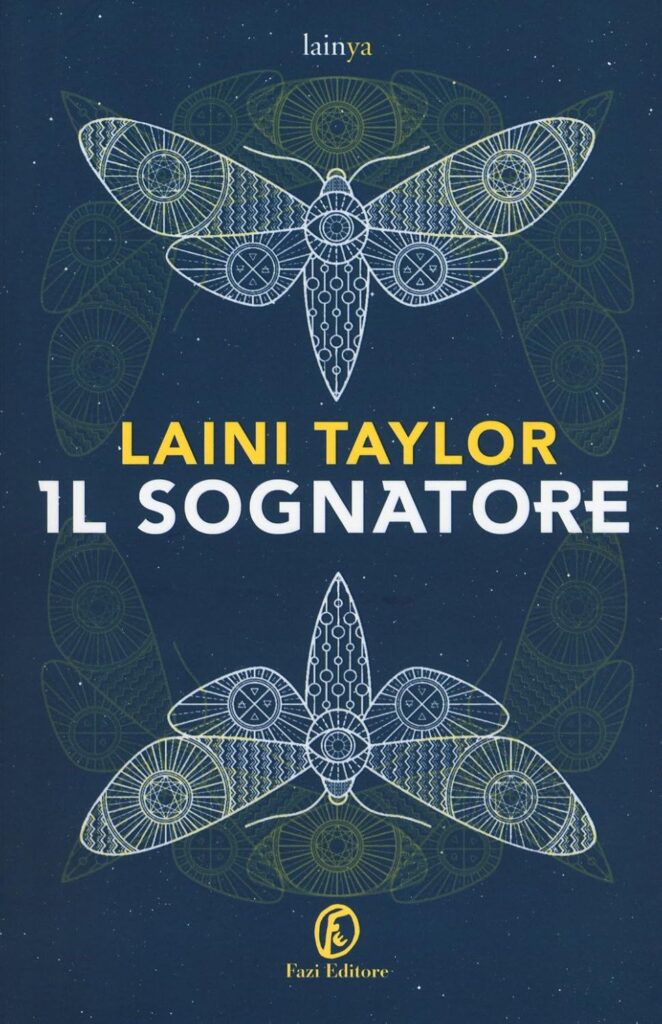
SINTESI DEL LIBRO:
È possibile che i nomi vengano
dimenticati o perduti. Nessuno lo
sapeva meglio di Lazlo Strange.
Dapprincipio aveva avuto un altro
nome, ma quello era morto come
una canzone che nessuno canta più.
Forse era stato un antico nome di
famiglia, lustrato dall’uso di
generazioni. Forse gli era stato dato
da qualcuno che lo amava. A lui
piaceva pensarlo, ma non ne aveva
idea. Tutto quello che aveva era
Lazlo e Strange – Strange perché era
questo il nome attribuito a tutti i
trovatelli del regno di Zosma, e
Lazlo perché così si chiamava lo zio
senza lingua di un monaco.
«Gliela tagliarono nella prigione
di una galea», gli disse fratello
Argos, quando Lazlo fu abbastanza
grande per capire. «Era un uomo dal
silenzio inquietante e tu eri un
bimbo dal silenzio inquietante, e
così mi è venuto in mente: Lazlo.
Quell’anno dovetti battezzare
talmente tanti bambini che seguii
qualsiasi idea mi venne in mente».
Poi aggiunse, come se ci riflettesse
ancora: «Comunque non pensavo
che saresti sopravvissuto».
Quello fu l’anno in cui Zosma
cadde in ginocchio e perse il sangue
di tanti uomini in una guerra inutile.
La guerra, certo, non si accontentò
dei soldati. Vennero bruciati i campi;
saccheggiati i villaggi. Bande di
contadini senza più casa vagavano
nelle campagne bruciate lottando
contro i corvi per spigolare i resti.
Ne morirono talmente tanti che i
carri di solito destinati a trasportare i
ladri alla forca, vennero destinati a
portare gli orfani nei conventi e nei
monasteri. Arrivavano, a sentire i
monaci, come un carico di agnelli, e
degli agnelli avevano la stessa
inconsapevolezza riguardo le loro
origini. Alcuni, per lo meno, erano
abbastanza grandi da conoscere i
propri nomi, ma Lazlo era soltanto
un neonato, e malato, per giunta.
«Grigio come la pioggia, eri»,
disse fratello Argos. «Pensavo che
di sicuro saresti morto, ma mangiavi
e dormivi e con il tempo il tuo
colore si fece normale. Non hai
pianto mai, nemmeno una volta, il
che era una cosa innaturale, ma
proprio per questo ci piacevi di più.
Nessuno di noi si è fatto monaco per
diventare una bambinaia».
Allora il piccolo Lazlo ribatté,
con l’anima in fiamme: «E nessuno
di noi è nato per diventare orfano».
Tuttavia lui era un orfano, e uno
Strange, e per quanto fosse incline
alla fantasia, non si fece mai nessuna
illusione su questo. Sin da bambino
capì che non ci sarebbe stata alcuna
rivelazione. Nessuno sarebbe venuto
a prenderlo e lui non avrebbe mai
conosciuto il suo vero nome.
E forse è per questo che il mistero
della città di Pianto lo catturò così
completamente.
In realtà i misteri erano due: uno
antico, uno nuovo. Quello antico gli
aprì la mente, ma fu quello nuovo a
farsi strada dentro di lui, a compiere
lenti giri circolari e finalmente ad
assestarsi con un grugnito – come un
drago soddisfatto in una comoda
tana nuova. E lì sarebbe rimasto – il
mistero nella sua mente – esalando
enigmi per gli anni a venire.
Aveva a che fare con un nome e
con la scoperta che, oltre a essere
stati persi o dimenticati, I misteri
potevano anche essere stati rubati.
Aveva cinque anni quando
accadde, un trovatello dell’abbazia
di Zemonan, ed era sgattaiolato nel
vecchio frutteto infestato da
sparvieri e insetti per giocare da
solo. L’inverno era appena iniziato.
Gli alberi erano neri e spogli. I suoi
piedi rompevano una crosta
ghiacciata a ogni passo e gli sbuffi
del suo fiato lo accompagnavano
come un amico fantasma.
Suonò l’Angelus, la voce bronzea
della campana si riversò nell’ovile e
oltre le mura del frutteto in ondate
ricche e lente. Era una convocazione
alla preghiera. Se non fosse rientrato
l’avrebbe persa, e se l’avesse persa
lo avrebbero frustato.
Lazlo non rientrò.
Trovava continuamente dei modi
per svignarsela per fatti suoi, e le
sue gambe erano perennemente
segnate dalla verga di nocciolo che
pendeva da un gancio con il suo
nome scritto sopra. Ne valeva la
pena. Scappare via dai monaci, dalle
regole, dai doveri e da una vita che
lo pressava come un paio di scarpe
strette.
Per giocare.
«Tornate indietro adesso, se
sapete cosa è meglio per voi»,
intimava a dei nemici immaginari.
Teneva una “spada” in ogni mano:
neri rami di melo con le estremità
tozze avvolte nello spago per farne
delle else. Lazlo era un trovatello
smunto e denutrito, con la testa
piena di tagli provocati dai monaci
che la rasavano per prevenire i
pidocchi, ma aveva un
atteggiamento di raffinata solennità
e non c’era alcun dubbio che nella
sua mente, in quel momento, lui si
considerasse un guerriero. E non un
guerriero qualsiasi, ma un
Tizerkane, i più feroci mai esistiti.
«Nessuno straniero», diceva ai suoi
avversari, «ha mai posato gli occhi
sulla città proibita. E finché io
respirerò, nessuno lo farà mai».
«Allora siamo fortunati»,
rispondevano i nemici, e per Lazlo
erano più reali loro, nella luce del
tramonto, dei monaci i cui canti
dall’abbazia scendevano giù per la
collina. «Perché non respirerai
ancora per molto».
Gli occhi grigi del bambino si
stringevano come due fessure.
«Pensate di poter battere me?».
Gli alberi neri cominciavano a
danzare. Il suo respiro usciva in
rapidi sbuffi che si rincorrevano uno
dietro l’altro. La sua ombra si
stendeva enorme di fronte a lui e
nella sua mente si affacciavano
antiche guerre ed esseri alati, una
montagna fatta di ossa fuse di
demoni e la città che sorgeva
dall’altra parte… una città che era
scomparsa nella nebbia del tempo.
Questo era il mistero antico.
Ne era venuto a conoscenza da un
monaco anziano, fratello Cyrus. Era
malato e gli orfani avevano il
compito di portargli i pasti. Non era
un uomo gentile. Non era una figura
paterna, né un mentore. Aveva una
presa formidabile ed era noto perché
aveva l’abitudine di afferrare i
bambini per il polso e di tenerli lì
per ore, obbligandoli a ripetere un
catechismo sconclusionato e a
confessare ogni genere di malvagità
che loro riuscivano a malapena a
comprendere, figuriamoci se
potevano averla commessa. Erano
tutti terrorizzati da lui e dalle sue
nodose mani rapaci e i bambini più
grandi, lungi dal proteggere i
piccoli, li mandavano nella tana del
vecchio al posto loro. Lazlo era
spaventato come gli altri, eppure si
offriva di portare tutti i pasti.
Perché?
Perché fratello Cyrus raccontava
storie.
All’abbazia le storie non erano
viste di buon occhio. Come minimo,
distraevano dalla contemplazione
spirituale. Nel peggiore dei casi
onoravano falsi dèi e covavano il
peccato. Ma fratello Cyrus aveva
oltrepassato simili restrizioni. La sua
mente aveva ormai mollato gli
ormeggi e preso il largo. Sembrava
che non sapesse mai dove si trovava
e quello stato confusionale lo faceva
infuriare. Il viso gli diventava
sempre più rosso e teso. Una pioggia
di sputi accompagnava le sue
invettive. Ma aveva anche dei
momenti di calma: quando
sgattaiolava in qualche porta
nascosta della memoria e tornava
alla sua infanzia e alle storie che gli
raccontava sempre la nonna. Non
riusciva a ricordare i nomi degli altri
monaci, né le preghiere che per
decenni erano state il suo mestiere,
ma le storie gli fluivano dalla bocca
e Lazlo le ascoltava. Ascoltava con
l’avidità di un cactus che beve la
pioggia.
Nella parte meridionale e
orientale del continente di Namaa –
molto, molto lontano dal
settentrionale regno di Zosma –
c’era un vasto deserto chiamato
Elmuthaleth, il cui attraversamento
era un’arte perfezionata da pochi e
ferocemente custodita contro tutti gli
altri. Da qualche parte, in
quell’immenso vuoto, sorgeva una
città che nessuno aveva mai visto.
Era una diceria, una leggenda, ma
era una diceria e una leggenda da cui
arrivavano meraviglie portate dai
cammelli attraverso il deserto per
infiammare le fantasie delle genti di
tutto il mondo.
La città aveva un nome.
Gli uomini che conducevano i
cammelli, che portavano le
meraviglie, pronunciavano il nome e
raccontavano le storie, così il nome
e le storie si fecero strada, insieme
alle meraviglie, fino a terre lontane
dove evocavano visioni di cupole
luccicanti e candidi cervi
addomesticati, donne talmente belle
da confondere la mente e uomini
con scimitarre di una lucentezza
abbagliante.
Fu così per secoli. Intere ali dei
palazzi signorili erano dedicate alle
meraviglie e interi scaffali delle
biblioteche alle storie. I mercanti si
arricchirono. Gli avventurieri si
fecero più audaci e andarono da soli
in cerca della città. Nessuno tornò.
La città era interdetta ai faranji – gli
stranieri – che, se sopravvivevano
alla traversata dell’Elmuthaleth,
venivano giustiziati come spie. Non
che questo impedisse loro di tentare.
Proibisci qualcosa a un uomo e lui la
desidererà come se fosse la salvezza
della sua anima, ancora di più poi se
è la fonte di incomparabili
ricchezze.






Commento all'articolo