Il serpente dell’Essex – Sarah Perry
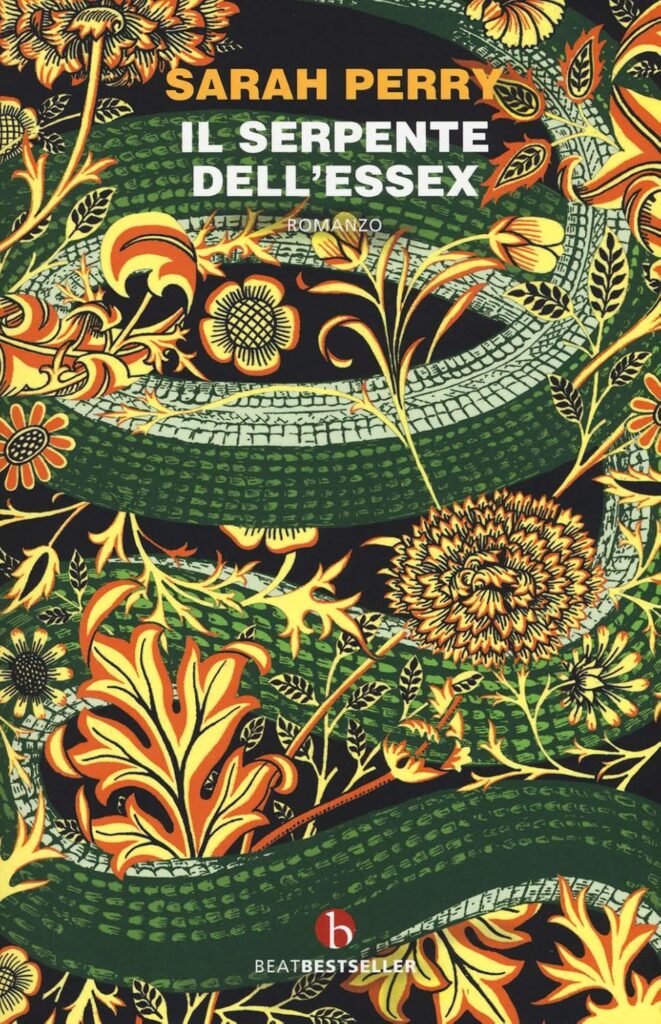
SINTESI DEL LIBRO:
L’una in punto di una giornata cupa e uggiosa, e la palla segnatempo
dell’Osservatorio di Greenwich venne lasciata cadere come di consueto, per
comunicare l’ora alle navi. C’era del ghiaccio sul meridiano più importante, e
così pure sul cordame delle larghe chiatte sul Tamigi fitto di traffici. I
comandanti annotarono ora e marea e issarono le vele rosso sangue per
sfruttare il vento proveniente da nordest; un carico di ferro era diretto alla
fonderia di Whitechapel, dove le campane rintoccavano per cinquanta volte
sull’incudine come se il tempo stesse per finire. C’era chi il tempo lo vedeva
trascorrere entro i confini della prigione di Newgate, e chi, come i filosofi, lo
sprecava nei caffè sullo Strand; chi lo perdeva desiderando rivivere i bei
tempi andati, chi lo disprezzava, aspettando solo che il presente diventasse
passato. Arance e limoni suonavano le campane di St Clement’s, mentre la
campana delle votazioni di Westminster restava muta.
Il tempo era denaro al Royal Exchange, dove gli uomini passavano il
pomeriggio guardando calare le loro speranze di far passare cammelli
attraverso la cruna di un ago, e negli uffici di Holborn Bars l’ingranaggio
dell’orologio principale faceva suonare i suoi dodici orologi schiavi. Gli
impiegati sollevarono lo sguardo dai libri mastri e con un sospiro li
abbassarono di nuovo. In Charing Cross Road il tempo aveva abbandonato il
suo tradizionale cocchio per salire su autobus e taxi che percorrevano la via
in frenetiche flotte, e nelle corsie di Barts e del Royal Borough la sofferenza
trasformava i minuti in ore. Nella cappella di Wesley cantavano The sands of
time are sinking augurandosi che le sabbie del tempo affondassero più
rapidamente, mentre a qualche metro da lì, in Bunhill Fields, il ghiaccio sulle
tombe cominciava a sciogliersi.
A Lincoln’s Inn e a Middle Temple gli avvocati guardavano i calendari e
vedevano scadere termini di prescrizione; nelle stanze di Camden e
Woolwich il tempo era crudele con gli amanti, che si domandavano perché
passasse tanto in fretta, per rallentare d’improvviso quando tornavano ai
dolori della vita quotidiana. Per tutta la città, nelle case a schiera e nei
caseggiati, nell’alta società e nelle classi umili e medie, il tempo trascorreva e
veniva sperperato. C’era chi lo centellinava e chi sperava solo che passasse; e
intanto cadeva una pioggia ghiacciata.
A Euston Square e Paddington le stazioni della metropolitana accoglievano
i passeggeri che vi si riversavano come materiale grezzo da triturare, lavorare
e colare negli stampi. In una carrozza della Circle Line, direzione ovest, le
luci intermittenti mostravano che il Times non aveva nulla di buono da
raccontare, e nel corridoio da una borsa si rovesciò della frutta marcia. Si
sentiva l’odore della pioggia sugli impermeabili, e tra i passeggeri, con il viso
affondato nel colletto, il dottor Luke Garrett stava recitando a memoria le
parti del cuore umano: «Ventricolo sinistro, ventricolo destro, vena cava
superiore» diceva, contando sulle dita, nella speranza che la litania placasse il
battito ansioso del suo cuore. L’uomo accanto a lui sollevò lo sguardo,
sgomento, e poi con una scrollata di spalle si voltò. «Atrio sinistro, atrio
destro» continuò Garrett, sottovoce: era abituato allo scrutinio degli estranei,
ma non vedeva il motivo di attirarlo quando non era necessario. Lo
chiamavano “Piccola Peste”, per la sua bassa statura e per quell’abitudine di
camminare a grandi passi, con un’andatura veloce e nervosa, come se da un
momento all’altro potesse balzare sul davanzale di una finestra. Attraverso il
cappotto si intravedeva nelle sue membra una sorta di forza pressante, e la
fronte sporgente sembrava contenere a stento la vastità e la ferocia del suo
intelletto. Sotto la lunga frangia, nera come l’ala di un corvo, gli occhi erano
scuri. Aveva trentadue anni: era un chirurgo, e aveva una mente affamata e
ribelle.
Le luci si spensero e si riaccesero, la sua destinazione si avvicinava. Era
atteso al funerale di un paziente, e nessun uomo aveva mai indossato un abito
a lutto con tanta leggerezza. Michael Seaborne era morto sei giorni prima per
un cancro alla gola, e aveva sopportato la malattia che l’aveva consumato e le
attenzioni del dottore con pari disinteresse. Tuttavia non era al morto che
andavano adesso i pensieri di Garrett, ma alla vedova, che (pensò, con un
sorriso) forse si stava spazzolando i capelli in disordine, o aveva scoperto che
all’abito nero buono mancava un bottone.
Mai aveva visto una persona comportarsi più stranamente di Cora
Seaborne di fronte alla scomparsa di un familiare… Del resto, aveva capito
fin dal primo istante in cui aveva messo piede nella residenza di Foulis Street
che in quella casa c’era qualcosa di bizzarro. Nelle stanze dai soffitti alti
aveva percepito un’atmosfera di disagio e inquietudine che poco aveva a che
fare con la malattia. A quel tempo le condizioni del paziente erano ancora
discrete, sebbene portasse una cravatta che faceva anche da benda. Era
sempre invariabilmente di seta chiara, e spesso era coperta di macchie:
considerato quant’era schizzinoso quell’uomo, era impossibile che non se ne
rendesse conto, e Luke nutriva il sospetto che volesse solo mettere a disagio
chi andava a fargli visita. Sembrava molto alto a causa dell’estrema
magrezza, e parlava talmente piano che bisognava avvicinarsi per sentire
quello che diceva. La sua voce era ridotta a un sibilo. Aveva modi compiti, e
le unghie tinte di blu. Aveva sopportato il primo consulto tranquillamente,
rifiutando la proposta di un intervento chirurgico. «Intendo andarmene da
questo mondo così come ci sono arrivato» aveva detto, accarezzando la seta
intorno alla gola. «Senza cicatrici».
«Non c’è bisogno di soffrire» gli aveva detto Luke, offrendo una
consolazione non richiesta.
«Soffrire!» L’idea evidentemente lo divertiva. «Esperienza istruttiva, non
ne dubito» aveva detto, e poi aveva aggiunto, quasi il pensiero fosse scaturito
naturalmente dall’altro: «Avete già conosciuto mia moglie?»
Garrett ripensava spesso al primo incontro con Cora Seaborne, anche se,
alla luce di ciò che era avvenuto in seguito, non c’era da fidarsi troppo della
sua memoria. La donna era arrivata in quel momento, quasi il marito le
avesse dato l’imbeccata, e si era fermata sulla porta a scrutare l’ospite. Poi
aveva attraversato il tappeto e si era chinata per dare un bacio al consorte, e in
piedi dietro la sua sedia gli aveva teso la mano. «Charles Ambrose dice che
voi siete l’unico che possa guarirlo. Mi ha fatto leggere il vostro articolo sulla
vita di Ignaz Semmelweis: se incidete e tagliate con la precisione con cui
scrivete, camperemo tutti in eterno». Impossibile resistere alle facili lusinghe,
e Garrett non aveva potuto fare altro che ridere, chinandosi sulla mano che lei
gli stava porgendo. La signora aveva una voce profonda, e all’inizio aveva
creduto di cogliervi l’accento nomade di chi non ha mai vissuto a lungo in un
paese; ma in realtà si trattava di una lieve difficoltà di linguaggio, che lei
superava indugiando su talune consonanti. Era vestita di grigio, e in modo
semplice, ma la stoffa della gonna brillava come il collo di un piccione. Era
alta, e non esile, gli occhi grigi come il suo abito.
Nei mesi successivi, Garrett aveva imparato a comprendere in parte il
disagio che si respirava in Foulis Street insieme all’odore di legno di sandalo
e di tintura di iodio. Michael Seaborne, anche nei momenti di dolore più
atroce, esercitava un influsso maligno che aveva ben poco a che fare con il
potere solitamente esercitato da un infermo. Sua moglie, sempre pronta con
panni freschi e buon vino, disponibile a imparare come si infilava un ago in
vena, sembrava aver mandato a memoria fino all’ultima sillaba un manuale
sui doveri della donna. Ma tra Cora e il consorte Garrett non aveva mai visto
nulla che somigliasse all’affetto. A volte sospettava che in realtà il desiderio
della signora fosse di veder spegnersi quella breve candela… A volte temeva
che l’avrebbe preso da parte, mentre preparava una siringa, per dirgli:
«Dategliene di più… un po’ di più». Se si chinava sul cuscino a baciare quel
volto scavato da santo, lo faceva con cautela, quasi temendo che lui si
sollevasse di scatto rompendole il naso. Assumeva infermiere con il compito
di vestirlo, di drenarlo, di tenere le lenzuola pulite, ma raramente duravano
più di una settimana; l’ultima (una ragazza belga, dedita al lavoro) passando
accanto a Luke in corridoio aveva mormorato: «Il est comme un diable!» e gli
aveva mostrato il polso, sul quale però non c’erano segni. Soltanto il cane
senza nome – una creatura leale e malconcia che non si allontanava mai dal
letto – non aveva paura del suo padrone, o comunque si era abituato a lui.
Con il tempo Luke Garrett aveva allacciato un rapporto con Francis, il
figlio dei Seaborne, taciturno e dai capelli neri, e con Martha, la sua tata, il
cui braccio cingeva sempre la vita di Cora con un fare possessivo che non gli
piaceva. Dopo una visita superficiale al paziente (non c’era molto altro da
fare), Luke si lasciava condurre via per dare un’occhiata a un dente fossile
che la signora aveva ricevuto per posta, o per essere interrogato diffusamente
sulla sua ambizione di diventare cardiochirurgo. La ipnotizzava, e le spiegava
come l’ipnosi fosse stata usata in guerra per rendere più facile l’amputazione
degli arti dei soldati; giocavano a scacchi, e al termine di ogni partita Cora si
offendeva perché il suo avversario si era impegnato con tutte le sue forze per
batterla. Luke aveva emesso una diagnosi: si era innamorato. Tuttavia non
aveva cercato una cura.
Fin dal primo momento aveva avvertito in lei una sorta di energia,
un’energia repressa che aspettava di essere liberata; e si era convinto che,
quando per Michael Seaborne fosse giunta la fine, Cora si sarebbe
abbandonata all’euforia… Nella sua mente, aveva coltivato l’immagine di lei
che camminava per i marciapiedi lasciandosi dietro una scia di scintille
azzurre. Poi la fine era arrivata, e Luke era presente quando l’uomo aveva
esalato l’ultimo respiro, faticoso e profondo, come se in quell’ultimo istante
avesse messo da parte l’ars moriendi, mosso solo dal desiderio di vivere
ancora un istante. Cora però non era cambiata. Non era apparsa addolorata né
sollevata: le si era rotta la voce una sola volta, quando aveva riferito che il
cane era stato ritrovato morto, ma Luke non era riuscito a capire se stesse
trattenendo il pianto o una risata. Dopo aver firmato il certificato di morte, e
dopo che i resti di Michael Seaborne erano stati trasferiti altrove, non aveva
avuto più alcun motivo per recarsi in Foulis Street; ma ogni mattina si era
svegliato con un’idea fissa: giungere alla cancellata di ferro e scoprire di
essere atteso.
Il treno entrò nella stazione di Embankment, e lui si mosse con la folla
lungo la banchina. In quel momento si accorse di provare un sentimento
simile al dolore, ma non per Seaborne, né tantomeno per la sua vedova: a
tormentarlo più di ogni altra cosa era il pensiero che quello poteva essere il
suo ultimo incontro con Cora… Temeva che l’ultima immagine che avrebbe
avuto di lei sarebbe stata quella in cui lui si voltava a guardarla da sopra la
spalla, con il rintocco delle campane funebri in sottofondo. «Eppure» disse ad
alta voce, «devi essere presente; fosse soltanto per veder inchiodare il
coperchio della bara». Oltre i tornelli il ghiaccio sui marciapiedi si stava
sciogliendo; il sole accecante iniziava a calare.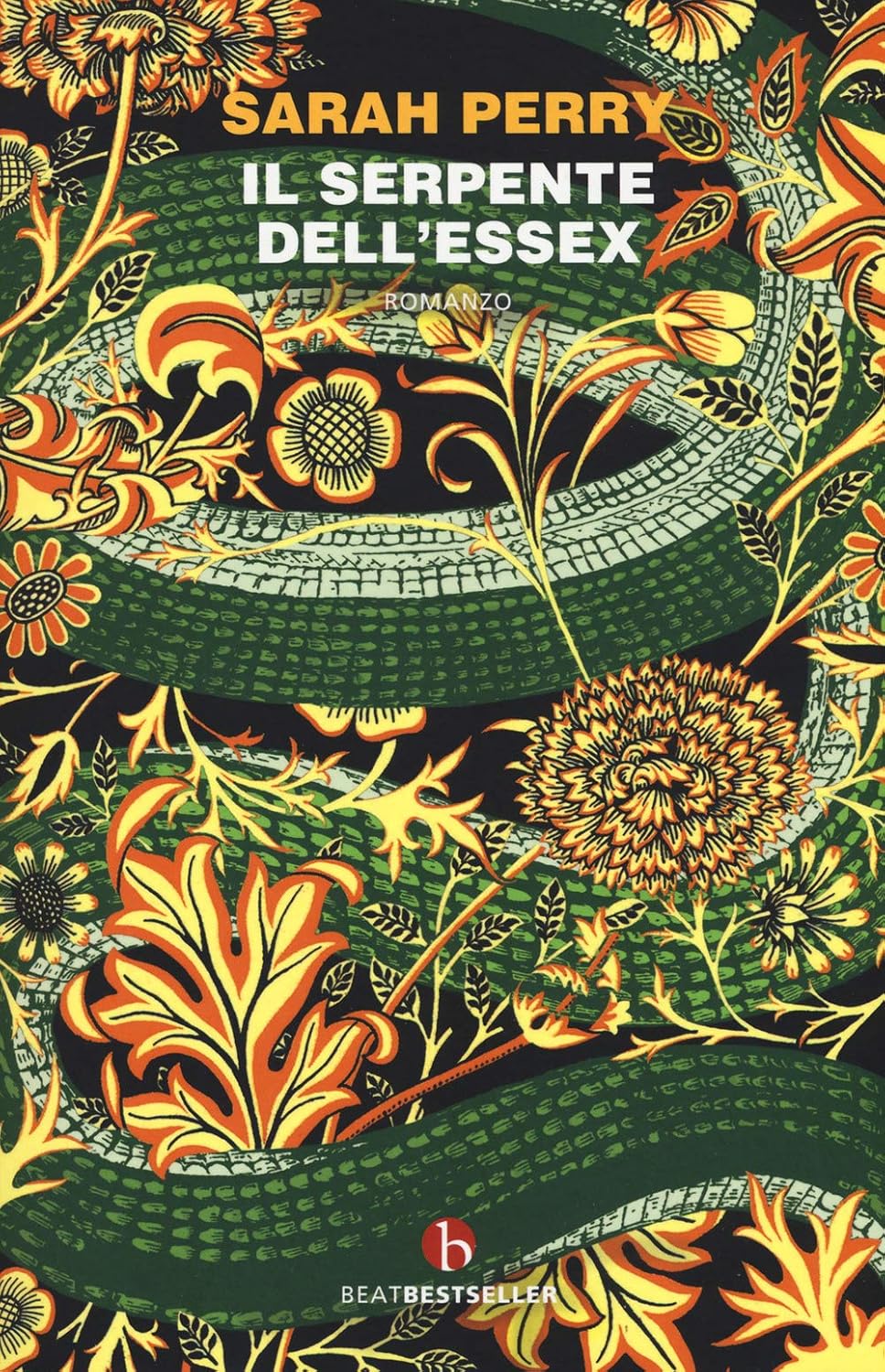






Commento all'articolo