Il filo di mezzogiorno – Goliarda Sapienza
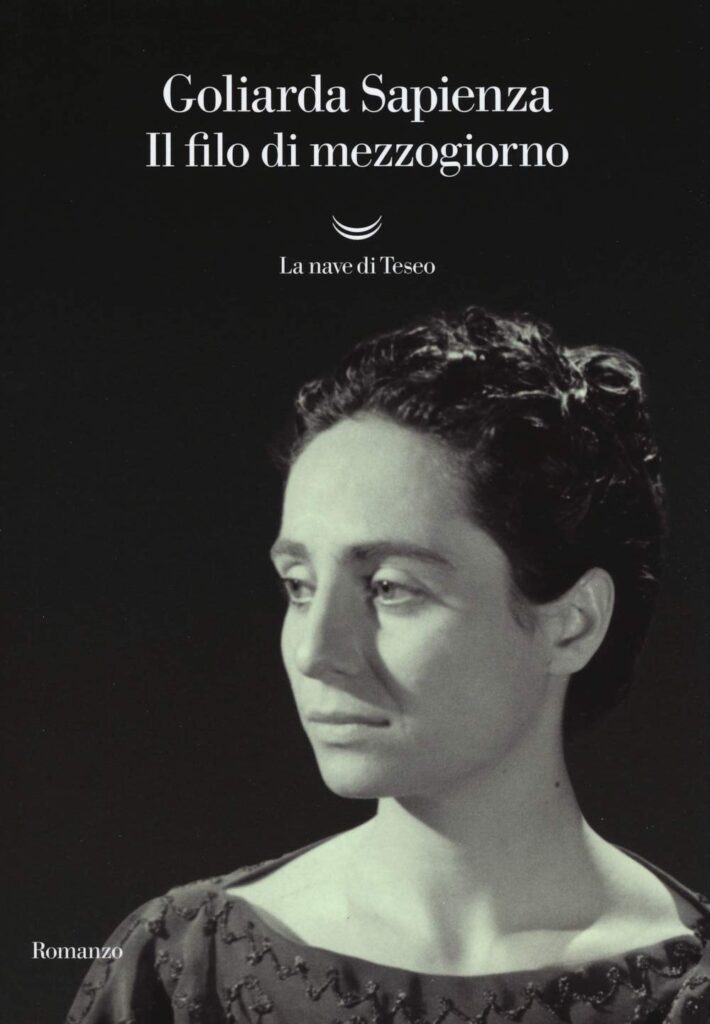
SINTESI DEL LIBRO:
Il filo di mezzogiorno è un libro d’amore. D’amore per l’analisi. Goliarda
non l’avrebbe mai scrio, e non certo così, se non avesse sperimentato di
persona il beneficio a tuo campo, psichico e artistico cioè, ricevuto da
quella terapia, pur drammatica, iniziata nel 1962. Nello stesso tempo è un
libro di critica a una certa psicoanalisi.
Si traò di “analisi selvaggia”, come allora si chiamava la pratica
eterodossa che alcuni analisti usavano, o provavano a usare. D’altronde
l’Italia, ancora negli anni cinquanta, era una sorta di Far West in ambito
psicoanalitico. Scontava così vent’anni di ostracismo fascista che l’avevano
tagliata fuori dallo sviluppo di una scienza che doveva poi dilagare nel
nostro paese con tua la caoticità delle cose troppo a lungo ritardate.
Ma l’ostracismo non fu soltanto liorio, si continuò, ancora più
categorico, nell’ambito della sinistra marxista, cui Goliarda apparteneva
anche se in posizione fortemente critica, per via delle sue origini familiari:
entrambi i genitori furono figure di primo piano del socialismo italiano.
Infai Goliarda non ricorse volontariamente all’analisi. Fu un accadimento
causato da un altro accadimento: gli eleroshock, allora assai di moda, che
le venivano praticati in una clinica romana senz’altro risultato che quello
di disfare la sua mente.
Goliarda soffriva di depressione. Non sappiamo quando questa
cominciò. Le cause si possono tue desumere dalla leura aenta di
questo libro, diventato poi curiosamente un manuale per molti
psicoanalisti. Sta di fao che nei mesi che precedeero il suo ricovero
nella famigerata clinica, il suo stato s’aggravò a causa di una grave forma
d’insonnia che l’uso regolare di sonniferi non risolveva più. A questo
punto accadde un vero e proprio incidente. Goliarda una noe, non
potendone più, desiderando solo dormire, assunse una quantità di
sonniferi ben maggiore della solita. La trovarono in coma. E tui
pensarono a un tentativo di suicidio che, stando alle sue precise e
categoriche dichiarazioni, già subito al risveglio in clinica, non era mai
stato nelle sue intenzioni.
Il gruppo di persone che allora le stavano intorno pensò di affidarla alle
cure di un medico che praticava gli eleroshock. Ma dopo alcune diecine
di scariche si vide che la terapia non dava risultati. Apparve a questo
punto l’analista-protagonista del Filo di mezzogiorno, il quale si assunse la
responsabilità di farla dimeere dalla clinica e di prenderla in cura. Inizia
così il rapporto analitico descrio nel romanzo. Durò poco più di tre anni.
Tui i giorni codesto analista si recava a casa di Goliarda, e seduti insieme
sul divano procedevano nella cura. esto è il fao, e l’antefao.
Il leore, però, non deve pensare che Goliarda e il gruppo di amici che
l’assistevano fossero così sprovveduti da non accorgersi dei poco ortodossi
metodi di un analista che addiriura prese in cura anche il compagno di
Goliarda, allora già noto regista cinematografico. Il fao è che il suo
operato godeva di una stima confermata dal numero di notissime
personalità della cultura e dell’arte che lo elessero a proprio analista anche
dopo la sua clamorosa crisi raccontata in questo romanzo, e lo scandalo
che ne seguì.
Ma veniamo al Filo di mezzogiorno. È il secondo romanzo di Goliarda.
Vide la luce presso Garzanti nel 1969, ma era già finito da almeno due
anni. Segue Leera aperta, cui direamente si ricollega, uscito anch’esso
da Garzanti nel 1967. Il filo di mezzogiorno doveva far parte di un ciclo
autobiografico, iniziato appunto con Leera aperta, un’autobiografia
costantemente in fieri, man mano che la vita fluiva, che Goliarda
nominava autobiografia delle contraddizioni. Periodicamente una nuova
Leera aperta, dove ogni volta dovevano entrare in scena i vecchi
personaggi aggiunti ai nuovi, ai nuovi amici, ai nuovi incontri, alle nuove
avventure. Ogni romanzo doveva far parte a sé, essere leggibile cioè senza
l’ausilio degli altri, come un ideale mazzo di carte dove ognuna aveva la
sua emblematicità, subito contraddea dalla successiva. Intendeva
mostrare così, di contro alla rigida autobiografia tradizionale che di
necessità appiaisce fai e persone contro un fondale fortemente
idealizzato da un lungo tempo trascorso, il continuo, inarrestabile
mutamento della coscienza e dei suoi giudizi, la trasformazione dell’io nei
confronti del proprio passato, e di conseguenza dei fenomeni che
circondano il proprio presente.
Analisi continua, rivoluzione continua, narrazione continua.
Il progeo s’interruppe a causa dell’urgenza irrefrenabile di dar vita
alla potente protagonista dell’Arte della gioia, quella Modesta destinata a
diventare il personaggio femminile più originale e vivo del nostro
Novecento, un personaggio d’invenzione questa volta, dove però
confluiscono in grande sintesi tue le figure dell’universo femminile di
Goliarda, compresa lei stessa naturalmente. La stesura di questo vasto
romanzo, da me pubblicato postumo soltanto nel 1998, comportò quasi
dieci anni di lavoro (era stato portato a termine nel 1976), un’immersione
totale nel puro raccontare. Durante tuo quel tempo Goliarda non scrisse
altro. ando riemerse, la società italiana era del tuo mutata –
incombevano gli anni di piombo – e naturalmente anche Goliarda, così
che quando riprese in mano il ciclo autobiografico il suo stile e gli stessi
presupposti non erano più quelli precedenti. La sua scriura iniziò un
nuovo periodo col romanzo Io, Jean Gabin che fa da cerniera tra la prima
parte del ciclo e la seconda rappresentata dai romanzi L’università di
Rebibbia (1983) e Le certezze del dubbio (1987).
Con Il filo di mezzogiorno si chiuse un’intera stagione, quella
drammatica e contrastata dei suoi inizi leerari. Goliarda aveva cercato il
più possibile di resistere alla sua vocazione, sapendone la vanità e insieme
la frustrazione, insomma tua la drammaticità che comportava portarla
avanti sino in fondo in una società antileeraria come quella italiana (ma
il motivo più profondo era soprauo un altro, come presto vedremo). Se
c’è scririce che ha fao di tuo per non diventarlo, questa è stata
Goliarda Sapienza.
Goliarda nasce arice. Dopo aver dovuto abbandonare la scuola
fascista, fra tui i mestieri d’arte che aveva intrapreso grazie al suo
multiforme talento – la danzatrice, la pupara, la pianista, e perché no,
anche l’impagliatrice di sedie, come si legge in Leera aperta – a un certo
punto il migliore le parve, dopo la benedizione di Angelo Musco con cui
fece i primi passi a quaordici anni, quello del teatro, soprauo per la
possibilità di fuggire all’estero al primo giro di compagnia, come poi
avrebbero fao artisti e atleti sovietici fino alla caduta del Muro. La fine
della guerra interruppe questo proposito. “La pace m’ha rovinato!”
ironizzava spesso.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :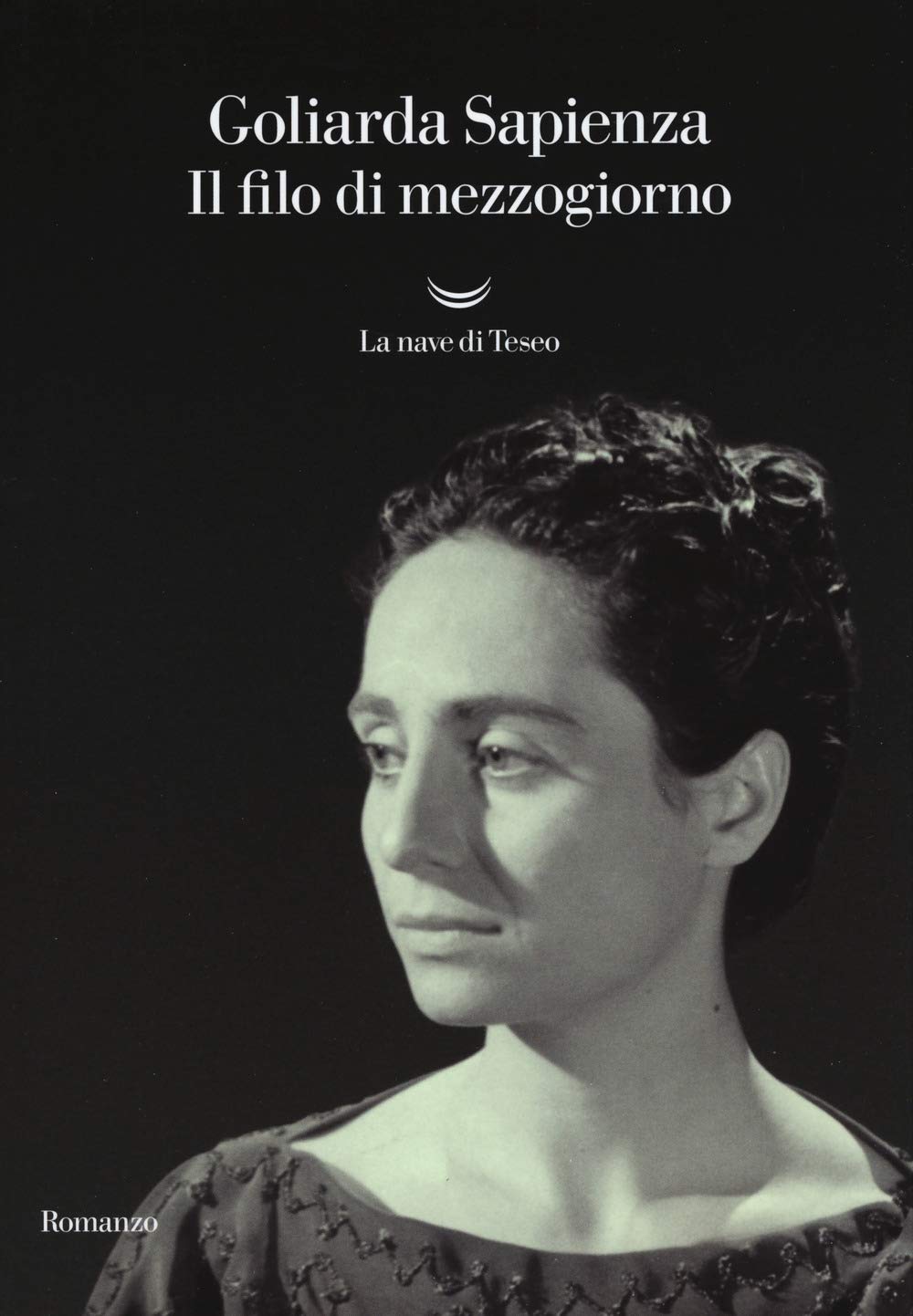






Commento all'articolo