Idee per il lavoro – Gino Giugni
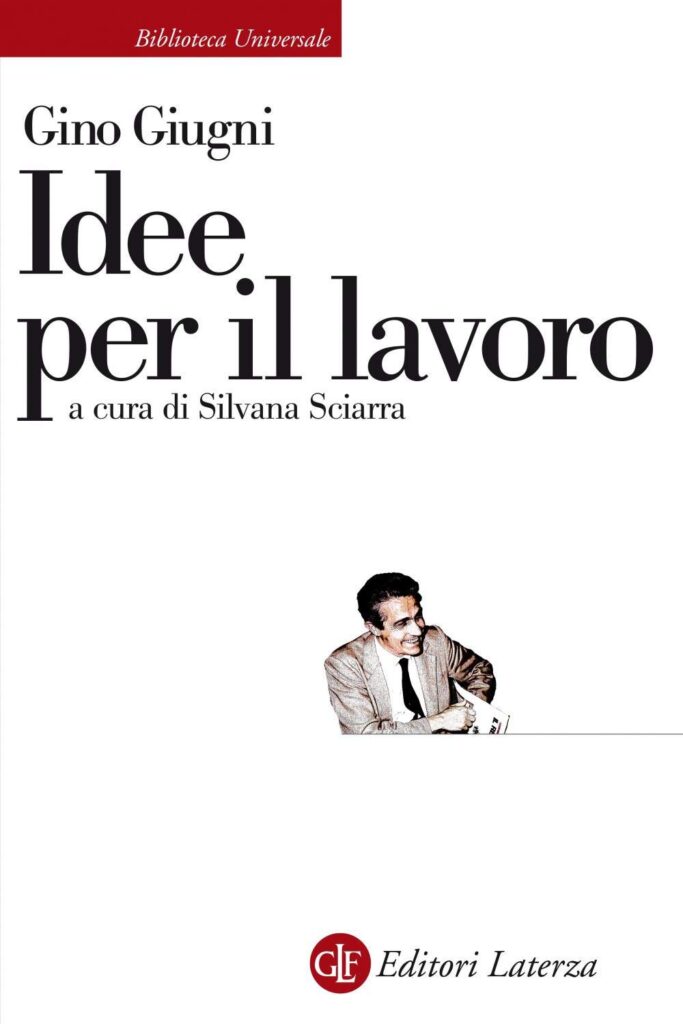
SINTESI DEL LIBRO:
La formazione del diritto del lavoro come area normativa o disciplina
speciale è un fenomeno tipico di questo secolo. Le prime leggi protettive,
che costituiscono la più immediata risposta alla «questione sociale» e
riguardano particolarmente il lavoro delle donne e dei fanciulli o la
materia degli infortuni, fanno invero la loro comparsa nel pieno secolo
XIX. Il primo Factory Act inglese è del 1833; la prima legge francese sul
lavoro dei fanciulli è del 1841. Il più tardivo avvento della legislazione
sociale negli altri paesi dipende da vari fattori, riferibili o meno ai tempi
di sviluppo del sistema produttivo industriale; in Italia esso è dovuto
certamente allo sviluppo industriale tardivo; negli Stati Uniti si spiega con
la forte resistenza opposta dalle classi proprietarie in nome dei principi di
non intervento e di libertà contrattuale; nella Germania guglielmina,
invece, la legislazione sociale nasce nella penultima decade del secolo
XIX, ma è coeva con le leggi speciali antisocialiste. Già in questo periodo
si delineano un modello liberale d’intervento, di cui è antesignana
l’Inghilterra, e uno di tipo autoritario e paternalistico, che caratterizza la
Germania imperiale. Il modello liberale corrisponde in genere a
condizioni di egemonia politica della borghesia industriale; l’altro, al
protrarsi del potere dei ceti agrari e delle caste militari, nonché al parziale
perdurare di strutture produttive corporative. L’intervento sociale
nell’ambito di regimi autoritari troverà la più coerente espressione nei
regimi fascisti.
Questi primi interventi legislativi, pur essendo ricchi di contenuti
innovativi di per sé idonei a porre le prime basi per un nuovo diritto, non
danno luogo tuttavia a una compiuta elaborazione scientifica fino al
nuovo secolo. Essi appaiono in un primo tempo come massi erratici nel
gran mare del diritto e in specie del diritto civile. Con singolare
sincronia, invece, nei primi dieci anni del secolo XX escono opere
sistematiche di alto impegno, dovute ad autori prestigiosi o destinati a
diventare tali, che pongono le fondamenta del diritto del lavoro.
Rammentiamo in proposito tra i più significativi: Ph. Lotmar e H.
Sinzheimer in Germania, P. Pic e (per il diritto dei sindacati) M. Leroy in
Francia, L. Barassi e G. Messina in Italia. D’altro lato il famoso Industrial
Democracy di S. e B. Webb, studio non ispirato da metodologia giuridica,
o l’opera delle scuole istituzionalistiche americane
102
, influenzate
dall’europeo «socialismo della cattedra», svolgono nei rispettivi paesi un
ruolo analogo, e cioè quello di porre sotto la lente dell’osservazione
scientifica il nuovo tessuto istituzionale che si era venuto formando
soprattutto nella seconda metà del secolo XIX: le leghe operaie, i
concordati o contratti collettivi, lo sciopero, il contratto o il rapporto di
lavoro. Il processo di sviluppo delle istituzioni sarà comunque più
accelerato che non il flusso di indagini e la sistemazione teorica, e sarà
esso, soprattutto, a porre in crisi il rigoroso impianto individualistico del
diritto borghese, e di quello civile in particolare. Notevole sarà fin dagli
inizi la circolazione internazionale dell’informazione legislativa, mentre
emergerà presto anche una pronunciata tendenza
all’internazionalizzazione del problema. Tale tendenza vedrà la sua prima
manifestazione nel 1890, con la Conferenza internazionale di Berlino
convocata da Guglielmo II, e culminerà nel 1919 a Versailles con la
costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, patrocinata
dal presidente Wilson.
Profondo sarà infine l’impatto di fattori politici di portata storica, quali
l’avvento delle dittature in Germania e in Italia da un lato, e il New Deal
statunitense dall’altro; o anche delle esigenze sociali poste in essere dalle
due guerre mondiali. Il fascismo e il nazismo, in particolare, ebbero un
effetto distruttivo sulle istituzioni come sulle dottrine, ma le prime
apparvero più capaci di immediato recupero che non le seconde. Negli
Stati Uniti il New Deal rovesciò completamente e durevolmente
l’atteggiamento dello Stato federale nei confronti dei rapporti sindacali.
L’emergenza bellica indusse molti paesi ad adottare misure di controllo e
di protezione, che sopravvissero ad essa. In mezzo a tali sequenze di
avvenimenti, mentre l’evoluzione degli istituti legali, della giurisprudenza
e dei contratti collettivi mutava il modo di essere di questa importante
area di relazioni sociali ed economiche, la dottrina, pur abbondante e, nel
complesso, sensibile e originale, avrebbe continuato a vedere nel diritto
del lavoro un diritto nuovo o «un diritto enfant che è tenuto per mano dal
vegliardo diritto civile»
103
. La verità è che il diritto del lavoro appariva
sempre nuovo perché cambiava e cambia continuamente, con un ritmo
dinamico certamente più accentuato di quello di altri rami del diritto (ma
non di tutti: si pensi al diritto dell’economia o a quello tributario). Ciò
che non veniva percepito adeguatamente era l’insufficienza della
metodologia dominante, la cosiddetta dogmatica, ossia la tecnica
costruttiva procedente per grandi sistemazioni concettualizzanti, a tenere
il passo con il fenomeno del cambiamento.
[...]
3. I contenuti
In un primo tempo (più o meno a cavallo tra i due secoli) il diritto del
lavoro ha per oggetto la posizione di una serie di consistenti limiti
all’autonomia dei soggetti, diretti a contenere le forme più intense di
sfruttamento: restrizioni all’occupazione dei fanciulli e delle donne,
durata massima dell’orario di lavoro, riposi settimanali, ecc. Questa sfera
del diritto del lavoro viene chiamata legislazione del lavoro o sociale o
protettiva. Posto che i vari divieti da essa previsti sono sanzionati
penalmente e che, in genere, alla loro osservanza sono preposti servizi
ispettivi facenti parte dell’amministrazione dello Stato (factory inspectors in
Gran Bretagna, ispettori del lavoro in Francia e in Italia), si riconosce
l’appartenenza di questa sfera al diritto pubblico.
Un altro aspetto che viene regolato fin dagli inizi è quello indennitario
per gli infortuni e le malattie professionali. Il meccanismo
dell’assicurazione obbligatoria, una novità per l’epoca (Germania 1884;
Italia 1898), è impiegato per coprire il rischio d’impresa per l’infortunio
del lavoratore, un principio che andava affermandosi nella giurisprudenza,
ma che non costituiva una soddisfacente protezione del lavoratore
soprattutto nei casi di fallimento o di cessazione dell’impresa. Con
cadenze molto diverse da paese a paese (primo, la Germania imperiale,
ultimi, e tuttora lontani dai livelli degli altri paesi, gli Stati Uniti) si
diffondono forme di copertura di altri rischi: vecchiaia, invalidità,
disoccupazione, malattie non professionali. Quando la tecnica assicurativa
tende a essere sostituita dalla copertura della finanza pubblica, e quando il
diritto alle prestazioni non ha più la sua fonte in un rapporto di lavoro ma
nella condizione di membro della comunità sociale, si ha il passaggio dal
sistema delle assicurazioni sociali a quello della sicurezza sociale, come
realizzato in Gran Bretagna nel secondo dopoguerra (Piano Beveridge).
In questo caso, la materia dei rischi esce dal campo del diritto del lavoro
ed entra in quello dell’intervento pubblico diretto alla soddisfazione dei
bisogni sociali.
[...]
Infine, la branca più accidentata, anche perché la più sensibile al
mutamento politico e all’interazione dei rapporti e delle forze sociali, è il
diritto sindacale. Esso riguarda le condizioni di esistenza giuridica delle
organizzazioni costituite dai lavoratori e dai datori di lavoro per il
perseguimento dei loro interessi, nonché l’attività delle stesse, con
particolare riguardo alla stipulazione e agli effetti dei contratti collettivi; e,
infine, le forme dell’autotutela, che del diritto sindacale costituiscono una
caratteristica saliente e unica. Questo insieme normativo si forma
all’inizio con la rimozione di divieti o di altri impedimenti giuridici alla
costituzione e attività delle coalizioni sindacali, o allo svolgimento di
talune forme di autotutela, e soprattutto dello sciopero. Più tardi esso si
può evolvere in una disciplina di tipo garantistico, che frequentemente
viene accolta nel corpo dei principi costituzionali. Un tipo di intervento
che compare in Svezia e negli Stati Uniti negli anni Trenta e si diffonde
altrove soprattutto negli anni Settanta è quello di promozione dell’attività
sindacale.
La linea di spartiacque tra i vari sistemi è comunque il riconoscimento e
l’effettività del principio di libertà sindacale. Da esso, che è carattere
proprio e distintivo di regime, dipendono caratteristiche differenziali
pressoché totali, quali non si riscontrano negli altri rami del diritto del
lavoro, dove è anzi in atto una tendenza a marcate uniformità, anche tra
regimi sociopolitici diversi.
Al di là di queste ripartizioni, poi, si può affermare che il diritto del
lavoro percorre in senso orizzontale quasi tutte le divisioni tradizionali
della scienza giuridica, configurando così un diritto internazionale del
lavoro, pubblico e privato, un diritto penale, un diritto processuale del
lavoro. Il diritto processuale merita una specialissima menzione, perché
esso appare quasi sempre costruito su normative speciali o addirittura su
giurisdizioni speciali, con partecipazione sindacale (corti del lavoro,
probiviri), oppure su sistemi arbitrali regolati dalla contrattazione
collettiva. L’importanza del meccanismo processuale è dovuta non
soltanto alla funzione di quest’ultimo di realizzare l’effettività delle
norme, ma anche al fatto che le decisioni enunciate da tali giurisdizioni
speciali o nell’ambito di tali procedimenti ad hoc, in numerosi
ordinamenti, hanno posto in essere il primo corpo normativo
sostanziale
104
o ne alimentano tuttora il rinnovamento.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :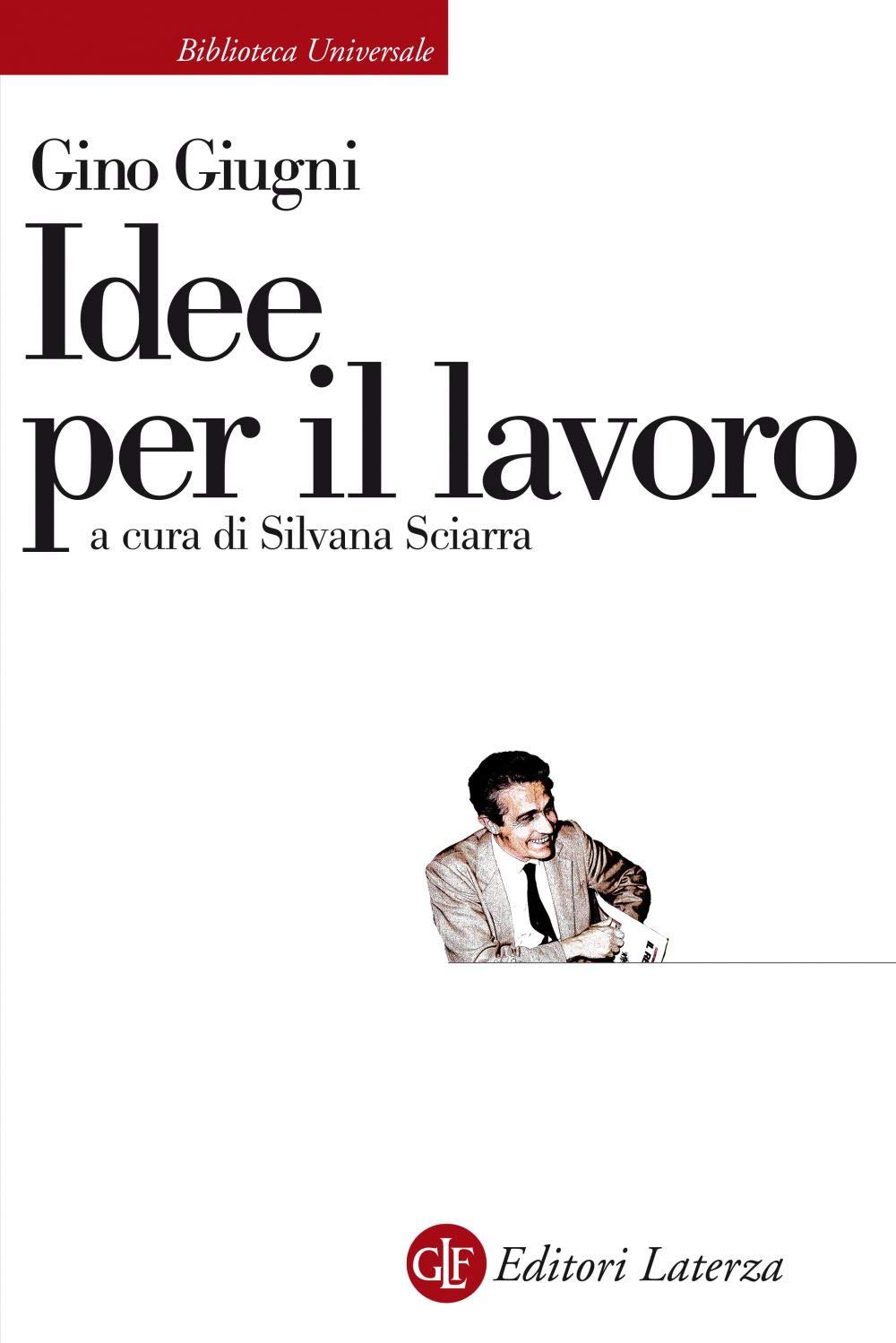






Commento all'articolo