Fenomenologia della percezione – Maurice Merleau-Ponty
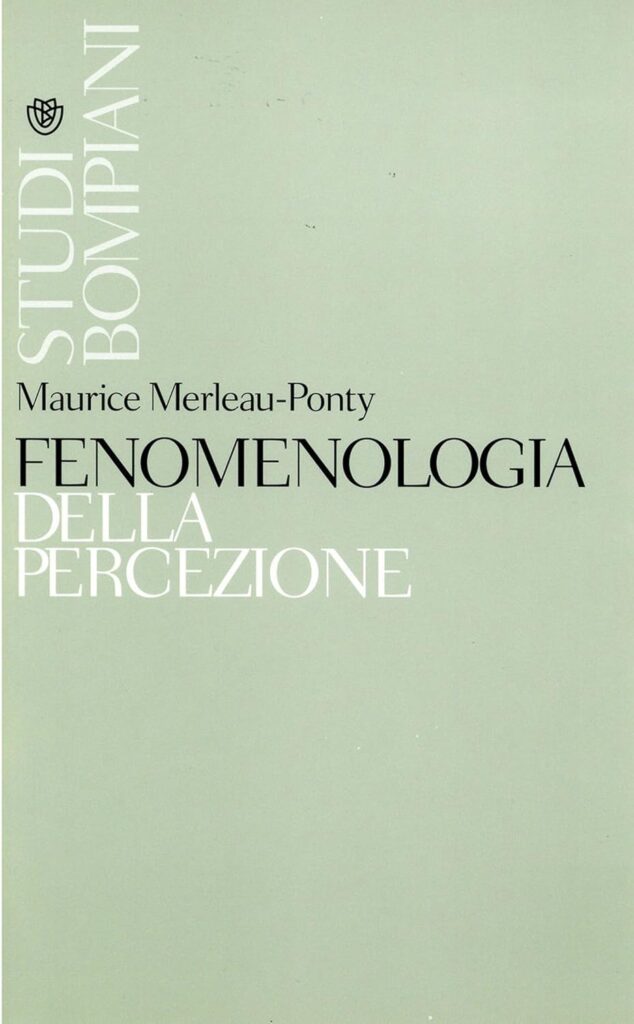
SINTESI DEL LIBRO:
Cominciando lo studio della percezione troviamo nel linguaggio la
nozione di sensazione, che sembra immediata e chiara: io sento del
rosso, dell’azzurro, del caldo, del freddo. Tuttavia, vedremo che essa
è oltremodo confusa e che, per averla ammessa, le analisi classiche
hanno fallito il fenomeno della percezione.
Anzitutto potrei intendere per sensazione la maniera in cui sono
stimolato e l’esperienza di uno stato di me stesso. Il grigio degli
occhi chiusi che mi circonda senza distanza, i suoni del dormiveglia
che vibrano «nella mia testa» indicherebbero ciò che può essere il
puro sentire. Io sentirei nell’esatta misura in cui coincido con il
sentito, e in cui esso cessa di aver posto nel mondo oggettivo e non
mi significa nulla. Ciò equivale a confessare che si dovrebbe cercare
la sensazione al di qua di ogni contenuto qualificato, giacché, per
distinguersi l’uno dall’altro come due colori, il rosso e il verde devono
già esser spettacolo dinanzi a me anche senza localizzazione
precisa, e cessano dunque di essere me stesso. La sensazione pura
consisterà nell’esperire uno «choc» indifferenziato, istantaneo e
puntuale. Non è, necessario dimostrare, data la concordanza dei
punti di vista in proposito, che tale nozione non corrisponde a nulla
di cui abbiamo l’esperienza e che le percezioni di fatto più semplici
che conosciamo, per esempio in animali come la scimmia e la
gallina, vertono su relazioni e non su termini assoluti.1 Ma resta da
chiedersi perché ci si crede autorizzati di diritto a distinguere
nell’esperienza percettiva uno strato di «impressioni». Prendiamo
una macchia bianca su uno sfondo omogeneo. Tutti i punti della
macchia hanno in comune una certa «funzione» che fa di essi una
«figura». Il colore della figura è più denso e per cosi dire più
resistente di quello dello sfondo; i bordi della macchia bianca le
«appartengono» e non sono solidali con lo sfondo, quantunque
quest’ultimo sia a essi contiguo; la macchia appare posta sullo
sfondo e non lo interrompe. Ogni parte annuncia più di quanto
contenga e questa percezione elementare è quindi già pregna di un
senso. Ma se la figura e lo sfondo, come insieme, non sono sentiti, è
pur necessario, si dirà, che lo siano in ogni loro punto. Ciò
significherebbe però dimenticare che, a sua volta, ogni punto può
essere percepito solo come una figura su uno sfondo. Quando la
Gestalttheorie ci dice che una figura su sfondo è il dato sensibile più
semplice che possiamo ottenere, non ci troviamo di fronte a un
carattere contingente della percezione di fatto - che, in una analisi
ideale, ci lascerebbe liberi di introdurre la nozione di impressione, -
ma alla definizione stessa del fenomeno percettivo, ciò senza di cui
un fenomeno non può essere detto percezione. Il «qualcosa»
percettivo è sempre in mezzo ad altre cose e fa sempre parte di un
«campo». Una zona veramente omogenea che non offra nulla da
percepire non può essere data a nessuna percezione. Solo la
struttura della percezione effettiva ci può insegnare che cos’è
percepire. Pertanto, la pura impressione è non soltanto introvabile,
ma anche impercettibile, e quindi impensabile come momento della
percezione. Se la si introduce, è perché, invece di rimanere attenti
all’esperienza percettiva, la si dimentica in favore dell’oggetto
percepito. Un campo visivo non è fatto di visioni locali. Ma l’oggetto
visto è fatto di frammenti di materia e i punti dello spazio sono l’uno
esteriore all’altro. Un dato percettivo isolato è inconcepibile, se per lo
meno facciamo l’esperienza mentale di percepirlo. Ma nel mondo vi
sono oggetti isolati, ossia c’è un vuoto fisico.
Pertanto, rinuncerò a definire la sensazione con l’impressione
pura. Ma vedere è avere dei colori o delle luci, udire è avere dei
suoni, sentire è avere delle qualità: per sapere che cos’è sentire, non
è forse sufficiente aver visto un rosso o udito un lai II rosso e il verde
non sono sensazioni, ma dei sensibili, e la qualità non è un elemento
della coscienza, ma una proprietà dell’oggetto. Se la consideriamo
nell’esperienza stessa che la rivela, la qualità è ben lungi dall’offrirci
un mezzo semplice per delimitare le sensazioni, ma è ricca e oscura
quanto l’oggetto o l’intero spettacolo percettivo. Questa macchia
rossa che vedo sul tappeto è rossa solo tenuto conto di un’ombra
che l’attraversa, la sua qualità non appare se non in rapporto ai
giochi di luce e quindi come elemento di una configurazione
spaziale. Del resto, il colore è determinato solo se si stende su una
certa superficie, una superficie troppo piccola sarebbe inqualificabile.
Infine, questo rosso non sarebbe letteralmente lo stesso se non
fosse il «rosso lanoso» di un tappeto.2
In ogni qualità l’analisi scopre
quindi dei significati che l’abitano. Si dirà forse che si tratta qui
esclusivamente delle qualità della nostra esperienza effettiva,
ricoperte da tutto un sapere, e che si conserva il diritto di concepire
una «qualità pura» che definirebbe il «puro sentire»? Ma, come
abbiamo visto, questo puro sentire equivarrebbe a non sentire nulla
e quindi a non sentire affatto. La pretesa evidenza del sentire non è
fondata su una testimonianza della coscienza, ma sul pregiudizio del
mondo. Noi crediamo di sapere molto bene che cos’è «vedere»,
«udire», «sentire», perché da molto tempo la percezione ci ha dato
oggetti colorati o sonori. Quando vogliamo analizzarla, trasportiamo
tali oggetti nella coscienza. Commettiamo quello che gli psicologi
chiamano l’experience error, e cioè d’un sol tratto supponiamo nella
nostra coscienza delle cose ciò che sappiamo essere nelle cose. Per
costituire la percezione ricorriamo al percepito. E poiché
evidentemente il percepito stesso è accessibile solo attraverso la
percezione, in definitiva non comprendiamo né l’uno né l’altra. Siamo
presi nel mondo e non arriviamo a staccarcene per passare alla
coscienza del mondo. Se lo facessimo, vedremmo che la qualità non
è mai esperita immediatamente e che ogni coscienza è coscienza di
qualcosa. Del resto, questo «qualcosa» non è necessariamente un
oggetto identificabile. Vi sono due modi di ingannarsi sulla qualità: il
primo consiste nel farne un elemento della coscienza, mentre essa è
oggetto per la coscienza, nel trattarla come un’impressione muta,
mentre ha sempre un senso, il secondo consiste nel credere che al
livello della qualità questo senso e questo oggetto siano pieni e
determinati. E, come il primo, il secondo errore deriva dal pregiudizio
del mondo. Con l’ottica e la geometria costruiamo il frammento del
mondo la cui immagine può in ogni momento formarsi sulla nostra
retina. Non riflettendosi su alcuna superficie possibile, tutto ciò che è
fuori da questo perimetro non agisce sulla nostra visione più di
quanto agisca la luce sugli occhi chiusi. Dovremmo quindi percepire
un segmento del mondo contornato da limiti precisi, circondato da
una zona buia, riempito senza lacune da qualità, sotteso da rapporti
di grandezza determinati come quelli che esistono sulla retina.
Orbene, l’esperienza non offre nulla di simile, e a partire dal mondo
non comprenderemo mai che cosa è un campo visivo. Se è possibile
tracciare un perimetro di visione avvicinando a poco a poco al centro
gli stimoli laterali, i risultati della misura variano da un momento
all’altro e non si giunge mai a stabilire il momento in cui uno stimolo
dapprima visto cessa di esserlo. La regione che circonda il campo
visivo non è facile da descrivere, ma è pur certo che non è né nera
né grigia. Vi è qui una visione indeterminata, una visione di non so
che e, se si passa al limite, ciò che è dietro la mia schiena non
manca di presenza visiva.
Fig. 1
Nella illusione di Müller-Lyer ( fig. 1) i due segmenti di retta non
sono né eguali né diseguali : questa alternativa si impone solo nel
mondo oggettivo.3
Il campo visivo è quel particolare ambito in cui le
nozioni contraddittorie si incrociano perché, in esso, gli oggetti - le
rette di Müller-Lyer - non sono posti sul terreno dell’essere, ove
sarebbe possibile un confronto, ma colti ciascuno nel suo contesto
privato, come se non appartenessero al medesimo universo. Per
molto tempo gli psicologi hanno accuratamente ignorato questi
fenomeni. Nel mondo preso in sé tutto è determinato. Vi sono si
spettacoli confusi, come un paesaggio in un giorno di nebbia, ma per
l’appunto noi ammettiamo sempre che nessun paesaggio reale è in
sé confuso. Non lo è se non per noi. L’oggetto, diranno gli psicologi,
non è mai ambiguo, lo diviene solo per disattenzione. I limiti stessi
del campo visivo non sono variabili, e vi è un momento in cui
l’oggetto che si avvicina comincia assolutamente a essere visto:
semplicemente, non lo «notiamo».4 Ma, come dimostreremo in
modo più ampio, la nozione di attenzione non ha per sé alcuna
testimonianza della coscienza. È soltanto una ipotesi ausiliaria,
formulata per salvare il pregiudizio del mondo oggettivo. Dobbiamo
riconoscere l’indeterminato come un fenomeno positivo. È in questa
atmosfera che si presenta la qualità. Il senso che essa racchiude è
un senso equivoco, si tratta di un valore espressivo piuttosto che di
un significato logico. La qualità determinata, con la quale l’empirismo
voleva definire la sensazione, è un oggetto, non un elemento, della
coscienza, ed è l’oggetto tardivo di una coscienza scientifica. Per
questi due motivi, più che rivelare essa maschera la soggettività.
Le due definizioni della sensazione che abbiamo abbozzato
erano dirette solo in apparenza. Come s’è visto, esse si modellavano
sull’oggetto percepito e in ciò concordavano con il senso comune,
che delimita il sensibile con le condizioni oggettive da cui esso
dipende. Il visibile è ciò che si coglie con gli occhi, il sensibile ciò che
si coglie tramite i sensi. Seguiamo l’idea di sensazione su questo
terreno5 e vediamo cosa divengono, nel primo grado di riflessione
che è la scienza, questo «tramite», questo «con» e la nozione di
organo di senso. In mancanza di una esperienza della sensazione,
nelle sue cause e nella sua genesi oggettiva troviamo almeno
qualche motivo per mantenerla come concetto esplicativo? La
fisiologia, alla quale lo psicologo si rivolge come a un’istanza
superiore, è nelle medesime difficoltà in cui versa la psicologia.
Anch’essa comincia con il situare il suo oggetto nel mondo e con il
trattarlo come un frammento di estensione. Il comportamento si trova
cosi nascosto dal riflesso, l’elaborazione e la strutturazione degli
stimoli da una teoria longitudinale del funzionamento nervoso che di
norma fa corrispondere a ogni elemento della situazione un
elemento della reazione.6 Come la teoria dell’arco riflesso, la
fisiologia della percezione comincia con l’ammettere un percorso
anatomico che, attraverso un trasmettitore definito, porta da un
recettore determinato a un posto di registrazione anch’esso
specializzato.7 Una volta dato il mondo oggettivo, si ammette che
esso affida agli organi di senso messaggi che devono quindi essere
portati, poi decifrati, in modo da riprodurre in noi il testo originale. Ne
deriva, in via di principio, una corrispondenza puntuale e una
connessione costante fra lo stimolo e la percezione elementare. Ma
questa «ipotesi di costanza»8 entra in conflitto con i dati della
coscienza e gli stessi psicologi che l’ammettono ne riconoscono il
carattere teorico.9 Per esempio, in certe condizioni la forza del
suono fa decrescere la sua altezza, l’aggiunta di linee ausiliarie
rende diseguali due figure oggettivamente eguali,10 un colore
pellicolare ci appare del medesimo colore su tutta la sua superficie,
mentre le soglie cromatiche delle differenti zone della retina
dovrebbero farlo qui rosso, altrove arancione, talvolta persino
acromatico.11
Questi casi in cui il fenomeno non aderisce allo stimolo
devono forse essere mantenuti nel quadro della legge di costanza e
spiegati con fattori addizionali - attenzione e giudizio -, oppure
occorre respingere la legge stessa? Quando un rosso e un verde,
presentati insieme, danno una risultante grigia, si ammette che la
combinazione centrale degli stimoli può immediatamente dar luogo a
una sensazione diversa da quella che gli stimoli oggettivi
esigerebbero. Quando la grandezza apparente di un oggetto varia
con la sua distanza apparente, o il suo colore apparente con i ricordi
che ne abbiamo, si riconosce che «i processi sensoriali non sono
inaccessibili a influenze centrali».12 Pertanto, in questo caso il
«sensibile» non può più essere definito come l’effetto immediato di
uno stimolo esterno. La stessa conclusione non si attaglia forse ai
primi tre esempi citati? Il fatto che l’attenzione, una consegna più
precisa, il riposo, l’esercizio prolungato ottengano alla fine percezioni
conformi alla legge di costanza, non prova la validità generale di
questa legge: infatti, negli esempi citati la prima apparenza aveva un
carattere sensoriale allo stesso titolo che i risultati ottenuti alla fine, e
il problema consiste nel sapere se la percezione attenta, la
concentrazione del soggetto su un punto del campo visivo - per
esempio la «percezione analitica» delle due linee principali
nell’illusione di Müller-Lyer - non sostituiscano al fenomeno originario
un montaggio eccezionale, anziché rivelare la «sensazione
normale».13 Contro la testimonianza della coscienza la legge di
costanza non può valersi di nessuna esperienza cruciale in cui tale
legge non sia già implicata, e ovunque si crede di stabilirla essa è
già presupposta.14 Se torniamo ai fenomeni, essi ci mostrano
l’apprensione di una qualità, esattamente come quella di una
grandezza, collegata a tutto un contesto percettivo, e gli stimoli non
ci danno più il mezzo indiretto che noi cercavamo per delimitare uno
strato di impressioni immediate. Ma, quando si cerca una definizione
«oggettiva» della sensazione, non è soltanto lo stimolo fisico che
sfugge. L’apparato sensoriale, quale se lo rappresenta la fisiologia
moderna, non è più adatto alla funzione di «trasmettitore» cui la
scienza classica l’aveva preposto. Le lesioni non corticali degli
apparati tattili diradano certo i punti sensibili al caldo, al freddo o alla
pressione, e diminuiscono la sensibilità dei punti conservati. Ma se
all’apparato leso si applica un eccitante abbastanza ampio, le
sensazioni specifiche riappaiono; l’elevazione delle soglie è
compensata da una esplorazione più energica della mano.15 Al
grado elementare della sensibilità si intravede una collaborazione
degli stimoli parziali fra di loro e del sistema sensoriale con il sistema
motorio, collaborazione che, in una costellazione fisiologica variabile,
mantiene costante la sensazione e quindi impedisce di definire il
processo nervoso come la semplice trasmissione di un messaggio
dato. A prescindere dalla sede delle lesioni, la distruzione della
funzione visiva segue la medesima legge: in un primo tempo tutti i
colori sono percepiti16 e perdono la loro saturazione. Poi lo spettro si
semplifica, si riduce a quattro e poco dopo a due colori; si arriva
infine a una monocromasia in grigio, del resto senza che il colore
patologico sia mai identificabile a un qualsiasi colore normale.
Pertanto, nelle lesioni centrali come nelle lesioni periferiche «la
perdita di sostanza nervosa cagiona non soltanto una deficienza di
certe qualità, ma il passaggio a una struttura meno differenziata e
più primitiva».17 Viceversa, il funzionamento normale deve essere
inteso come un processo di integrazione in cui il testo del mondo
esterno non è ricopiato, bensì costituito. E se tentiamo di cogliere la
«sensazione» nella prospettiva dei fenomeni corporei che la
preparano, non troviamo un individuo psichico, funzione di certe
variabili conosciute, ma una formazione già collegata a un insieme e
già dotata di un senso, la quale si distingue solo per grado dalle
percezioni più complesse e quindi non ci è di alcun aiuto nella nostra
delimitazione del sensibile puro. Non c’è definizione fisiologica della
sensazione e, pili in generale, non c’è psicologia fisiologica
autonoma perché lo stesso evento fisiologico obbedisce a leggi
biologiche e psicologiche. Per molto tempo si è creduto di trovare nel
condizionamento periferico una maniera sicura di individuare le
funzioni psichiche «elementari» e di distinguerle dalle funzioni
«superiori» meno strettamente legate all’infrastruttura corporea. Una
analisi più esatta mette in luce che le due specie di funzioni si
incrociano. Quella elementare non è più ciò che per addizione
costituirà il tutto, né del resto una semplice occasione offerta al tutto
per costituirsi. L’avvenimento elementare è già rivestito di un senso e
la funzione superiore realizzerà soltanto un modo di esistenza più
integrato o un adattamento più valido, utilizzando e sublimando le
operazioni subordinate. Reciprocamente, «l’esperienza sensibile è
un processo vitale, così come la procreazione, la respirazione o la
crescita».18 La psicologia e la fisiologia non sono quindi più due
scienze parallele, ma due determinazioni del comportamento, la
prima concreta e la seconda astratta.19 Quando lo psicologo chiede
al fisiologo una definizione della sensazione «fondata sulle sue
cause», egli ritrova su questo terreno, come dicevamo, le proprie
difficoltà, e ora vedremo il perché. Il fisiologo ha il compito di liberarsi
dal pregiudizio realista che tutte le scienze attingono al senso
comune e che le intralcia nel loro sviluppo. Il cambiamento di senso
delle parole «elementare» e «superiore» verificatosi nella fisiologia
moderna annuncia un mutamento di filosofia.20 Anche lo scienziato
deve imparare a criticare l’idea di un mondo esterno in sé, giacché i
fatti stessi lo invitano ad abbandonare quella del corpo come
trasmettitore di messaggi. Il sensibile è ciò che si coglie con i sensi,
ma ora sappiamo che questo «con» non è semplicemente
strumentale, che l’apparato sensoriale non è un conduttore e che
anche alla periferia l’impressione fisiologica si trova legata a
relazioni un tempo considerate centrali.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :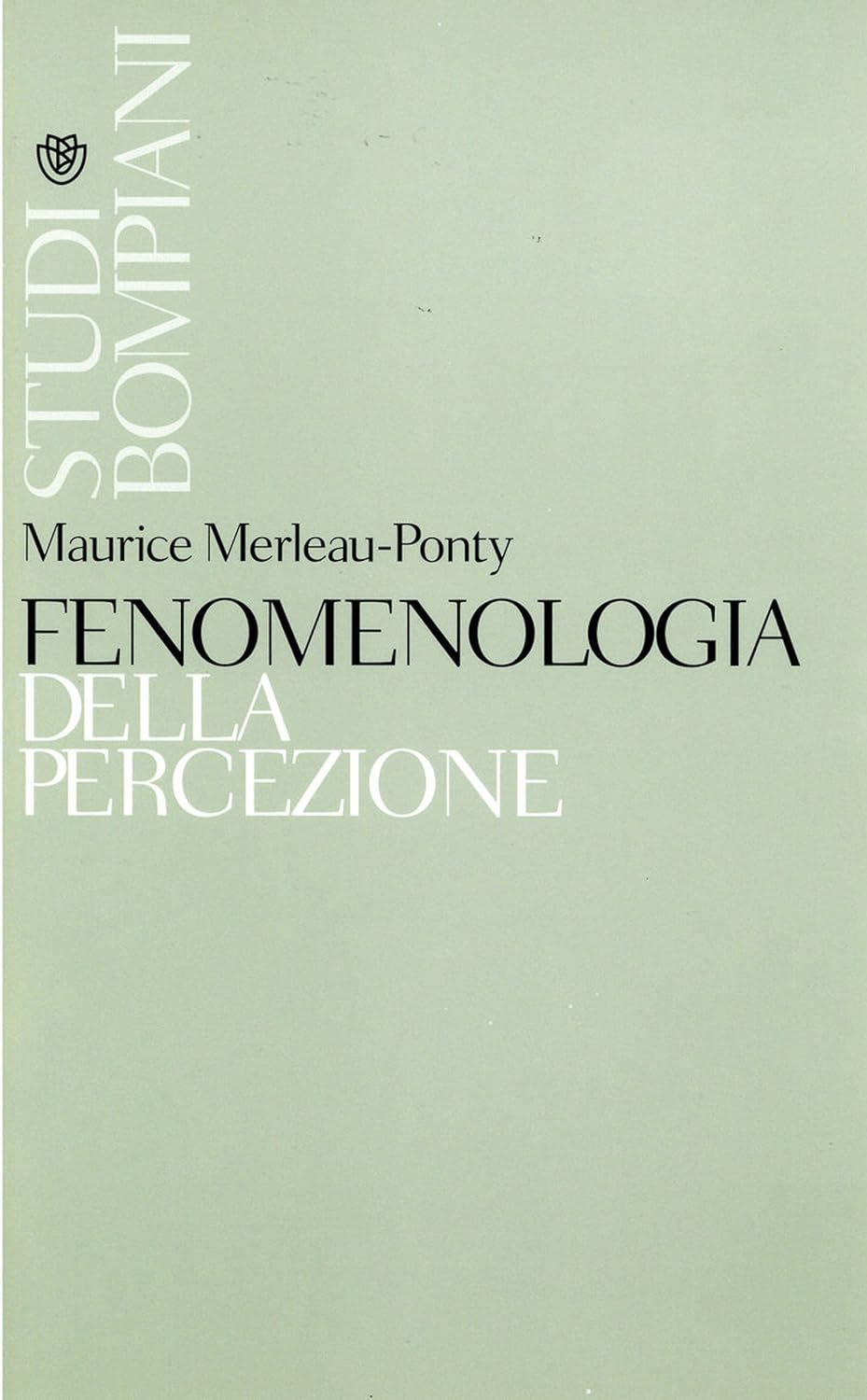






Commento all'articolo