Diritti o tutela degli animali? Uno sguardo antropologico sull’animalismo – Paola Binetti
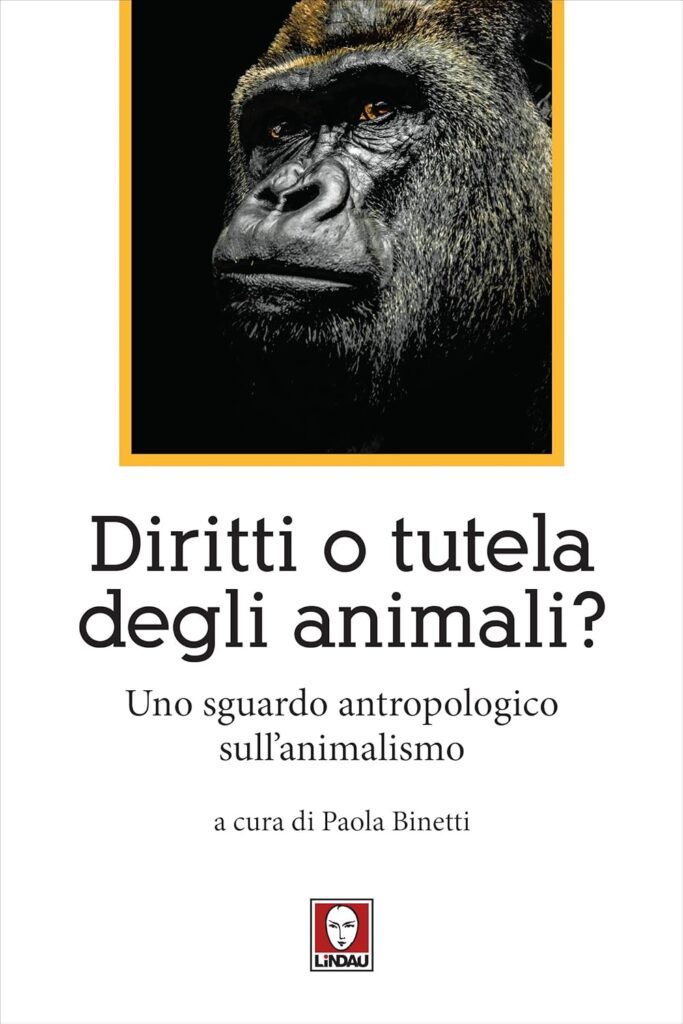
SINTESI DEL LIBRO:
Il cambio di paradigma: aspetti etici tra tutela e diritti degli animali
La maggiore attenzione con cui si considera la «questione
animale» in ambito bioetico è il risultato di un rinnovato rispetto
dell’uomo nei confronti delle altre specie e della crescente
consapevolezza, nell’ambito delle varie scienze, dei problemi etici
connessi alla ricerca scientifica. L’interesse per le condizioni degli
animali è un fatto sempre più diffuso nel sentire collettivo, anche se
non scevro da contraddizioni, per cui se da una parte si auspica un
miglioramento delle condizioni di vita degli animali, dall’altra non
sempre si creano le condizioni oggettive per la sua realizzazione
pratica. In realtà il paradigma della complessità, con cui siamo
sollecitati a confrontarci ogni giorno davanti alle questioni inedite che
si profilano nel nostro orizzonte culturale, mostra in modo
inequivocabile come anche la cosiddetta «questione animale»
rimandi a nuove e diversificate visioni, a volte contrastanti tra di loro
altre volte più facilmente sovrapponibili 1
. La stessa cura e tutela
degli animali rivela dimensioni non solo inaspettate, ma
contraddittorie al punto da diventare vere e proprie provocazioni per
la cultura del nostro tempo. L’antico atteggiamento che una volta
avremmo sintetizzato con l’espressione «dalla parte degli animali»,
oggi rivela una tale multidimensionalità da rendere difficile
identificare quale sia la parte degli animali. E forse è proprio questa
la sfida più importante che si pone alla nostra riflessione: che cosa
significa oggi stare dalla parte degli animali e in che modo gli uomini
che lo desiderano possono e debbono porsi dalla parte degli animali,
salvaguardando le rispettive specificità. Il tema è quello di una
relazione asimmetrica che faccia salva la dignità degli uni e degli
altri, evitando sia la confusività dei piani che la genericità delle
impostazioni.
La riflessione etico-culturale sull’insieme dei viventi rappresenta in
questo nostro tempo una delle dimensioni più stimolanti e più
controverse del dibattito filosofico e scientifico e implica
conseguenze di natura pratica sia nei comportamenti personali sia
nelle decisioni politico-sociali e giuridico-economiche. I due punti
estremi del dibattito sono da un lato l’antropomorfismo e dall’altro la
reificazione degli animali: animali umanizzati versus animali
cosificati. In questo ampio arco di prospettive, sottilmente sfumate se
le si considera in ragione della loro prossimità, ma diverse fino ad
essere contrastanti e conflittuali, si collocano le diverse culture
animaliste del nostro tempo. Per questo occorre capire meglio il
problema nella sua specificità concettuale e con tutte le sue
conseguenze 2
. La domanda sul chi è dell’animale va oltre il
concetto di razza a cui appartiene il singolo animale e tocca piuttosto
la specificità del termine animale, posto in relazione con l’uomo,
anch’esso animale razionale, rimandando a una evidente relazione
asimmetrica tra di loro. Ma, ciò nonostante, esiste una caratteristica
comune tra l’animale e l’uomo, come emerge dal Trattato di Lisbona
del 13 dicembre 2007, in cui si riconosceva, anche sotto il profilo
giuridico, che gli animali erano esseri senzienti e gli Stati nazionali
avrebbero dovuto tenere pienamente conto del loro benessere.
Il problema si è quindi concentrato nel cercare di sviscerare quali
conseguenze questa definizione potesse avere sul piano etico e
normativo, a livello europeo e nazionale. La dialettica si è
concentrata sul termine senziente e sulle sue somiglianze e
differenze con il sentire dell’uomo, rilanciando il dibattito tra
«specismo» e «antispecismo». Ci si chiede in che misura
l’atteggiamento dell’uomo verso gli animali, compresa la valutazione
etica che si dà di determinate pratiche che riguardano gli animali,
dipenda da una nostra antropomorfizzazione verso di loro 3
. È
evidente come l’antropomorfizzazione sia un atteggiamento
ineliminabile perché la nostra stessa evoluzione ci ha indotto a
comprendere e interpretare il comportamento degli animali in
funzione della nostra stessa sopravvivenza, delle nostre esigenze e
dei nostri stili di vita 4
. Si è creato quindi un approccio culturale che
interpreta le relazioni tra uomini e animali secondo una linea di
continuità con gli uomini, considerando entrambi esseri senzienti,
ossia capaci di provare sensazioni. Esiste anche un approccio
culturale distinto per cui il concetto di specie marca una differenza
sostanziale. Ma anche affermando che si tratti di specie diverse,
alcuni ritengono che non si possano trattare gli animali in maniera
utilitaristica e discriminatoria proprio in base alla differenza di specie.
In questo senso, tutta una serie di pratiche risulta moralmente
sbagliata, dall’alimentazione a base di animali fino ad ambiti più
problematici, come la sperimentazione farmacologica sugli animali,
tanto che oggi si utilizza la nozione di «benessere animale», di cui la
sperimentazione deve comunque tenere conto. Ovviamente con il
termine «antropomorfizzazione» non si tratta di attribuire intenzioni e
sensazioni umane agli animali, quanto piuttosto di applicare un
sostrato comune di intenzioni e sensazioni che appartengono agli
uni e agli altri 5
.
Certo è che per analizzare il cambio di paradigma che in questi
ultimi anni si è venuto strutturando, occorre precisare ogni volta a
quale corrente di pensiero si fa riferimento; non c’è un animalismo di
riferimento comune a tutti, ma visioni diverse del mondo animale e
delle sue prerogative, compresa quella che pone il problema dei
diritti degli animali. Ma ciò a cui non si può comunque rinunciare è
proprio il vasto tema della loro tutela, che pur rimandando a culture
diverse e quindi ad approcci diversi, richiede sempre e comunque
all’uomo di declinare un rapporto di tutela nei loro confronti.
Il sentire degli animali e il paradigma della cura
Il sentire dell’animale rimanda non solo al loro benessere, ma
anche al loro malessere, ossia alla loro capacità di soffrire. Di fatto il
problema di fondo è costituito dalla valutazione della sofferenza
animale e dalla responsabilità dell’uomo di evitare agli animali
qualunque sofferenza aggiuntiva. Il dolore e la sofferenza fanno
parte integrante della vita di ogni essere, compreso l’animale, sono a
modo loro una dimostrazione concreta della vita stessa. Ma questo
non autorizza nessuno ad essere causa di sofferenza per gli altri,
neppure per gli animali, a meno che la sofferenza indotta non sia
funzionale allo stesso benessere degli animali. Un’analisi delle
dottrine storiche che riguardano la condizione degli animali, da
quelle relative all’utilitarismo e al contrattualismo a quelle dei diritti
naturali, ha indotto il Comitato Nazionale per la Bioetica a scegliere
come punto di partenza una riflessione che fosse la più vicina
possibile all’esperienza relazionale dell’uomo col mondo animale. Il
perché di questa scelta è evidentemente legato al fatto che l’uomo è
l’unico essere capace di riflettere su di sé e sulle sue relazioni,
comprese quelle con gli animali, di elaborare questa riflessione e di
comunicarla per condividerla con altri e trarne le conseguenze.
Difficile immaginare nella relazione dell’animale con altri animali
quali possano essere le immagini, le fantasie e le eventuali
considerazioni che gli animali stessi potrebbero elaborare e quindi le
conseguenze che potrebbero ricavarne 6
. È vero che
dall’osservazione del comportamento animale è possibile intuire
qualcosa di ciò che sentono, degli effetti che certi stimoli e certe
emozioni provocano in loro; ma è pur sempre l’uomo che ricava
queste considerazioni, che attribuisce loro dei significati e tenta delle
interpretazioni. È nella relazione uomo-animale che prende forma la
comprensione di ciò che l’animale è e sente; compreso il come si
sente in termini di benessere e malessere. Per questo si è giunti a
elaborare criteri più appropriati di riflessione, partendo da un
principio di precauzione ambientale e da un principio di
responsabilità nei confronti del mondo animale. Ci si è quindi
concentrati sul tema della cura, uno dei paradigmi relazionali più
potenti e ricchi di implicazioni 7
. Ci si prende cura di chi si ama e di
chi ha bisogno; di chi soffre e di chi, nella sua fragilità, non è in
grado di far da sé 8
. Nella relazione di cura ci si mette in gioco a
partire dalla convinzione di poter fare qualcosa per qualcuno che
non è in grado di far da sé. Ci si prende cura di un animale e di un
uomo, di un gruppo o di una comunità, in modo diverso, a seconda
della specificità dei bisogni emergenti. Non si può certo negare, anzi
bisogna riconoscere, che spesso sono gli animali a prendersi cura
dei loro simili, come accade nella pet therapy, ma anche
nell’esperienza quotidiana di chi si occupa di loro, intuendone
bisogni e necessità.
Rifiutata con tutta la convinzione e l’energia necessaria la cultura
del dispotismo nei confronti degli animali, si può perseguire il
paradigma della cura, ispirato a una prospettiva di antropocentrismo
riflessivo che vede la responsabilità etica dell’uomo estesa anche
agli altri esseri viventi, animali compresi. Non solo, il paradigma della
cura si può estendere anche a tutto l’ambiente che ci circonda, in
una visione ecologica di tipo teocentrico, come quella che propone
Papa Francesco nella enciclica Laudato si’, che vede la natura in
una condizione di cui l’uomo è solamente custode e non padrone.
Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla
meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra
relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del
consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi
interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la
sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea.
Che gli animali meritino un’adeguata tutela da parte dell’uomo, un
vero e proprio rapporto di cura, è un concetto ampiamente condiviso
nella nostra cultura, che lo considera un passaggio essenziale nel
rispetto che l’uomo deve avere nei confronti dell’ambiente in cui vive
e della sua biodiversità. La stessa salvaguardia della biodiversità
degli animali diventa un elemento di cura, che offre all’ambiente
elementi di tutela e di presa in carico che in un’ottica globale non
possono essere sottovalutati. La biodiversità infatti è strettamente
legata alla biologia evolutiva, alla genetica, all’etologia, e gli animali,
proprio con la loro differenza, rappresentano in questo quadro un
importante punto di riferimento per capire come la biodiversità
influisca sulla funzione ecologica nella sua complessità. Se una
razza, una specie di animali, scompare, tutto l’universo ne risulta
impoverito; indagarne le cause significa mantenere alto il livello di
guardia tra ambiente ed epigenetica; il che comporta garantire
attraverso la salvaguardia del mondo animale la salvaguardia di tutto
l’ambiente che ci circonda. Per questo il tema della cura degli
animali, pur essendo la chiave di volta per penetrare nel senso
dell’identità animale, presenta nodi da sciogliere, tutt’altro che facili e
scontati. È il paradigma della cura che si articola in modo
multidimensionale e che intercetta bisogni diversi a seconda che si
tratti di animali da compagnia o di animali selvatici; di animali
addestrati alla sicurezza o alla pet therapy; di animali di cui ci
ciberemo o di animali liberi nel loro ambiente.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :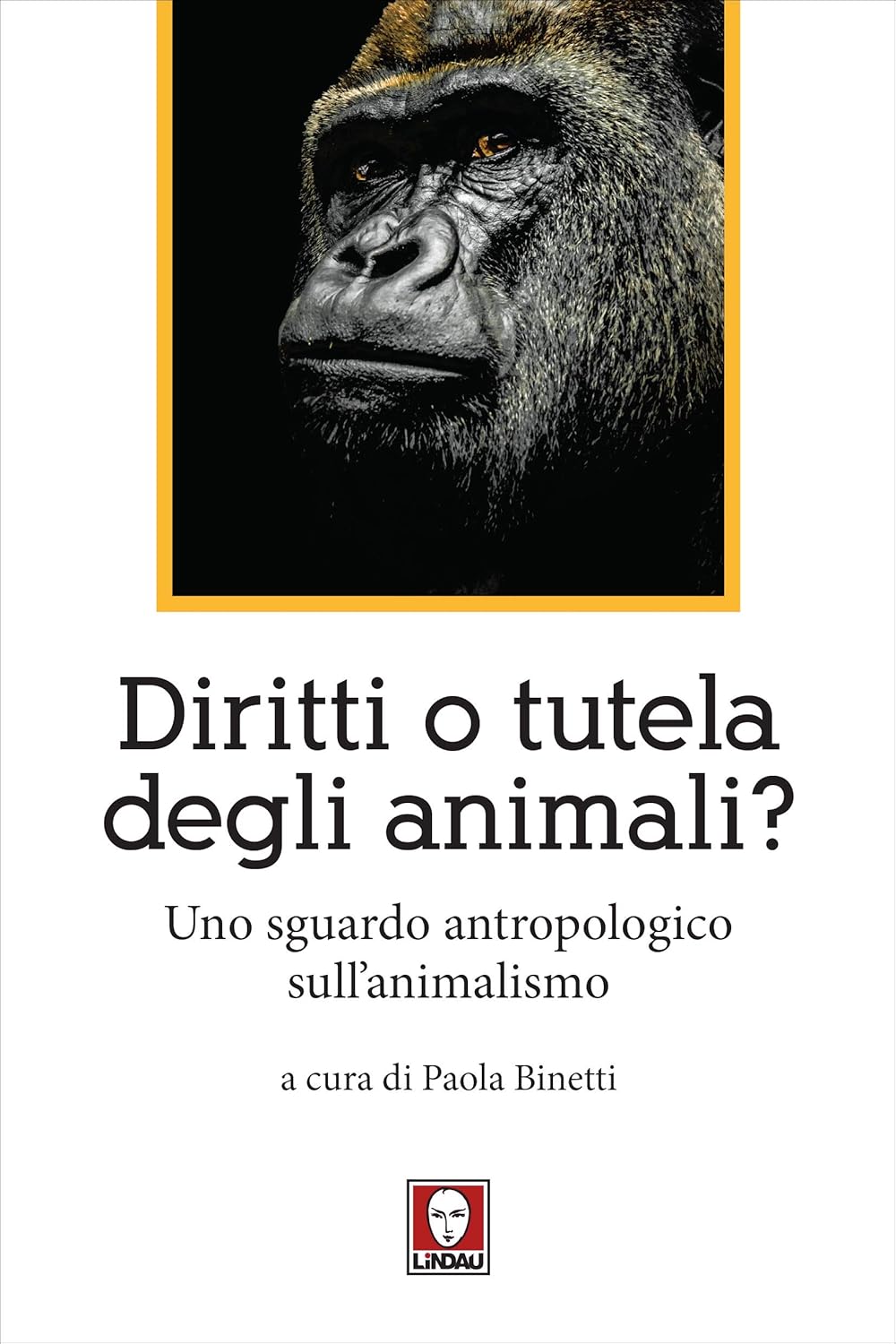






Commento all'articolo