Dio odia le donne – Giuliana Sgrena

SINTESI DEL LIBRO:
«E adesso, bambini, preghiamo tutti insieme per la vostra compagna
Giuliana…»
L’orribile puzza di minestra mi perseguitava ancora, quel 1º ottobre del
1954, mentre aspettavo di entrare per la prima volta nell’aula dove avrei
passato i cinque anni delle scuole elementari. Quella puzza l’avevo già
sentita un paio d’anni prima nella mensa dell’edificio, che ospitava anche
l’asilo. Una donazione della Fondazione Mellerio, un’istituzione nel piccolo
paese dove sono nata, Masera, vicino a Domodossola, quasi in Svizzera.
Poco più di mille anime, a fondovalle, nel cuore di quella che fu la
Repubblica dell’Ossola, il primo territorio italiano liberato dal
nazifascismo. Un soffio di libertà durato solo quaranta giorni.
All’asilo avevo passato un solo giorno: i miei strilli avevano commosso
zia Maria (io la chiamavo semplicemente zia, ma era la sorella della mia
bisnonna Giulietta). La zia, una donna alta – o almeno io la vedevo così – e
magra, mi aveva liberata dall’odore di minestra e da quei fantasmi neri, le
suore che gestivano la scuola materna. Gli stessi fantasmi li avrei ritrovati
alle elementari, perché, nonostante fosse una scuola pubblica, due classi
erano gestite dalle suore, e una era proprio la mia. Non mi sono mai
spiegata il perché, ma erano altri tempi, negli anni cinquanta succedeva
anche questo. Mio padre era stato partigiano, ma all’epoca non era una cosa
così apprezzata né un titolo di merito per trovare lavoro; qualche anno dopo
la situazione sarebbe cambiata. Ma alla mia maestra, suor Natalina, bassa e
grassoccia, non importava cosa avesse fatto mio papà, bensì quello che era:
un comunista. Io non sapevo nemmeno cosa volesse dire, ma tant’è.
A me piaceva andare a scuola e studiare, ero anche la prima della classe,
ma ogni volta che entravo in aula mi sentivo male: la suora faceva sempre
recitare una preghiera prima dell’inizio delle lezioni (mattino e pomeriggio)
e chiedeva a tutti i bambini di pregare per me. Per me che, secondo la
maestra, vivevo in un inferno, che avevo per padre il diavolo in persona.
Era un incubo per una bambina di sei anni. Io stavo bene con la mia
famiglia, avevo un buon rapporto con mia madre – probabilmente solo una
vittima secondo la maestra, che infatti non infieriva mai contro di lei – e
anche con mio padre; come poteva essere un demone? L’essere comunista
non gli aveva impedito di mandarmi a scuola dalle suore e nemmeno di
battezzarmi, anche perché senza battesimo sarei stata discriminata.
Allora non si poteva mangiare carne il venerdì, e comunque noi non ce la
potevamo permettere tanto spesso, casomai la domenica. A ogni modo,
regolarmente, il venerdì, al rientro pomeridiano, la maestra mi chiedeva
cosa avessi mangiato; perciò un giorno mio padre mi suggerì di dire che
avevo mangiato una fetta di minestra. «Così forse la smetterà» aveva
aggiunto.
Quando in classe riuscivo a raggiungere un punto di relativo equilibrio,
improvvisamente succedeva qualcosa che faceva di nuovo precipitare la
situazione. Un giorno portai a scuola un atlante e lo prestai ai miei
compagni. Non so come, ma tra le cartine geografiche era finita una
cartolina che ci aveva inviato un amico dall’Africa: era la foto di una donna
africana con il seno nudo. Un bambino la trovò e la fece subito vedere alla
maestra: apriti cielo, ecco la prova della depravazione! La cartolina finì nel
fuoco della vecchia stufa di ghisa: bruciata in una sorta di rito purificatorio.
L’inferno a quei tempi non era semplicemente una pena eterna, né il luogo
descritto da Dante, che alle elementari non si studiava; l’immaginario
cattolico era ricco di scenari angoscianti, che venivano descritti con
particolari mostruosi. Immagini del fuoco eterno che popolavano i miei
incubi notturni. Mi ricordo di aver ritrovato la stessa tecnica per terrorizzare
i bambini, e di conseguenza i genitori, durante un viaggio a Hebron, in
Palestina: gli insegnanti islamisti diffondevano video con visioni spaventose
e invitavano i bambini a mostrarli ai genitori.
La suora era decisamente impegnata a portarci sulla ‘retta via’, il che, tra
l’altro, comportava confessione e comunione tutte le settimane. Ogni
sabato, alla fine delle lezioni, venivamo spedite a confessarci per poter fare
la comunione la domenica (noi femmine, perché i maschi se la
squagliavano, e questo veniva dato per scontato dalla suora, che già li
riempiva di pizzicotti per tenerli a bada durante le ore di lezione). Poi il
prete del paese, don Giovanni, si stufò di perdere tempo con noi ogni
sabato. Un pomeriggio d’ottobre stava facendo la vendemmia e non aveva
intenzione di interrompere il suo lavoro: «Cosa avrete mai da confessare» ci
apostrofò. «Dite un’avemaria e i vostri peccati saranno perdonati, così
domani potrete fare la comunione», e ci diede l’assoluzione mentre si
allontanava con la sua brenta piena d’uva in spalla. Don Giovanni era meno
zelante delle suore e non si preoccupava del fatto che mio padre era
comunista, anzi, spesso approfittava di lui per avere un passaggio in
macchina. Del resto erano anche i tempi di Peppone e don Camillo.
E poi il prete aveva le sue buone ragioni: che peccati potevamo mai
commettere noi bambine, che vivevamo in un paesino senza nessuna
distrazione, non avevamo nemmeno la tivù e quando i nostri vicini la
comprarono fu un vero avvenimento. Io poi ero una bambina tranquilla, che
scontava le colpe anche per i disastri combinati da mio fratello – che aveva
cinque anni meno di me, ma era un vero discolo.
Che bisogno c’è di una confessione settimanale? La religione cattolica è
l’unica a prevedere la confessione dei peccati a una terza persona, un prete
(non Dio) al quale viene riconosciuta l’autorità di perdonarli. Nella Bibbia e
nel Nuovo Testamento non si parla di confessione, che è stata istituita solo
nel 1215, evidentemente per estendere il controllo sociale e forse anche
sessuale, visto che il potere di confessare e di perdonare i peccati è
attribuito solo a un maschio. E, se ci penso, a confessarsi ho sempre visto
soprattutto femmine. Forse hanno maggiore timore di Dio. Mi ricordo
anche che nel confessionale la domanda più ricorrente era: «Hai commesso
atti impuri?». Allora non avevo ancora scoperto che le religioni usano ogni
mezzo per avere il controllo sulla sessualità delle donne e me ne
meravigliavo.
Suor Natalina non si accontentava del rispetto che dimostravo per tutti i
canoni della Chiesa. L’unica possibilità di redimermi consisteva – secondo
lei – nell’allontanarmi dalle tentazioni di casa e farmi suora. La pressione
era così forte che, non ricordo se per sottrarmi a ulteriori assedi o perché il
plagio aveva funzionato, mi ero convinta che la mia sorte fosse segnata: non
avrei avuto altra scelta che consegnarmi alla volontà di Dio, o meglio di
suor Natalina.
In casa mia non ci credevano molto; qualcuno mi prendeva in giro e mio
fratello, che a sua volta è andato a scuola da suor Natalina, non ha mai
avuto le pressioni che ho subito io. Ma lui era un maschio e, sebbene fosse
stato indottrinato come tutti – allora non ci si poteva sottrarre
all’insegnamento del catechismo –, l’unico effetto sortito era che voleva
assolutamente andare a visitare Gerusalemme. Poi a Gerusalemme ci sarei
andata solo io, ma ero già in un’altra vita.
Perché sono solo le donne a dover espiare? Perché i credenti – in base alla
Bibbia – ritengono che il male sia una conseguenza del peccato originale.
Ed essendo stata Eva a cadere in tentazione e a mangiare il frutto proibito
offerto poi a Adamo, è la donna la causa di tutti i mali.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :



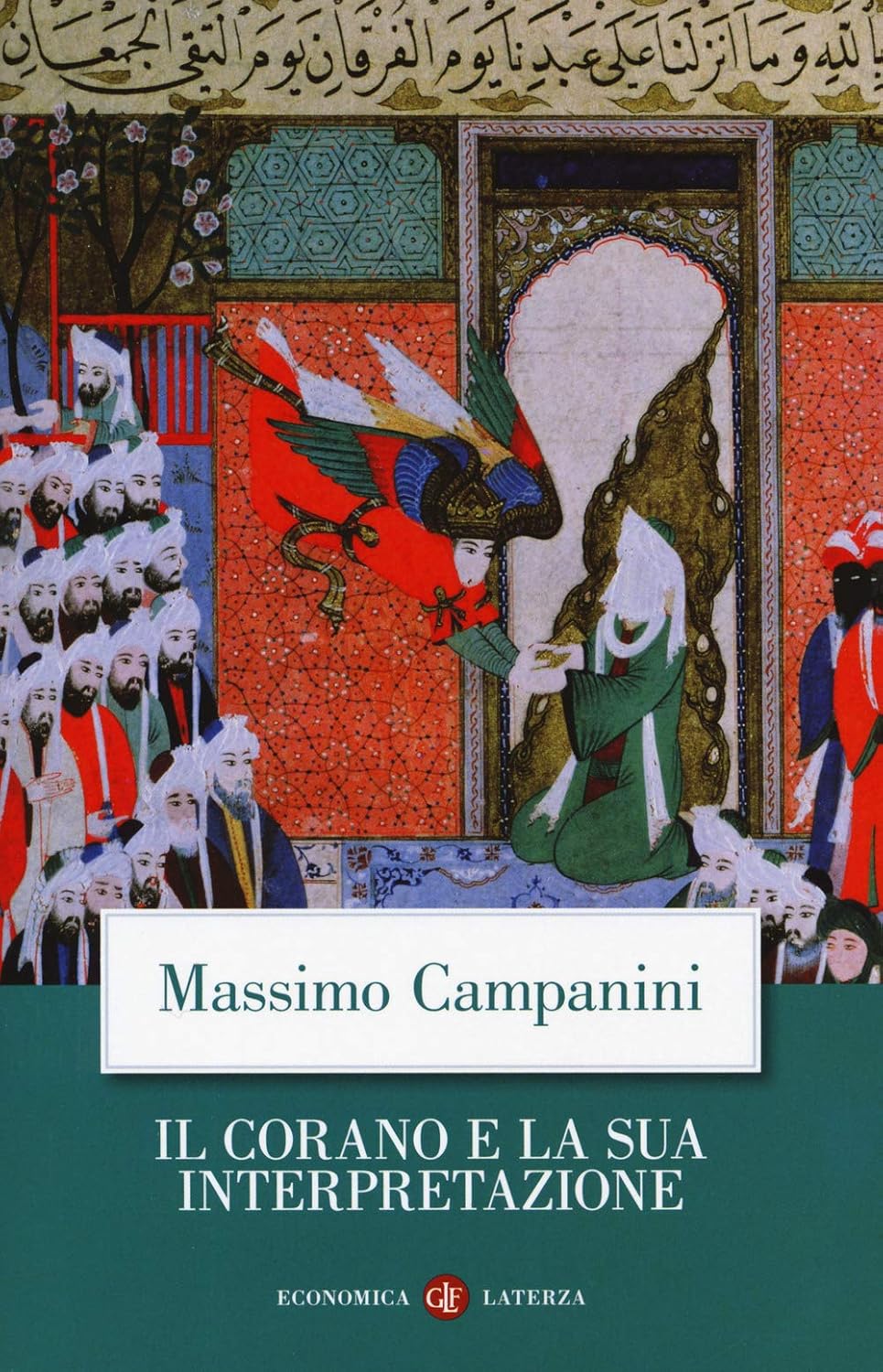

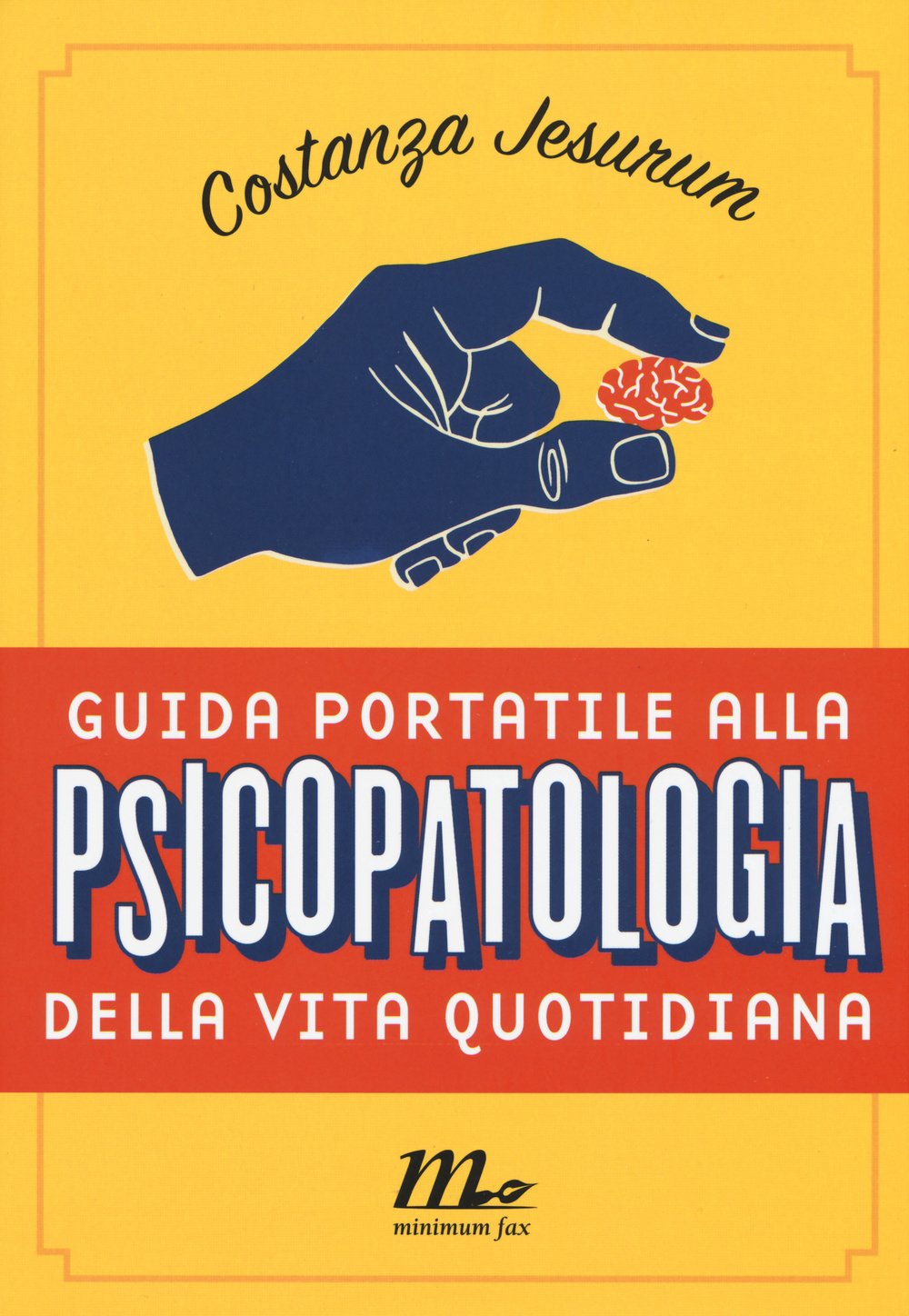
Commento all'articolo