Consumo, dunque sono – Zygmunt Bauman
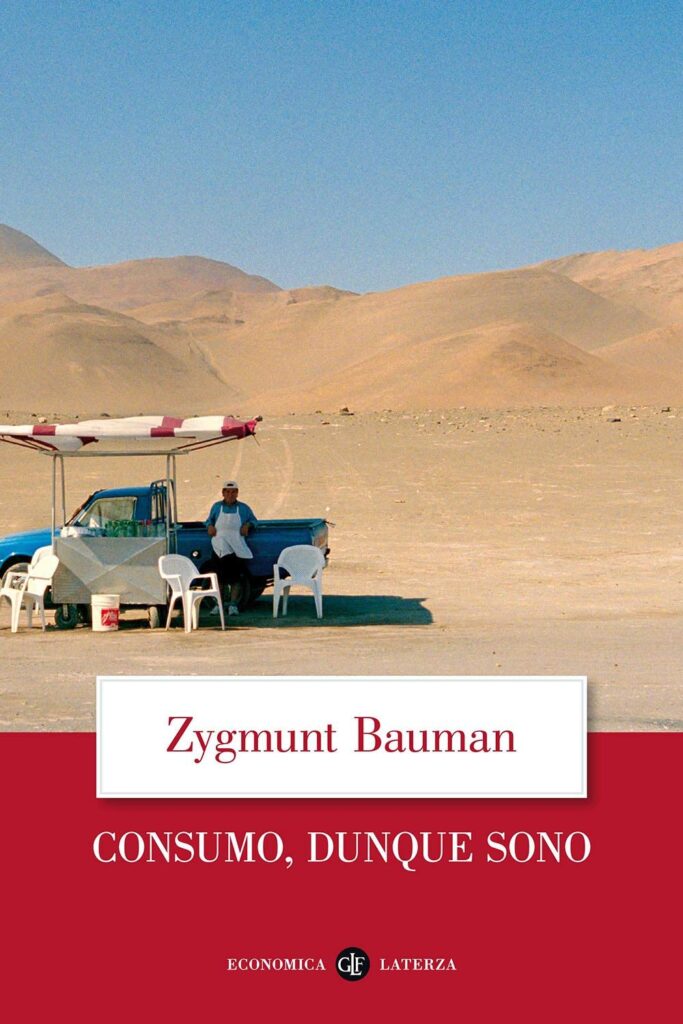
SINTESI DEL LIBRO:
Apparentemente il consumo è un fatto comune, se non
addirittura insignificante. Ognuno di noi ogni giorno consuma: a
volte lo facciamo con allegria - quando organizziamo una festa,
celebriamo un evento importante o ci gratifichiamo per essere
riusciti a fare qualcosa di particolarmente ragguardevole - ma il più
delle volte "di fatto", potremmo dire di routine, senza pianificarlo
granché o starci a pensare su.
In effetti il consumo, se ridotto alla sua forma essenziale del ciclo
metabolico di ingestione, digestione ed escrezione, è una condizione
e un aspetto permanente e ineliminabile della vita svincolato dal
tempo e dalla storia, un elemento inseparabile dalla sopravvivenza
biologica che gli esseri umani condividono con tutti gli altri
organismi viventi. Così descritto, il fenomeno del consumo ha radici
tanto antiche come quelle degli organismi viventi, ed è certamente
un aspetto permanente e integrante di qualsiasi forma di vita nota
dalle narrazioni storiche e dai resoconti etnografici. Apparentemente
niente di nuovo sotto il sole... Qualsiasi forma di consumo
considerata tipica di una specifica epoca della storia umana può
essere presentata senza grande sforzo come versione leggermente
modificata delle usanze/abitudini del passato/trascorse. In questo
campo la continuità sembra essere la regola; salti, discontinuità,
cambiamenti radicali o rivoluzionari, eventi spartiacque, possono
essere (e molte volte sono) sconfessati in quanto trasformazioni
puramente quantitative ma non qualitative. Eppure, se l'attività del
consumare in quanto
_______
"Excursus" sul metodo dei tipi ideali
Nell'intento di evitare le controversie, inevitabilmente
irrisolvibili, sull'unicità o generalità, ovvero sulla peculiarità o
ordinarietà, dei fenomeni analizzati è opportuno un avvertimento
preliminare. E fuori discussione che nella storia umana nulla o quasi
sia totalmente nuovo, se ciò significa non avere alcun precursore nel
passato; le catene causali possono sempre essere allungate a ritroso
all'infinito. Ma è anche indiscutibile che persino i fenomeni di cui è
possibile dimostrare la presenza universale assumano configurazione
in certo qua] modo diversa in diverse forme di vita: ed è la
particolarità della configurazione a "fare la differenza", molto più
della specificità degli ingredienti. Il modello del "consumismo", come
quelli della "società dei consumatori" e della "cultura del consumo"
qui presentati sono quelli che Max Weber definì "tipi ideali":
astrazioni che puntano a cogliere l'unicità di una configurazione
composta di ingredienti tutt'altro che unici e a separare gli schemi
che definiscono tale configurazione dalla moltitudine degli aspetti
che essa condivide con altre. La maggior parte, se non la totalità, dei
concetti abitualmente utilizzati dalle scienze sociali - ad esempio
"capitalismo", "feudalesimo", "libero mercato", "democrazia", e
anche "società", "comunità", "luogo", "organizzazione" o "famiglia" -
hanno lo status di tipi ideali. Come afferma Weber, i tipi ideali (se
costruiti correttamente) sono strumenti cognitivi utili, e anzi
indispensabili, anche se (o forse proprio perché) essi fanno
intenzionalmente luce solo su determinati aspetti della realtà sociale
che rappresentano, lasciando in ombra altri aspetti che essi
considerano meno rilevanti, o semplicemente casuali, rispetto alle
caratteristiche essenziali, necessarie, di una determinata forma di
vita. I tipi ideali non sono descrizioni della realtà: sono gli strumenti
utilizzati per analizzarla. Essi sono utili per pensare; o, come si può
sostenere paradossalmente, nonostante la loro natura astratta
consentono di descrivere la realtà sociale empirica, così come è
accessibile all'esperienza. Questi strumenti sono insostituibili in
qualsiasi tentativo di rendere i pensieri intelligibili e di descrivere in
modo coerente le risultanze terribilmente confuse dell'esperienza
umana. Ma ricordiamo il modo elegante e convincente in cui lo
stesso Max Weber ne giustificava la costruzione e l'utilizzo, una
posizione che non ha perso nulla della sua attualità e rilevanza per la
prassi sociologica:
[... l'analisi sociologica] si distacca dalla realtà, e serve alla
conoscenza di questa in quanto, fornendo la misura
dell'avvicinamento di un fenomeno storico ad uno o a più di tali
concetti, consente di sottoporlo a un ordine. Il medesimo fenomeno
storico può, ad esempio, configurarsi in una parte dei suoi elementi
come fenomeno "feudale", in un'altra come fenomeno
"patrimoniale", in un'altra ancora come fenomeno "burocratico"
oppure "carismatico". Affinché questi termini possano designare
qualcosa di univoco, la sociologia deve, chi parte sua, formulare tipi
"puri" (cioè tipi ideali) di formazioni di quel genere, le quali
mostrano in sé l'unità conseguente della più completa adeguazione di
senso, ma appunto per ciò non si presentano in questa forma
assolutamente e idealmente pura, [...]. Soltanto muovendo dal tipo
puro (cioè dal tipo "ideale") è possibile una casistica sociologica1.
Se teniamo a mente le parole di Weber possiamo tranquilla
mente continuate a utilizzare con la dovuta cautela dei costrutti
"puri", nel nostro sforzo per rendere intelligibile, e dunque
comprendere, una realtà dichiaratamente "spuria", evitando al
tempo stesso le trappole che attendono l'incauto che tenda a
confondere i tipi ideali "puri" con i "fenomeni reali". Possiamo
dunque procedere a costruire i modelli del consumismo, della società
dei consumatori e della cultura consumistica, che ad avviso di chi
scrive sono gli strumenti che occorrono per comprendere un aspetto
cruciale della società in cui oggi viviamo, ed elaborare così una
descrizione coerente della nostra esperienza condivisa di questo
vivere.
____________
tale sembra lasciare poco spazio all'inventiva e agli stratagemmi,
ciò non vale per la parte che il consumo ha svolto nelle
trasformazioni passate e che esso svolge nelle dinamiche attuali del
modo umano di esserenelmondo, e in particolare per il posto che
esso occupa tra i fattori che determinano lo stile e per così dire
l'aroma della vita sociale, e per il ruolo che ha nel determinare gli
schemi delle relazioni interumane (uno dei tanti, o anche lo schema
fondamentale).
Per tutta la storia umana le attività del consumo o legate ai
consumi (produzione, accumulazione, distribuzione e smaltimento
degli oggetti di consumo) hanno fornito una costante disponibilità di
"materia prima" da cui plasmare la varietà di forme di vita e di
schemi delle relazioni tra gli uomini con l'ausilio dell'inventiva
culturale guidata dall'immaginazione. Fatto ancor più fondamentale,
quando tra gli atti del produrre e del consumare si aprì uno spazio
suscettibile di estensione, ciascuno di tali atti acquisì una crescente
autonomia dall'altro e poté essere regolato, indirizzato e gestito da
complessi di istituzioni reciprocamente indipendenti. Dopo la
"rivoluzione paleolitica", che pose fine al modo di vivere alla giornata
tipico dei raccoglitori e inaugurò l'era del surplus e
dell'accumulazione, divenne possibile scrivere la storia dal punto di
vista degli ingegnosi modi escogitati per colonizzare e gestire tale
spazio.
Qualcuno ha sostenuto (e in questo capitolo si sosterrà e si
elaborerà questa tesi) che un punto di rottura carico di conseguenze,
che si può dire abbia meritato il nome di "rivoluzione consumistica",
sia stato raggiunto millenni dopo con il passaggio dal consumo al
"consumismo", nel momento in cui il consumo, come scrive Colin
Campbell, ha acquisito nella vita della maggior parte delle persone
una "importanza particolare, se non centrale", trasformandosi nello
"scopo stesso dell'esistenza"2, e in cui "la nostra capacità di "volere",
di "desiderare" e di "agognare", e specialmente di fare esperienza
ripetuta di tali emozioni, diventa l'effettivo fondamento
dell'economia" della comunanza umana.
Possiamo dire che il "consumismo" è un tipo di assetto sociale
che risulta dal riutilizzo di bisogni, desideri e aspirazioni dell'uomo
prosaici, permanenti e per così dire "neutrali rispetto al regime",
facendone la principale forza che alimenta e fa funzionare la società e
coordina la riproduzione sistemica, l'integrazione sociale, la
stratificazione sociale e la formazione degli individui, oltre a svolgere
un ruolo di primo piano nei processi di autoidentificazione
individuale e di gruppo e nella scelta e ricerca dei modi per orientare
la propria esistenza. Vi è "consumismo" là dove il consumo assume
quel ruolo cardine che nella società dei produttori era svolto dal
lavoro. Come sottolinea Mary Douglas, "se non sappiamo perché le
persone hanno bisogno di lussi [ossia di beni che vanno al di là dei
bisogni di sopravvivenza] e che uso ne fanno, siamo ben lontani dal
prendere sul serio i problemi della disuguaglianza"3.
A differenza del consumo, che è soprattutto caratteristica e
attività di singoli esseri umani, il consumismo è un attributo della
società. Affinché una società lo abbia è necessario che la capacità
totalmente individuale di volere, desiderare e agognare, proprio
come nella società dei produttori accadeva alla capacità di lavorare,
sia distaccata ("alienata") dagli individui e riconvertita/ reificata
come forza estranea che mette in moto la "società dei consumatori" e
la mantiene in rotta in quanto forma specifica di comunanza umana,
del inondo al tempo stesso dei parametri specifici per efficaci
strategie di vita individuali e manipolando le probabilità di scelta e di
comportamento individuali.
Tutto ciò dice ancora poco sul contenuto della "rivoluzione
consumistica". Le domande su cui occorre indagare più da vicino
riguardano cosa "vogliamo", "desideriamo" e "agogniamo", e comenel corso (e in conseguenza) del passaggio al consumismo - la
sostanza del nostro volere, desiderare e agognare si modifichi.
Si pensa di solito (impropriamente, si direbbe) che gli uomini e le
donne collocati nell'ambito della forma di vita consumistica
desiderino e agognino, prima e al di sopra di tutto, acquisire,
possedere e accumulare oggetti, valutati in base agli agi e al prestigio
che si prevede possano offrire a chi li ha.
L'appropriazione e il possesso di beni che assicurino (o almeno
promettano) comodità e prestigio erano forse le principali
motivazioni dei desideri e delle aspirazioni umane nella società dei
produttori: un tipo di società dedito alla sicurezza stabile e alla
stabilità sicura e che per riprodursi nel lungo periodo faceva
affidamento su schemi di comportamento individuale pensati in
funzione di tali motivazioni.
In effetti la società dei produttori - principale modello di società
nella fase "solida" della modernità - era orientata in primo luogo
sulla sicurezza. Nella sua ricerca di sicurezza essa faceva leva sul
desiderio umano di vivere in un contesto affidabile, degno di fiducia,
ordinato, regolare, trasparente e al tempo stesso durevole, resistente
e sicuro. Un simile desiderio era effettivamente una materia prima
eccellente per costruire i tipi di strategia di vita e di schema di
comportamento necessari per sopperire alle esigenze dell'epoca in
cui "l'unione fa la forza" e "grande è bello": epoca di fabbriche e di
eserciti di massa, di regole vincolanti cui conformarsi, di strategie di
dominio burocratiche e panoptiche che nel loro sforzo di stimolare
disciplina e subordinazione si basavano sulla standardizzazione e
routinizzazione della condotta individuale.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :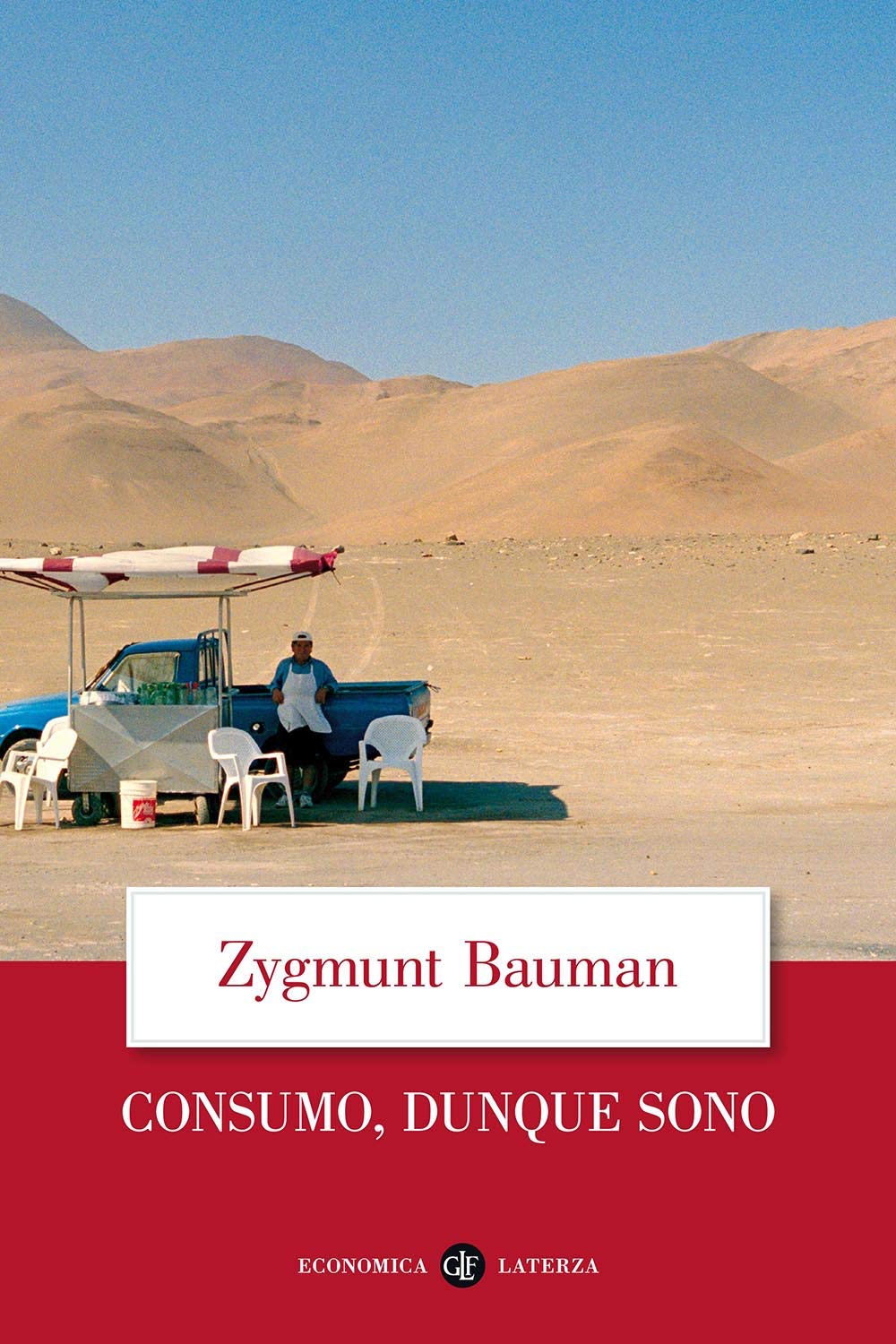






Commento all'articolo