Allenare il corpo, allenare la mente. Gli sport di resistenza come palestra di vita – Nicola Pfund
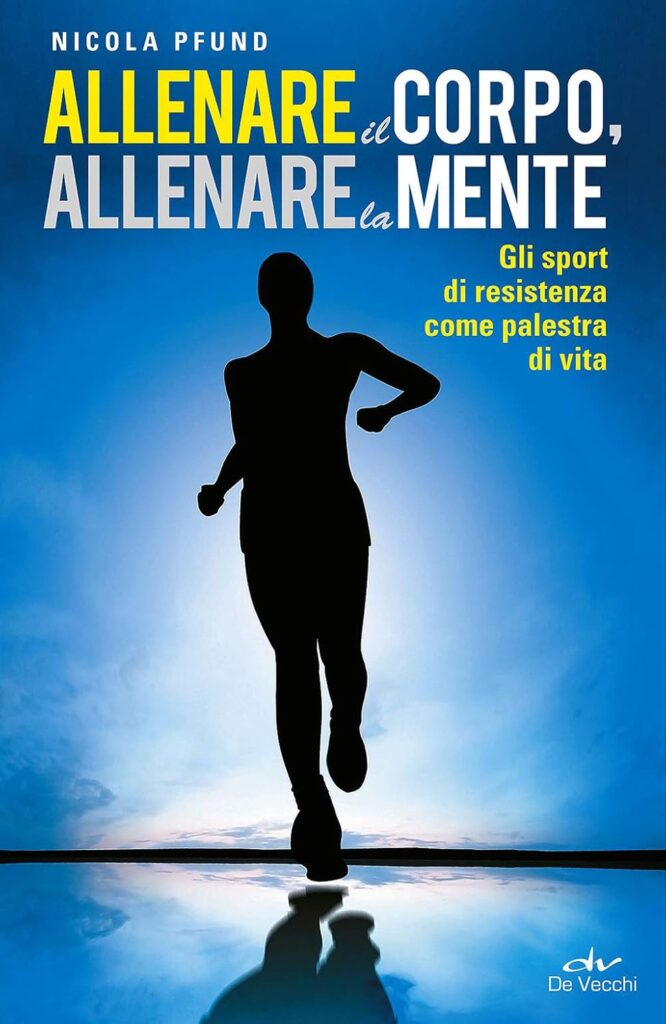
SINTESI DEL LIBRO:
La pianificazione degli allenamenti è simile a una piramide che si
sviluppa in un arco di tempo di alcuni mesi, solitamente da ottobrenovembre a maggio-giugno dell’anno successivo. In questa
piramide della preparazione ogni livello è costruito sul precedente e
conseguente a esso. Alla base di tutto, quindi, vi sono i lavori di
lunga durata e bassa intensità necessari per costruirsi la propria
resistenza aerobica. A questi si aggiungono i lavori per il
perfezionamento della propria tecnica e quelli che hanno come
obiettivo il potenziamento muscolare. Nella parte centrale si
collocano i lavori rivolti allo sviluppo della potenza aerobica e i lavori
rivolti ad aumentare la capacità di trasferire la forza acquisita in
palestra nelle tre discipline. Il vertice della piramide corrisponde alla
fase finale della preparazione, quella più vicina al periodo delle
gare. Questa fase è riservata ai lavori a più alta intensità, che
hanno l’obiettivo di innalzare la velocità alla soglia, e agli
allenamenti combinati.
CAPITOLO 1
LO SPORT
FA PARTE DI NOI
Si inizia fin da subito, già durante la gestazione: il movimento è vita e
lo sa bene qualsiasi mamma che sente muovere dentro di sé il
proprio bambino! Immerso nel liquido amniotico, il futuro bebè fa
capriole, si succhia il pollice, fa prove di respirazione… Si sta
allenando per la vita “fuori” di lì. Una volta nato, l’esercizio prosegue:
il suo sviluppo fisico e cognitivo passa attraverso l’interazione con
l’ambiente e la conoscenza che egli fa tramite i propri sensi. Solo per
fare una piccola panoramica, “assaggiare” con la bocca qualsiasi
oggetto, gattonare, tendere le manine per farsi prendere in braccio,
giocare, controllare i propri movimenti, abbandonare il pannolino, ma
anche iniziare a camminare, cadere, rialzarsi, correre, per così dire,
incontro alla vita, è un vero e proprio lavoro che impegna a tempo
pieno. E che richiede concentrazione, fiducia nelle proprie risorse,
approvazione sociale e, non ultima, anche una corretta
alimentazione.
Ma, soprattutto, occorre quella spinta interiore che porta
all’autonomia e al piacere della scoperta che solo tramite la sua
personalissima sperimentazione il bimbo può raggiungere. Gli
insegnamenti servono, ma solo grazie alla propria percezione egli
può comprendere, per esempio, che cosa significa l’equilibrio in
varie situazioni: camminare sul bordo di un muretto, stare in bilico su
un asse instabile o afferrare e lanciare una palla sono tutte attività
che gli danno modo di provare in prima persona come si fa e, nel
contempo, di conoscere empiricamente i principi che regolano le
cose.
Non solo: il suo sviluppo motorio va di pari passo con quello
intellettivo ed è caratterizzato dalla continua scoperta, soprattutto dal
L’UOMO È FATTO PIÙ PER
MUOVERSI CHE PER STARE
FERMO
piacere di meravigliarsi. Il bambino è per sua natura curioso, avido di
conoscere. Una caratteristica che, talvolta, la routine della
quotidianità tende a far affievolire col passare degli anni, ma che è
come la brace: basta una scintilla per riaccendere quel fuoco
interiore, per riprendere a entusiasmarsi e a ricercare nuovi percorsi
di vita. Individuate la vostra scintilla. E alimentatela.
L’uomo è sempre stato un grande sportivo
L’uomo, anche nella sua situazione attuale, è fatto più per muoversi
che per stare fermo e la spiegazione viene dalla nostra evoluzione.
Da Darwin in poi è comunemente accettato che siamo il frutto di un
processo evolutivo che nel corso della storia ci ha condotti dalla
forma di ominide fino a quella attuale. Le modificazioni che ci hanno
visti protagonisti sono avvenute per almeno due ragioni. La prima è
l’adattamento all’ambiente che aumenta la possibilità di
sopravvivenza. La seconda è invece legata ai vari stili di vita che i
nostri antenati hanno adottato per sopravvivere, la caccia in primo
luogo. Comparando il comportamento alimentare dei primati, ossia le
scimmie che più ci assomigliano, si può ipotizzare che all’inizio i
nostri lontani progenitori si cibassero dei frutti di piante e alberi
disponibili in natura. Poi, condizioni ambientali modificate e un
cervello più grande ed efficiente al punto da ideare ed essere in
grado di costruire attrezzi, tra cui le armi, hanno trasformato i nostri
antenati in cacciatori a tutti gli effetti. L’attività venatoria, inoltre,
richiedeva un’organizzazione particolare. La preda, infatti, veniva
dapprima isolata e poi inseguita per molti chilometri. Era necessaria
una strategia di attacco, un’eccellente condizione fisica, ma anche
una grande tenacia e determinazione. In una parola, non bisognava
arrendersi, consapevoli che solo sfiancando l’animale alla fine ci
sarebbe stata la cattura.
Possiamo anche immaginare quanto la
caccia abbia rappresentato per quelle
piccole comunità: un momento collettivo
molto importante e di grande
soddisfazione. Lavoro di gruppo, strategia, tenacia, determinazione,
resistenza: nell’organizzazione dell’attività venatoria ritroviamo
CORRERE È UNO SCHEMA
MOTORIO PRECISO ED
ESTREMAMENTE
RAFFINATO
ABBIAMO CAPACITÀ DI
RESISTERE, DI
PERSEVERARE E DI
AUTOMOTIVARCI
numerosi elementi che ci caratterizzano ancora oggi nella nostra
essenza di uomini, anche se spesso non vengono valorizzati. La
corsa di resistenza, unitamente ad altre abilità come forza, agilità e
coordinazione, ha dunque avuto un ruolo determinante
nell’evoluzione della specie umana.
Correre è uno schema motorio preciso
ed estremamente raffinato, non un atto
arbitrario. Uno schema che l’uomo ha
migliorato in centinaia di migliaia di anni di
evoluzione. Non tutti i tipi di corsa sono
uguali: velocità oppure resistenza richiedono gesti atletici differenti,
uno sforzo anaerobico o aerobico. Nella corsa di resistenza si deve
risparmiare su tutto, persino sulla posizione delle mani, che devono
essere rilassate per ridurre al minimo qualsiasi dispendio energetico
e non rimanere senza forze proprio vicino all’obiettivo. Ed è
attraverso la resistenza che l’uomo ha costruito la sua evoluzione.
Una teoria affascinante
Le teorie di Charles Darwin, riassunte nella sua celebre opera
intitolata l’Origine della specie, sono affascinanti: l’essere umano è
un animale molto simile alle grandi scimmie. Ci ha resi quel che
siamo un lunghissimo processo evolutivo, la cui regola è la stessa
per tutti gli esseri viventi, vegetali compresi: la selezione naturale, la
sopravvivenza del più adatto. A questo si è aggiunto il tipo di
intelligenza che ci caratterizza: nessuno ne ha una uguale sul
pianeta. In più abbiamo un misto tra capacità di resistere, di
perseverare e di automotivarci.
La nostra capacità di adattamento è
stata un’importante spinta evolutiva che ci
ha permesso di essere bravi in tanti campi
pur senza eccellere in nessuno. A
differenza delle altre specie viventi, siamo
stati in grado di sopravvivere praticamente in ogni condizione
ambientale, salvandoci dall’estinzione e trasformandoci in ciò che
siamo oggi. Ormai la nostra sopravvivenza è assicurata: semmai i
pericoli vengono proprio da noi stessi. Abbiamo un’intelligenza che a
LO SPORT ERA UN RITO
SIMBOLICO CHE
PREPARAVA ALLA GUERRA
volte può ritorcersi contro di noi (pensiamo a talune invenzioni che
oggi, più che un beneficio, sono un pericolo per l’umanità) e
possediamo in misura eccezionale, anzi quasi esclusiva, un altro
istinto: l’aggressività intraspecifica, cioè quella che rivolgiamo contro
i nostri simili e che si manifesta attraverso le innumerevoli guerre
che hanno caratterizzato la nostra storia. Anche la preparazione alla
guerra, pur nella sua tragicità, è stato un altro campo di allenamento
eccezionale in cui, alle qualità strategiche e alla resistenza nella
corsa o nella marcia, sono state aggiunte altre abilità come forza,
coordinazione, agilità, tecnica e tattica.
Lo sport nel tempo
Lasciando da parte Darwin e le sue teorie evoluzionistiche, arriviamo
alla nascita dell’attività sportiva più o meno come la intendiamo oggi,
avvenuta nell’antichità classica con le prime olimpiadi.
Le competizioni avevano però
caratteristiche molto diverse da quelle
attuali. Per esempio, gli sport violenti,
come lotta e pugilato, non erano sottoposti
a regole o a controlli rigorosi e accadeva spesso che il
combattimento si concludesse con la morte di uno dei due
contendenti. Lo sport era, con ciò, la rappresentazione “cruda” dello
spirito guerriero di allora. Era un rito simbolico che preparava alla
guerra ma, come sempre, era anche lo specchio della società: nel
mondo greco, infatti, esso rappresentava la bellezza e l’armonia.
L’atleta, che proveniva sempre da classi sociali elevate, aveva il
culto della perfezione del proprio corpo, preparato con costanza e
finalizzato alla battaglia o ai giochi olimpici. Un corpo bello, dove
“bello” era anche “buono” nel senso di virtuoso, era fondamentale
per i greci, il fine altissimo di questi uomini.
Tale simbiosi tra corpo, mente ed educazione estetica è stata in
parte recuperata ai giorni nostri, ma, all’epoca, era invece ben
lontana, per esempio, dalla mentalità dei romani, che concepivano
l’attività fisica solo come impegno militare o come sport-spettacolo
praticato nei circhi, luoghi preposti allo svolgimento delle corse con
le quadriglie e, successivamente, negli anfiteatri destinati a ospitare i
L’INATTIVITÀ DIVENNE UNO
STATUS SYMBOL
giochi con i gladiatori, protagonisti di cruenti combattimenti che si
concludevano per lo più con la morte di uno dei contendenti. I
gladiatori seguivano un piano di addestramento fisico molto intenso
per preparare al meglio i loro combattimenti e, in buona sostanza,
per poter sopravvivere agli avversari.
Andando in là nei secoli, durante il Medioevo, invece, si diffuse
un disinteresse per la “fisicità” e la “corporeità”. Il corpo inteso anche
come fonte di piacere dei sensi finì, quindi, in una sorta di oblio a
vantaggio della spiritualità. Anzi, veniva sottoposto a estenuanti
digiuni e mortificazioni per arrivare a una purificazione spirituale.
Tuttavia anche nel Medioevo si doveva combattere, e non poco,
visto l’imperversare delle guerre, e perciò occorreva essere
preparati: questo, infatti, era l’unico ambito di rivalutazione della
prestanza fisica. L’addestramento militare era indispensabile e
addirittura invocato se dedicato alla salvaguardia della cristianità: ne
sono un esempio le Crociate.
Nei secoli successivi, l’inattività divenne
uno status symbol, un modo per dimostrare
che, per vivere, non si doveva faticare
nemmeno per spostarsi da un piano all’altro dei palazzi, o per
compiere viaggi… I “signori” stavano al “piano nobile” delle case,
ossia il primo, proprio per non compiere sforzi inappropriati alla loro
condizione sociale!
La storia dello sport vive finalmente una svolta decisiva a partire
dalla rivoluzione industriale e, in particolare, con la meccanizzazione
delle fabbriche inglesi di metà Ottocento, che consentì anche alla
classe operaia e alla borghesia dell’epoca di disporre di maggior
tempo libero. Con l’accorciarsi della giornata lavorativa si creò uno
spazio libero in cui si inserì l’attività sportiva. Tuttavia la fruibilità di
questo tempo era un po’ un’illusione: in realtà, lo sport divenne una
forma di controllo sociale che doveva permettere alle maestranze
anzitutto di scaricare le tensioni, ma anche di interiorizzare le norme
della società, senza rimetterne in questione i principi. Come?
Facendo in modo di riproporre nello sport quello che avveniva in
fabbrica, sul lavoro. Il calcio con la sua organizzazione razionale o
l’atleta con la ripetizione all’infinito dello stesso gesto erano l’esatta
riproduzione di quanto avveniva in fabbrica nel lavoro a catena.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :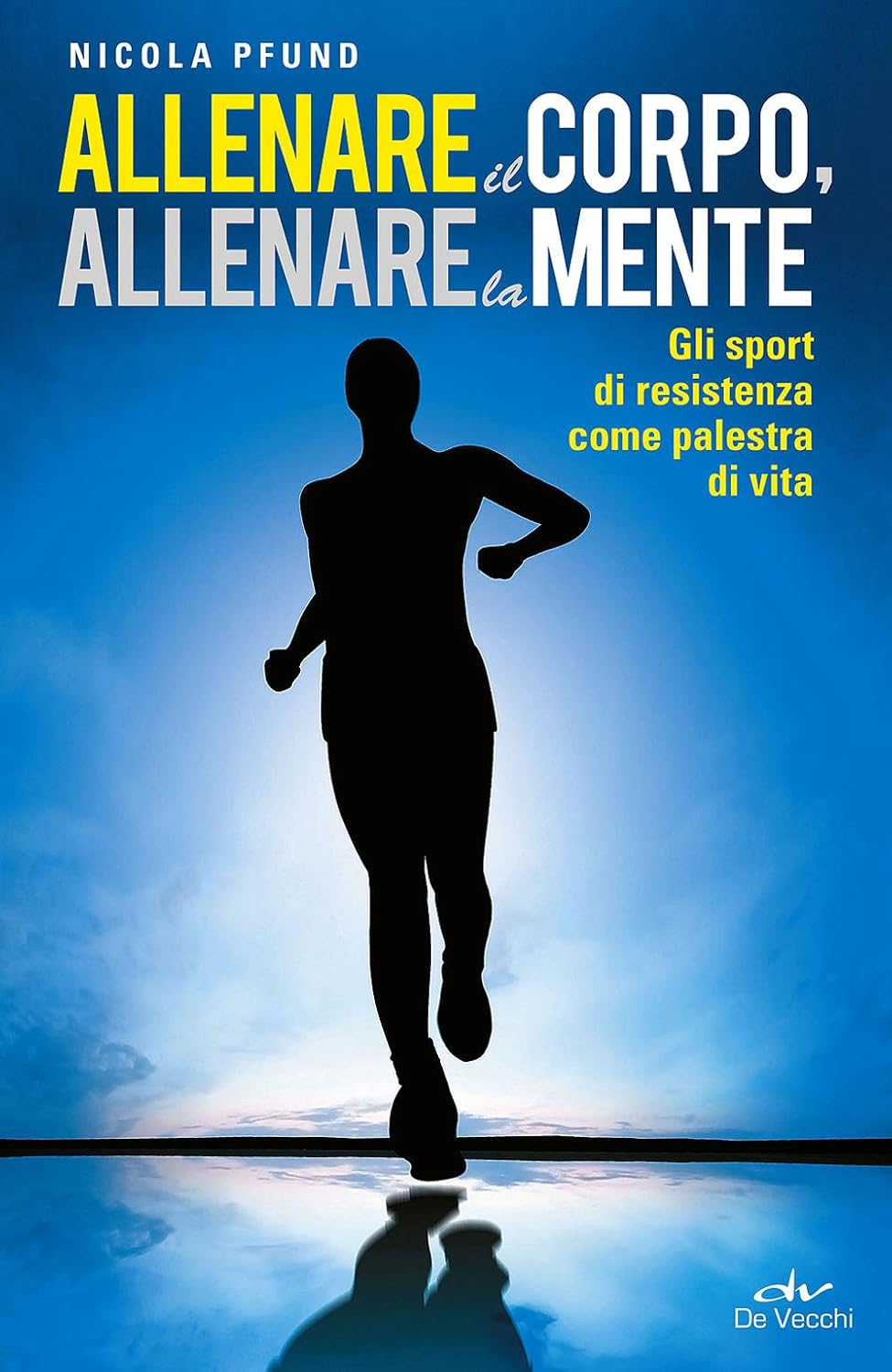






Commento all'articolo