Storia del teatro giapponese Dalle origini all’Ottocento – Bonaventura Ruperti
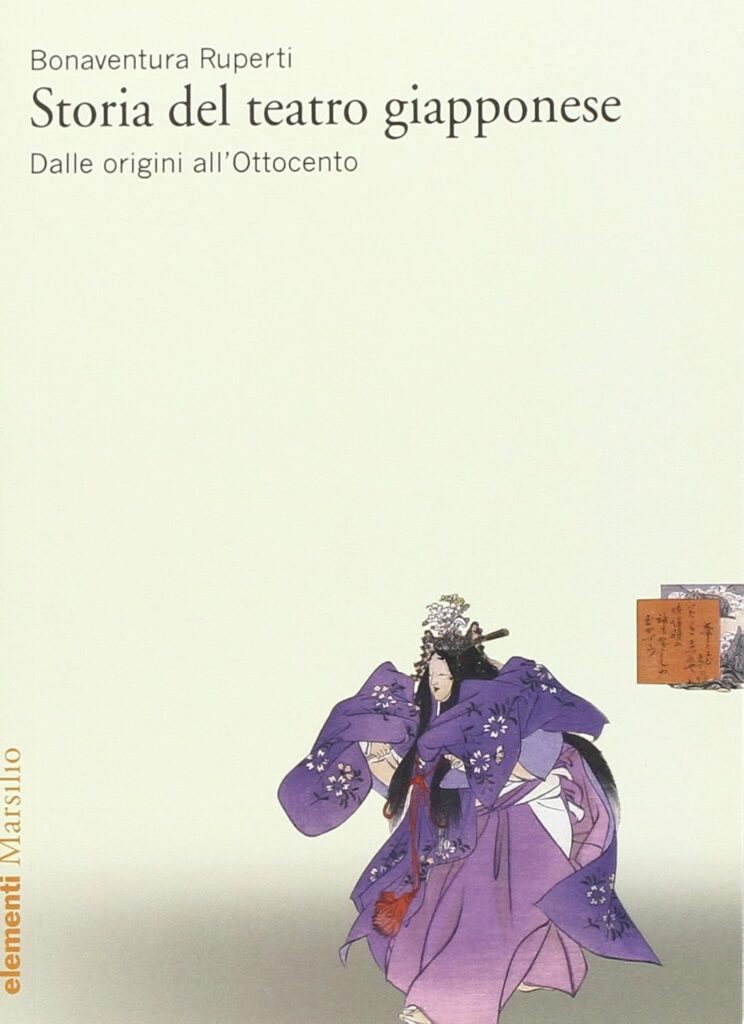
SINTESI DEL LIBRO:
Secondo la tradizione, ribadita anche nei trattati sul nō di Zeami, la
matrice originaria dello spettacolo risalirebbe al mito della caverna
(Ama no iwa[ya]to 天岩屋度) descritto nel Kojiki 古事記 (secolo VII),
mito secondo cui la dea solare Amaterasu ōmikami 天照大神, offesa
dal comportamento sacrilego del fratello Susanowo no mikoto スサ
ノオノミコト (素戔嗚尊), irruento signore dei venti, si sarebbe
rinchiusa in una caverna oscurando il mondo tra la disperazione
degli altri numi; grazie a un piano ideato dal dio Omoikane オモイカ
ネ (思金神), la dea Amenouzume アメノウズメ (天鈿女命) avrebbe
eseguito una danza su di una botte ribaltata, percuotendo i piedi e
denudandosi e tale rito di evocazione/spettacolo avrebbe suscitato le
risa delle divinità presenti e destato la curiosità di Amaterasu, che,
socchiudendo la caverna, attratta da uno specchio, sarebbe stata
afferrata saldamente per un braccio dal dio Amenotajikarawo アメノ
タヂカラヲ (天手力男神) e costretta a uscirne ponendo fine
all’eclissi1.
A questo mitico precedente e ad analoghi procedimenti magici di
richiamo di divinità risalirebbero i riti del kagura 神楽 e la nascita
della figura del wazaogi 俳優, ossia l’attore, figura intermedia tra dei
e uomini chiamata, attraverso trance, possessione, eccitazione e
invasamento, a evocare la divinità e a favorirne i benefici.
Il termine kagura si riferisce probabilmente alla «sede della divinità»
(kamikura 神座) – ma i sinogrammi 神楽 indicano in maniera
altrettanto pertinente «divertimento delle divinità» – ovvero un
oggetto, un luogo in cui si inviterebbe a risiedere il dio, tramite
procedimenti atti a attirarlo, accoglierlo, intrattenerlo: il canto e la
danza, movimenti circolari, il battito del piede, lo specchio, una
lancia, un ventaglio o altro. D’altro canto, anche il termine kamiasobi
神遊び, che vi si accosta spesso, ha dunque la valenza di
«divertimento degli dei», intrattenimento per gli dei e viene di norma
identificato o assimilato al kagura.
L’attore (in antico wazaogi 俳優) è dunque il tramite con le divinità e
gli spiriti, che vengono calamitati attraverso danza, canto, musica:
tramite il movimento circolare, rotatorio, gli spiriti sarebbero
richiamati a posarsi sul vertice di oggetti lunghi e appuntiti, arco di
catalpa per gli sciamani, su lance o spade, su rami di sakaki (la
pianta sacra agli dei, cleyera japonica) o bambù 、su ventagli o
altro, tenuti o fatti vorticare dall’attore danzatore.
L’etimo di waza è proprio di sortilegio/magia/anatema per far
manifestare la volontà della divinità, gli spiriti divini dotati di autorità e
potenza, mentre ogi è il sostantivo che deriva dalla voce verbale ogu
招ぐ ovvero «invitare», «richiamare», «condurrre».
La prima apparizione del termine sarebbe proprio nel Nihon shoki 日
本書紀, nell’età degli dei, laddove si riporta il mito su citato secondo
cui Amenouzume compie mirabilmente atti di evocazione. Il primo
sinogramma 俳,倡 e il secondo 優 insieme avrebbero entrambi il
significato di gi 戯 ossia gioco/scherzo/atto/azione e questi
sinogrammi sarebbero stati abbinati al termine autoctono wazaogi.
Probabilmente nel periodo della compilazione degli annali miticostorici, la tecnica/incantesimo per richiamare gli spiriti delle divinità
veniva considerato forse come un’espressione comica (kokkei 滑稽),
uno scherzo folle quale è il teatro, come manifesterebbe anche la
reazione della risata fragorosa dei numi al denudamento di
Amenouzume.
L’attore che appare sin dalle prime attestazioni è dunque sciamano,
anzi per la precisione è una figura femminile che svolge il ruolo di
sciamana, come sono e tuttora rimangono le miko nelle cerimonie
kagura. Ma se lo sciamanesimo in Giappone, a differenza di quello
continentale, propende meno verso il “viaggio mistico” di ascesa, per
l’incontro con la divinità, il raggiungimento di stati di estasi, e
piuttosto invece verso l’invito alla divinità a discendere, a
impadronirsi del tramite e parlare attraverso di esso, portare la sua
energia, sin dall’antichità il ruolo prevalente di mediatore tra esseri
umani, spiriti e divinità, ctonie più che uranie, con entità
soprannaturali, anime dei defunti, rimane affidato alle donne. È alla
donna, capace di dare la vita, che va anche la prerogativa di
svolgere la funzione primaria e vitale nei rituali che garantiscono
l’equilibrio del cosmo, la fertilità e la protezione della comunità2.
D’altro canto in epoca successiva avviene un trasferimento di tali
poteri sciamanici, ora taumaturgici più che divinatori, anche su figure
maschili, che, oltre a pratiche di meditazione e opportune discipline
ascetiche, ricorrono ad altri stratagemmi/strumenti/artifici per
raggiungere il loro scopo: oltre agli oggetti (torimono 採り物) o l’arco
di catalpa, impiegati dalle sciamane, essi ricorrono all’uso della
maschera, pratiche magico-ascetiche, formule magiche di scongiuro
ma sempre con canto e danza come elementi portanti e irrinunciabili.
Prima dell’affermazione della figura del tennō 天皇 (sovrano celeste,
non è chiaro quando questa lettura sino-giapponese sia venuta a
prevalere su quella autoctona sumeramikoto o altre) ossia, con
termine trasposto dalla Cina, colui che in Giappone viene designato
come “imperatore”, talora i sovrani stessi sembravano assommare in
sé tali poteri di sacerdoti. Le più antiche attestazioni in Giappone del
termine tennō risalgono al VII secolo, quando, subentrando al
termine ōkimi (grande re) che si riferiva ai sovrani di ciascuna
regione, viene a designare una figura la cui autorità politica e
religiosa si pone al di sopra dei sovrani di potentati locali per divenire
poi capo supremo e unico nel processo di centralizzazione e di
egemonia della regione di Yamato (o comunque del clan dominante)
rispetto ad altre forze e aree del paese. Di fatto, non monarca unico
e assoluto, anche quando si viene a formare un potere centrale
unitario e forte egli governa per una riconosciuta autorità religiosa
tramite la cerchia familiare e della nobiltà a lui legata e la sua
designazione non sembra avvenuta sempre in maniera ereditaria
lineare. Attraverso i testi di cronaca annalistica e mitologica Kojiki e
Nihonshoki agli inizi del secolo VIII ne avviene la legittimazione e la
teorizzazione della sua discendenza dalla divinità solare
progenitrice. Tale processo di fatto recepisce ed eredita, portandole
al culmine ideologico, valenze che già dal III secolo emergono in
figure come la regina Himiko, in cui la potenza materiale si
accompagnava a poteri magico-rituali di sciamano, sacerdote,
vaticinatore, medium, tramite con la divinità, per giungere a un
progressivo elevamento e allontanamento dal popolo comune, e alla
sua legittimazione tramite i miti ma anche le armi e i paraphernalia
del potere (sacri tesori shanshu no shingi 三種の神器: lo specchio, il
gioiello, la spada) che però via via passano come il potere politico
effettivo agli uomini, con un progressivo slittamento dalla
matrilinearità alla patrilinearità.
KAGURA: MUSICA E DANZA DIVERTIMENTO DEGLI DEI
Oggi si tramandano due tipi di kagura: mikagura 御神楽, che
comprendono le cerimonie investite di particolare prestigio
accompagnate da danza e musica tuttora eseguite al palazzo
imperiale, al massimo santuario di Ise o altro sacrario, in particolari
occasioni ufficiali, compresi i complessi rituali per l’incoronazione
imperiale; satokagura 里神楽, ossia gli spettacoli/celebrazioni che
avvengono in varie parti del paese in congiunzione con antichi
santuari o luoghi di culto in occasione di riti stagionali, legati al ciclo
agricolo, ai culti locali. Si circoscrivono dunque con il termine kagura
le forme performative che si eseguono in occasioni di festività per
placare e far posare (chinkon 鎮魂) o richiamare spiriti/divinità
(shōkon 招魂). Esse prevedono in primo luogo la preparazione del
kamikura (ricettacolo), l’invocazione degli spiriti/numi, e il trascorrere
l’intera notte fino all’alba in presenza delle divinità eseguendo riti e
pratiche per la pacificazione delle anime, il chinkon. Come esprime il
senso etimologico del termine, la prima funzione è di accogliere la
divinità ma a tal fine si rende necessaria la purificazione del
ricettacolo della divinità, del luogo della celebrazione, e per
purificazione ed evocazione si ricorre alle arti performative, la
musica, il canto, la danza. Il richiamo di spiriti e divinità in genere ha
il ruolo di catalizzarne l’energia, di calamitarne le forze, di
propiziarne i benefici. In tale contesto la musica, il canto e la danza
nel kagura hanno anche il valore di intrattenimento degli dei: nel
mikagura con rito durante la notte, le divinità vengono invitate a
sostare e accolte con offerte di cibo e bevande, e intrattenute con
canto danza e musica fino all’alba. Anche nell’intrattenimento e nel
banchetto sono dunque previste esecuzioni così come per
raffigurare la manifestazione della divinità, l’epifania, si ricorreva a
una forma d’arte rappresentativa. E da questa funzione primaria e
originaria del rituale per pacificare e richiamare le anime/gli spiriti,
prendono via via spazio gli elementi di arti performative che vengono
apprezzate dagli astanti/partecipanti contribuendo alla diffusione di
queste nelle diverse aree del paese. Anche nelle attestazioni storico-
letterarie le prime forme stilizzate di kamigakari 神懸かり
(possessione divina) sono le danze di miko, sacerdotesse-medium
tramite con le divinità, ossia le prime forme di miko kagura, che
risalgono al già citato mito della danza di Amenouzume. Il mikagura
che oggi avviene a corte nel mese di dicembre presso il
Kashikodokoro (il padiglione dove è collocato lo specchio sacro della
divinità Amaterasu ōmikami) all’interno dell’Unmeiden3, si ritiene
tramandi la forma dei kagura che avvenivano in ambito religiosopopolare a livello locale, presso le grandi sedi cultuali shintō 神道
distribuite nel territorio, e anche i vari eventi del chinkonsai all’interno
della corte, i kagura nelle festività dedicate alle divinità Sono e
Kara4, che grande rilievo ebbero in epoca Heian, il Kinka shin’en 琴
歌神宴 (sacro convito di canti e musica del koto) che dall’antichità si
teneva nel Seishodō e la cui prima attestazione lo colloca dopo il
Daijōe dell’imperatore Seiwa nel 8595. Queste sono dunque le
matrici delle cerimonie di mikagura, che sarebbero state inaugurate
nel 1002, e sono centrate sul canto vocale e una danza molto scarna
e che, oltre alla corte, sono state tramandate solo in grandi santuari,
Iwashimizu Hachimangū, i santuari Kamo a Kyōto e pochi altri.
D’altro canto, i riti kagura che erano diffusi a livello locale nel periodo
medievale vengono a essere rielaborati e riformulati per mano di
religiosi di basso grado, asceti (shugensha), asceti delle montagne
(yamabushi 山伏) i quali vi congiunsero riti di purificazione con
yudate (bollitura dell’acqua)6, danze con oggetti (torimono) di
richiamo delle divinità e invasamento, danze degli dei come nel
sarugaku nō: tutti rituali che precedevano il loro ingresso nel
profondo delle montagne e che pullularono in vari luoghi del paese.
A seconda delle fedi e delle scuole di appartenenza, della natura dei
gruppi religiosi che furono le cellule di dispersione di questi riti in
tutto il paese, gli atti performativi nella sostanza non mutano anche
se muta il modo di proporli, la combinazione o l’ordine. E le forme
disseminate a livello locale, satokagura, nel tramandare il genius
loci, colore e tradizioni locali, attraverso le metamorfosi delle storie
del territorio sono giunte fino a oggi come arti folcloriche
trasmettendoci nei modi esecutivi immagini viventi dell’epoca
medievale e, in base alle differenze sopra descritte, si distinguono le
seguenti: miko kagura, i kagura di Izumo, i kagura di Ise e i kagura
con shishi.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :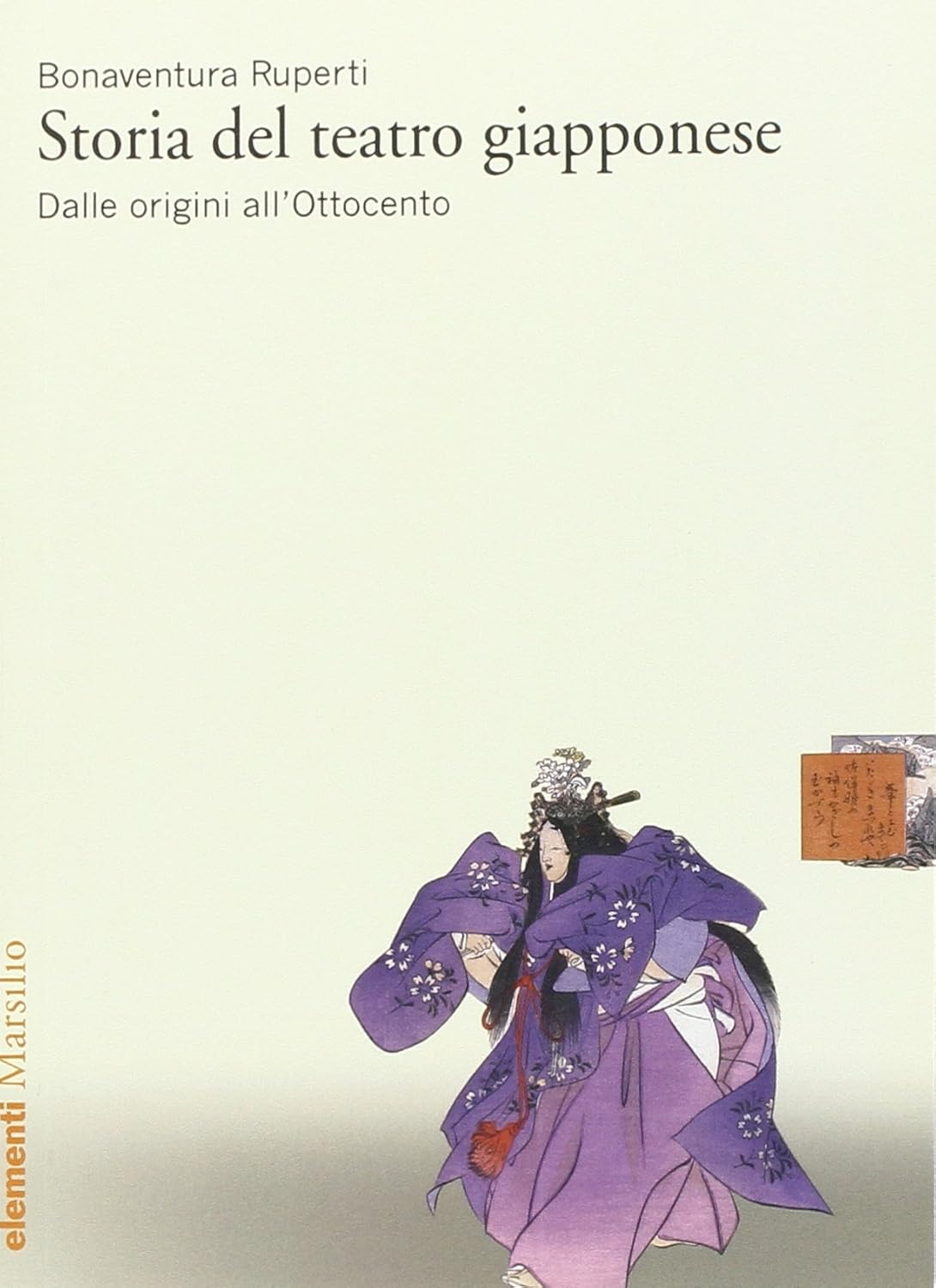






Commento all'articolo